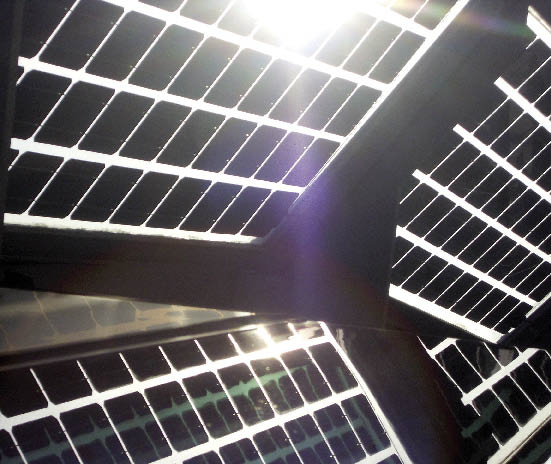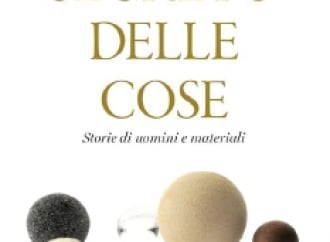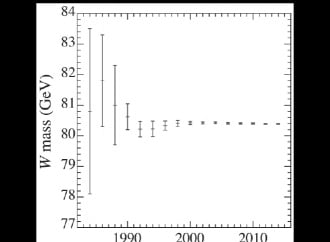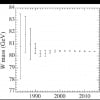"Effetto fotoelettrico". Due parole da wikipedia, molto diffuse. Fanno pensare, per lo più, a quei marchingegni che ci aprono (o chiudono) le sbarre di accesso ai parcheggi privati. Oppure a pannelli (non molti, per la verità) che ricoprono tetti e terreni per recuperare un po' di preziosa energia solare. Forse non tutti sanno, però, che dietro queste tecnologie vi è uno splendido capitolo della ricerca e dei fondamenti della fisica, uno di quelli che hanno scosso il mondo ormai più di cent'anni fa.
"Fotoelettricità" è chiaramente basato su due termini famigliari, "luce" e, naturalmente, "elettricità": cosa c'entrano fra di loro? Non è presto spiegato, almeno se si vuole entrare un po' nel merito e nei dettagli della questione.
Un po' di storia: durante il diciannovesimo secolo, molti furono gli studiosi che si occuparono di fenomeni che evidenziavano un qualche tipo di causa-effetto fra l'illuminamento di certi materiali, metallici in particolare, e la loro elettrizzazione. Schuster e Hertz osservavano che irraggiando con luce ultravioletta dei conduttori questi producevano delle scintille anche intense. L'italiano Righi stabiliva sperimentalmente che il metallo illuminato si caricava positivamente, ovvero, per esclusione, che esso doveva cedere delle cariche di segno negativo. Alla fine del 1800 era J.J. Thomson a scoprire che queste cariche negative erano proprio elettroni, ovvero le particelle che fanno parte integrante di tutti gli atomi di cui siamo composti. E, pochi anni dopo, Lenard capiva che la luce necessaria per provocare l'emissione di queste cariche dal metallo da essa illuminato doveva avere una frequenza di vibrazione minima, di soglia, sotto la quale, per quanto ci si desse da fare, nulla accadeva di interessante.
Se non fosse ancora chiaro: in qualche modo la luce che investe il metallo gli conferisce un chissà che cosa di energetico che consente alle cariche negative (elettroni) del metallo stesso di allontanarsi da esso e, in determinate condizioni, di produrre una corrente (elettrica, per l'appunto). Insomma, un modo di trasformare due diverse forme di energia: quella luminosa in quella elettrica. Un fenomeno molto interessante e, a posteriori, altrettanto utile.
Perché parlarne? Beh, per un motivo semplice: alla fine del 1800, quando per l'appunto tutte queste misure venivano portate a termine, vi erano delle spiegazioni teoriche basate su quanto i fisici del tempo avevano a disposizione, e che non era poco: proprio in quei decenni, lo scienziato scozzese James Maxwell aveva terminato un portentoso lavoro che gli permetteva di descrivere tutti (ma proprio tutti) i fenomeni elettromagnetici allora noti in termini di quattro splendide equazioni (non stenterete a credere che si chiamino ancora "equazioni di Maxwell"). Questi oggetti matematici, piuttosto complicati ma efficacissimi in termini di potere predittivo e descrittivo, erano quanto di meglio si potesse volere da una teoria fisica. In quegli anni, oltretutto, la fisica faceva incredibili progressi anche nello studio dei gas (la termodinamica e la meccanica statistica venivano inventate proprio allora). Questi risultati avevano condotto a decretare la fine delle scienze fisiche, nel senso almeno della possibilità di fare nuove scoperte. Per i fisici del tempo (come per molti di oggi, ahimè) la cassa integrazione era uno spettro concreto: non c'era più nulla da fare se non qualche conticino per far tornare i numeri con sufficiente dettaglio. Ma tutto era stato capito.
Quasi tutto. Se si prova ad applicare la teoria elettromagnetica di Maxwell al fenomeno di cui ci stiamo interessando, l'effetto fotoelettrico, si riescono a fare delle predizioni come minimo inquietanti.
Anzitutto: certo che ci aspetta l'effetto fotoelettrico, visto che Maxwell aveva capito che la luce altro non è che una particolare forma di energia, trasportata da una combinazione affascinante di campi elettrici e magnetici oscillanti (milioni di miliardi di volte al secondo, nel caso della luce visibile) e viaggiante nel vuoto alla velocità ... della luce (e che altro?). Onda viaggiante dunque è energia viaggiante. Ecco che se questa investe il metallo sul quale vogliamo fare il nostro esperimento, e se l'energia è sufficiente, è come se avessimo preso a frustate le particelle imprigionate nel metallo (da qualche parte, se poi le vediamo uscire, dovevano pure essere!): frustate tali appunto da liberarle e da permetterne l'osservazione e la misura. Tutto bene, dunque? No. Le onde elettromagnetiche di Maxwell (che davvero ci sono) hanno un'energia che dipende da quanto "ampie" sono le oscillazioni dei campi elettrici e magnetici che le costituiscono. Un po' come mettere in moto con maggiore ampiezza la frusta: frustata più decisa, schiocco maggiore, effetto assicurato. Però, facendo l'esperimento per davvero, come accennato poche righe fa, l'effetto fotoelettrico avviene solo se la frequenza di oscillazione della luce che investe il metallo è abbastanza elevata. Non dipende invece per nulla dall'ampiezza dell'oscillazione dell'onda. L'ampiezza ovviamente qualcosa fa: una frustata più decisa provoca un fiotto di elettroni dal metallo più denso, ovvero - come correttamente si dice anche - una corrente elettrica maggiore. Ma, e questo è il punto, al variare dell'ampiezza dell'onda non si conferisce maggiore o minore energia a queste particelle cariche. Inoltre, ripetiamo, al variare della frequenza dell'onda si può decidere se l'effetto fotoelettrico ci sarà o meno. Avete capito bene: per quanto ampia sia la frustata dell'onda, se questa non vibra abbastanza rapidamente, nessun elettrone (ma proprio nessuno) uscirà dal metallo. Non è tutto. Siccome ci si aspetta che gli elettroni siano molto piccoli (insomma, entro le dimensioni di un atomo, miliardesimi di metro o meno), e la luce investe un'area relativamente grande del metallo, il suo effetto in termini di espulsione di elettroni impiegherà vari secondi per manifestarsi. Questo ci si aspetterebbe in teoria. In pratica? L'avete immaginato: accendete la luce e l'effetto fotoelettrico parte pressoché istantaneamente.
Insomma, le equazioni di Maxwell non ne indovinano una, almeno in questo particolare (ma non certo esoterico o complicato) esperimento.
Dunque? Bisogna aspettare il 1905, anno nel quale Albert Einstein pubblica vari lavori, fra i quali i più famosi sono dedicati allo studio del moto browniano (grani di polline che sembrano animati di vita propria, ma la colpa è degli atomi che li prendono a calci), al comportamento di oggetti animati di velocità confrontabili con quella della luce (già, proprio la teoria della relatività, "ristretta" in questo caso), e un terzo articolo nel quale si discute infine dell'effetto fotoelettrico e dei problemi sopra elencati.
Einstein era motivato a introdurre una spiegazione decisamente rivoluzionaria di questo fenomeno, sull'onda di un lavoro che pochi anni prima (nel 1900) il fisico tedesco Max Planck aveva reso noto per spiegare la natura della radiazione elettromagnetica emessa da un corpo a una certa temperatura (radiazione del "corpo nero" - da non confondersi con un buco nero). La rivoluzione era da riferire al modo in cui si intendeva descrivere lo scambio dell'energia che necessariamente avviene fra radiazione elettromagnetica e cariche del metallo nell'effetto fotoelettrico. Le onde di Maxwell c'erano e ci sono, però quando esse incontrano gli elettroni nel metallo, l'energia viene ceduta a questi in modo "discreto", "a pacchetti" o, come anche si dice di solito, per tramite di "quanti" (che un po' dopo sarebbero stati battezzati "fotoni" da Lewis). Ogni quanto di radiazione ha energia che dipende molto semplicemente dalla frequenza dell'onda che esso rappresenta. Questo modo bizzarro di comportarsi della radiazione, che prende a calci "singoli" invece che a frustate "continue" i suoi bersagli, è esattamente quanto serve per capire tutte le caratteristiche quantitative dell'effetto fotoelettrico: luce intensa significa tanti fotoni che scalzano altrettanti elettroni, dunque grande corrente; la luce dev'essere "abbastanza ultravioletta" perché essa ha elevata frequenza e dunque energia per accelerare gli elettroni scalzati dal metallo. E questi partono subito, e non dopo qualche secondo, perché il calcio che ricevono dai fotoni è come quello di una partita a pallone, istantaneo (o quasi).
Una teoria rivoluzionaria per spiegare un fenomeno abbastanza ordinario, come già detto. Che la teoria fosse straordinaria lo spiegano anche due fatti che non tutti conoscono: Einstein fu insignito del premio Nobel per la fisica del 1921 "per i suoi servizi alla fisica teorica, e in particolare per la sua scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico" (non per la relatività, che pure era stata pubblicata nel 1905); il medesimo premio lo scienziato statunitense Robert Millikan lo avrebbe vinto nel 1923 per i suoi lavori sperimentali volti a confermare la teoria di Einstein con notevolissima precisione. A dirla tutta, lui, con le sue misure, avrebbe desiderato demolirla questa teoria ... per sua fortuna, tutto sommato, non è poi andata così.
"Fotoelettricità" è chiaramente basato su due termini famigliari, "luce" e, naturalmente, "elettricità": cosa c'entrano fra di loro? Non è presto spiegato, almeno se si vuole entrare un po' nel merito e nei dettagli della questione.
Un po' di storia: durante il diciannovesimo secolo, molti furono gli studiosi che si occuparono di fenomeni che evidenziavano un qualche tipo di causa-effetto fra l'illuminamento di certi materiali, metallici in particolare, e la loro elettrizzazione. Schuster e Hertz osservavano che irraggiando con luce ultravioletta dei conduttori questi producevano delle scintille anche intense. L'italiano Righi stabiliva sperimentalmente che il metallo illuminato si caricava positivamente, ovvero, per esclusione, che esso doveva cedere delle cariche di segno negativo. Alla fine del 1800 era J.J. Thomson a scoprire che queste cariche negative erano proprio elettroni, ovvero le particelle che fanno parte integrante di tutti gli atomi di cui siamo composti. E, pochi anni dopo, Lenard capiva che la luce necessaria per provocare l'emissione di queste cariche dal metallo da essa illuminato doveva avere una frequenza di vibrazione minima, di soglia, sotto la quale, per quanto ci si desse da fare, nulla accadeva di interessante.
Se non fosse ancora chiaro: in qualche modo la luce che investe il metallo gli conferisce un chissà che cosa di energetico che consente alle cariche negative (elettroni) del metallo stesso di allontanarsi da esso e, in determinate condizioni, di produrre una corrente (elettrica, per l'appunto). Insomma, un modo di trasformare due diverse forme di energia: quella luminosa in quella elettrica. Un fenomeno molto interessante e, a posteriori, altrettanto utile.
Perché parlarne? Beh, per un motivo semplice: alla fine del 1800, quando per l'appunto tutte queste misure venivano portate a termine, vi erano delle spiegazioni teoriche basate su quanto i fisici del tempo avevano a disposizione, e che non era poco: proprio in quei decenni, lo scienziato scozzese James Maxwell aveva terminato un portentoso lavoro che gli permetteva di descrivere tutti (ma proprio tutti) i fenomeni elettromagnetici allora noti in termini di quattro splendide equazioni (non stenterete a credere che si chiamino ancora "equazioni di Maxwell"). Questi oggetti matematici, piuttosto complicati ma efficacissimi in termini di potere predittivo e descrittivo, erano quanto di meglio si potesse volere da una teoria fisica. In quegli anni, oltretutto, la fisica faceva incredibili progressi anche nello studio dei gas (la termodinamica e la meccanica statistica venivano inventate proprio allora). Questi risultati avevano condotto a decretare la fine delle scienze fisiche, nel senso almeno della possibilità di fare nuove scoperte. Per i fisici del tempo (come per molti di oggi, ahimè) la cassa integrazione era uno spettro concreto: non c'era più nulla da fare se non qualche conticino per far tornare i numeri con sufficiente dettaglio. Ma tutto era stato capito.
Quasi tutto. Se si prova ad applicare la teoria elettromagnetica di Maxwell al fenomeno di cui ci stiamo interessando, l'effetto fotoelettrico, si riescono a fare delle predizioni come minimo inquietanti.
Anzitutto: certo che ci aspetta l'effetto fotoelettrico, visto che Maxwell aveva capito che la luce altro non è che una particolare forma di energia, trasportata da una combinazione affascinante di campi elettrici e magnetici oscillanti (milioni di miliardi di volte al secondo, nel caso della luce visibile) e viaggiante nel vuoto alla velocità ... della luce (e che altro?). Onda viaggiante dunque è energia viaggiante. Ecco che se questa investe il metallo sul quale vogliamo fare il nostro esperimento, e se l'energia è sufficiente, è come se avessimo preso a frustate le particelle imprigionate nel metallo (da qualche parte, se poi le vediamo uscire, dovevano pure essere!): frustate tali appunto da liberarle e da permetterne l'osservazione e la misura. Tutto bene, dunque? No. Le onde elettromagnetiche di Maxwell (che davvero ci sono) hanno un'energia che dipende da quanto "ampie" sono le oscillazioni dei campi elettrici e magnetici che le costituiscono. Un po' come mettere in moto con maggiore ampiezza la frusta: frustata più decisa, schiocco maggiore, effetto assicurato. Però, facendo l'esperimento per davvero, come accennato poche righe fa, l'effetto fotoelettrico avviene solo se la frequenza di oscillazione della luce che investe il metallo è abbastanza elevata. Non dipende invece per nulla dall'ampiezza dell'oscillazione dell'onda. L'ampiezza ovviamente qualcosa fa: una frustata più decisa provoca un fiotto di elettroni dal metallo più denso, ovvero - come correttamente si dice anche - una corrente elettrica maggiore. Ma, e questo è il punto, al variare dell'ampiezza dell'onda non si conferisce maggiore o minore energia a queste particelle cariche. Inoltre, ripetiamo, al variare della frequenza dell'onda si può decidere se l'effetto fotoelettrico ci sarà o meno. Avete capito bene: per quanto ampia sia la frustata dell'onda, se questa non vibra abbastanza rapidamente, nessun elettrone (ma proprio nessuno) uscirà dal metallo. Non è tutto. Siccome ci si aspetta che gli elettroni siano molto piccoli (insomma, entro le dimensioni di un atomo, miliardesimi di metro o meno), e la luce investe un'area relativamente grande del metallo, il suo effetto in termini di espulsione di elettroni impiegherà vari secondi per manifestarsi. Questo ci si aspetterebbe in teoria. In pratica? L'avete immaginato: accendete la luce e l'effetto fotoelettrico parte pressoché istantaneamente.
Insomma, le equazioni di Maxwell non ne indovinano una, almeno in questo particolare (ma non certo esoterico o complicato) esperimento.
Dunque? Bisogna aspettare il 1905, anno nel quale Albert Einstein pubblica vari lavori, fra i quali i più famosi sono dedicati allo studio del moto browniano (grani di polline che sembrano animati di vita propria, ma la colpa è degli atomi che li prendono a calci), al comportamento di oggetti animati di velocità confrontabili con quella della luce (già, proprio la teoria della relatività, "ristretta" in questo caso), e un terzo articolo nel quale si discute infine dell'effetto fotoelettrico e dei problemi sopra elencati.
Einstein era motivato a introdurre una spiegazione decisamente rivoluzionaria di questo fenomeno, sull'onda di un lavoro che pochi anni prima (nel 1900) il fisico tedesco Max Planck aveva reso noto per spiegare la natura della radiazione elettromagnetica emessa da un corpo a una certa temperatura (radiazione del "corpo nero" - da non confondersi con un buco nero). La rivoluzione era da riferire al modo in cui si intendeva descrivere lo scambio dell'energia che necessariamente avviene fra radiazione elettromagnetica e cariche del metallo nell'effetto fotoelettrico. Le onde di Maxwell c'erano e ci sono, però quando esse incontrano gli elettroni nel metallo, l'energia viene ceduta a questi in modo "discreto", "a pacchetti" o, come anche si dice di solito, per tramite di "quanti" (che un po' dopo sarebbero stati battezzati "fotoni" da Lewis). Ogni quanto di radiazione ha energia che dipende molto semplicemente dalla frequenza dell'onda che esso rappresenta. Questo modo bizzarro di comportarsi della radiazione, che prende a calci "singoli" invece che a frustate "continue" i suoi bersagli, è esattamente quanto serve per capire tutte le caratteristiche quantitative dell'effetto fotoelettrico: luce intensa significa tanti fotoni che scalzano altrettanti elettroni, dunque grande corrente; la luce dev'essere "abbastanza ultravioletta" perché essa ha elevata frequenza e dunque energia per accelerare gli elettroni scalzati dal metallo. E questi partono subito, e non dopo qualche secondo, perché il calcio che ricevono dai fotoni è come quello di una partita a pallone, istantaneo (o quasi).
Una teoria rivoluzionaria per spiegare un fenomeno abbastanza ordinario, come già detto. Che la teoria fosse straordinaria lo spiegano anche due fatti che non tutti conoscono: Einstein fu insignito del premio Nobel per la fisica del 1921 "per i suoi servizi alla fisica teorica, e in particolare per la sua scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico" (non per la relatività, che pure era stata pubblicata nel 1905); il medesimo premio lo scienziato statunitense Robert Millikan lo avrebbe vinto nel 1923 per i suoi lavori sperimentali volti a confermare la teoria di Einstein con notevolissima precisione. A dirla tutta, lui, con le sue misure, avrebbe desiderato demolirla questa teoria ... per sua fortuna, tutto sommato, non è poi andata così.