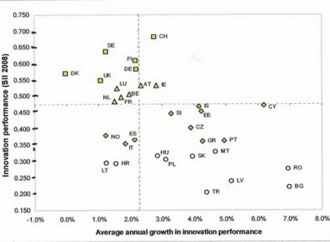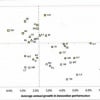Questo articolo è stato scritto a quattro mani con Simone Melis, dottorando in scienze cognitive, Università di Barcellona.
Il Covid-19 è stato un banco di prova per la preparazione scientifica dei nostri politici e i risultati sono stati sconcertanti: ministri che pretendono dalla scienza le “certezze inconfutabili” che non può dare, o che non credono ai vaccini e lamentano la mancanza di un misterioso ”onere della prova inversa”: indipendentemente dagli schieramenti, il Covid-19 è uno dei tanti settori dove la classe politica mostra la sua impreparazione in materia di scienza, con tutte le conseguenze del caso.
Una tentazione potrebbe allora essere la cosiddetta tecnocrazia. Di che cosa si tratta? Secondo Jean Meynaud la tecnocrazia è «l'ascesa al potere di coloro che possiedono conoscenze o abilità tecniche, a scapito del tipo tradizionale di politico». L’idea di fondo è molto intuitiva: i cittadini comuni sono troppo limitati dalle loro conoscenze e dai loro interessi e quindi incapaci di prendere le decisioni più appropriate, mentre esperti non eletti dal popolo ma scelti in virtù della loro competenza sarebbero in grado di perseguire più efficacemente dei politici tradizionali il bene comune in quanto lontani dalle pressioni elettorali. Ma questa visione apparentemente ragionevole nasconde alcune gravi insidie. Cerchiamo di esaminarne qualcuna.
La tecnocrazia è una dottrina molto attraente, sostenuta trasversalmente da pensatori molto diversi, che oggi definiremmo conservatori e progressisti. Il successo di questa ideologia è stato via via crescente tra illuminismo e positivismo, ma sono idee presenti anche nella società contemporanea. Pensiamo al concetto di “governo tecnico”: il tentativo di “depoliticizzare” per ragioni di efficienza il processo decisionale e delegarlo a soggetti neutrali e super partes che grazie alle loro conoscenze specialistiche sarebbero in grado di prendere le decisioni migliori. Inoltre, istituzioni sostanzialmente tecnocratiche, poco soggette al controllo degli elettori ma detentrici di un grande potere e capaci di influenzare i governi, sono presenti un po’ in ogni sistema politico: per fare solo due esempi, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea.
Nella realtà quindi non abbiamo una dicotomia tra democrazia e tecnocrazia ma più spesso una forma ibrida tra i due sistemi. Il fatto che la tecnocrazia non sia rimasta un modello teorico ma sia stata ampiamente sperimentata, sia pure in coabitazione con altre forme di governo, ci permette di valutarne anche empiricamente vantaggi e svantaggi. Chi la sostiene lo fa in genere per due ragioni distinte e complementari: la prima riguarda gli esperti stessi, ritenuti in grado di prendere le decisioni migliori; la seconda concerne i sistemi di natura tecnocratica, reputati meno permeabili da corruzione e illegalità. Ciascuna di queste ragioni si dissolve però a un’analisi più attenta.
Se ci concentriamo sulla presunta capacità ottimale di scelta degli esperti, possiamo subito fare una precisazione: anche ammesso che la competenza sia il sommo criterio per delegare le nostre scelte comunitarie, molte scelte operate dalle istituzioni democratiche non rientrano affatto nell’ambito tecnico-scientifico, in cui gli esperti sono più competenti; spesso si tratta piuttosto di scelte valoriali o pragmatiche. Tornando ancora una volta al recente periodo pandemico, ricordiamo tutti i dibattiti sui media, anche e spesso tra scienziati, aventi almeno sulla carta le stesse competenze e conoscenze, eppure profondamente divisi su scelte di natura pratica: greenpass sì o no, lockdown sì o no, e così via. Non è difficile intuire che le differenze erano di natura valoriale: per qualcuno le libertà individuali erano più importanti di un certo livello minimale di sicurezza collettiva e viceversa. Si deve tenere a mente, pertanto, che fatti e valori stanno su piani diversi, complementari ma indipendenti: per le scelte più complesse spesso non basta la conoscenza dei primi.
Se approfondiamo l’esame “antropologico” del tecnocrate, emergono ulteriori problemi: qualunque essere umano, per competente che sia, è affetto da considerevoli limiti cognitivi. Soprattutto in ambito decisionale, gli studi che mostrano bias e tendenze all’errore sono molto ben documentati, spesso proprio su persone ritenute massimamente competenti. Daniel Kahneman, psicologo e fondatore dell’economia comportamentale, ha studiato per anni i processi decisionali di esperti nell’area finanziaria, ritrovandovi gli stessi limiti delle persone comuni, talvolta persino più pronunciati: in breve, un’eccessiva fiducia in sé stessi e l’illusione di saper padroneggiare tutte le variabili in gioco possono portare più spesso fuori strada gli esperti che le persone comuni. Anche in questo caso, bisogna tenere concettualmente separata la disponibilità di buoni dati di partenza (di cui gli esperti sono senza dubbio ottimi custodi) dalla capacità di trarre in modo efficace conclusioni corrette, utili e pertinenti (un diverso genere di capacità di cui nessuno è “proprietario” esclusivo). Detto in uno slogan, competenza non è sinonimo di razionalità ed è difficile considerare i tecnocrati come le persone più adatte a priori a prendere qualunque tipo di decisione.
Le cose non vanno meglio se guardiamo al secondo genere di ragioni a favore della tecnocrazia. Alcuni studiosi sostengono che i rischi di scelte irrazionali aumentano laddove vi siano gruppi ristretti e omogenei, come quelli degli specialisti, rispetto a comunità più ampie e democratiche. Per esempio, commentando la crisi dell'Eurozona, Matthias Matthijs e Mark Blyth sostengono che «poiché non ci sono controlli democratici diretti sulle loro politiche, le élite tecnocratiche sono incentivate a scegliere politiche che le isolano dalle critiche (politicamente razionali) mentre riproducono politiche economiche che sono subottimali (economicamente irrazionali)». In altre parole, la mancanza di un feedback democratico non obbliga gli esperti a un confronto con informazioni alternative che potrebbero risultare migliorative. Ecco perché anche questo sostegno alla tecnocrazia collassa su sé stesso: essa tende a stabilire una forma di dominio da parte di una minoranza nei confronti dei comuni cittadini, impedendo a questi ultimi di metterne in discussione il potere e di contestare le decisioni che li danneggiano.
Ma c’è di più: le élite economiche più ricche e meglio organizzate sono in una posizione ottimale per influenzare le decisioni dei tecnocrati, attraverso think tank, fondazioni politiche, università private e altre organizzazioni. Possono infatti mascherare le politiche che le avvantaggiano a spese dei cittadini comuni con il linguaggio della neutralità tecnocratica, presentandole cioè come ciò che deve essere fatto, anziché come ciò che desidera un particolare gruppo di interesse: per esempio un sistema di tassazione che le favorisca a svantaggio della maggioranza della popolazione. In altre parole il ricorso alla tecnocrazia può diventare un pretesto per imporre decisioni di parte sottraendole al confronto democratico nel quale rischierebbero di essere sconfitte.
È bene essere il più chiari possibile su un punto finora sottinteso. Non si propone certo di ignorare le competenze degli esperti: nessuno più di noi del CICAP sa quanto oggi sia fondamentale consultare gli specialisti per affrontare i problemi e districarsi in un mondo dominato da informazione di scarsa qualità. Tuttavia, si deve evitare di farsi prendere dall’entusiasmo e mitizzare gli specialisti come adatti a risolvere ogni genere di problema.
Assegnare agli specialisti incarichi che garantiscono molto potere ma non impongono di risponderne ai cittadini produce più problemi di quanti ne risolva. Un sistema politico-istituzionale davvero razionale dovrebbe premiare gli sforzi e le competenze degli esperti istituendo uno scambio virtuoso di conoscenze laddove queste possono incidere positivamente. Al contempo, escludere dal processo decisionale (ancorché in forma rappresentativa) le classi meno scolarizzate e specializzate sarebbe, oltre che moralmente deprecabile, dannoso sul piano pratico. Molti studi affermano infatti che tutti i cittadini possono contribuire efficacemente all'identificazione e alla risoluzione dei problemi sociali. In definitiva, quindi, tecnica e competenza sì, tecnocrazia no.
Il Covid-19 è stato un banco di prova per la preparazione scientifica dei nostri politici e i risultati sono stati sconcertanti: ministri che pretendono dalla scienza le “certezze inconfutabili” che non può dare, o che non credono ai vaccini e lamentano la mancanza di un misterioso ”onere della prova inversa”: indipendentemente dagli schieramenti, il Covid-19 è uno dei tanti settori dove la classe politica mostra la sua impreparazione in materia di scienza, con tutte le conseguenze del caso.
Una tentazione potrebbe allora essere la cosiddetta tecnocrazia. Di che cosa si tratta? Secondo Jean Meynaud la tecnocrazia è «l'ascesa al potere di coloro che possiedono conoscenze o abilità tecniche, a scapito del tipo tradizionale di politico». L’idea di fondo è molto intuitiva: i cittadini comuni sono troppo limitati dalle loro conoscenze e dai loro interessi e quindi incapaci di prendere le decisioni più appropriate, mentre esperti non eletti dal popolo ma scelti in virtù della loro competenza sarebbero in grado di perseguire più efficacemente dei politici tradizionali il bene comune in quanto lontani dalle pressioni elettorali. Ma questa visione apparentemente ragionevole nasconde alcune gravi insidie. Cerchiamo di esaminarne qualcuna.
La tecnocrazia è una dottrina molto attraente, sostenuta trasversalmente da pensatori molto diversi, che oggi definiremmo conservatori e progressisti. Il successo di questa ideologia è stato via via crescente tra illuminismo e positivismo, ma sono idee presenti anche nella società contemporanea. Pensiamo al concetto di “governo tecnico”: il tentativo di “depoliticizzare” per ragioni di efficienza il processo decisionale e delegarlo a soggetti neutrali e super partes che grazie alle loro conoscenze specialistiche sarebbero in grado di prendere le decisioni migliori. Inoltre, istituzioni sostanzialmente tecnocratiche, poco soggette al controllo degli elettori ma detentrici di un grande potere e capaci di influenzare i governi, sono presenti un po’ in ogni sistema politico: per fare solo due esempi, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea.
Nella realtà quindi non abbiamo una dicotomia tra democrazia e tecnocrazia ma più spesso una forma ibrida tra i due sistemi. Il fatto che la tecnocrazia non sia rimasta un modello teorico ma sia stata ampiamente sperimentata, sia pure in coabitazione con altre forme di governo, ci permette di valutarne anche empiricamente vantaggi e svantaggi. Chi la sostiene lo fa in genere per due ragioni distinte e complementari: la prima riguarda gli esperti stessi, ritenuti in grado di prendere le decisioni migliori; la seconda concerne i sistemi di natura tecnocratica, reputati meno permeabili da corruzione e illegalità. Ciascuna di queste ragioni si dissolve però a un’analisi più attenta.
Se ci concentriamo sulla presunta capacità ottimale di scelta degli esperti, possiamo subito fare una precisazione: anche ammesso che la competenza sia il sommo criterio per delegare le nostre scelte comunitarie, molte scelte operate dalle istituzioni democratiche non rientrano affatto nell’ambito tecnico-scientifico, in cui gli esperti sono più competenti; spesso si tratta piuttosto di scelte valoriali o pragmatiche. Tornando ancora una volta al recente periodo pandemico, ricordiamo tutti i dibattiti sui media, anche e spesso tra scienziati, aventi almeno sulla carta le stesse competenze e conoscenze, eppure profondamente divisi su scelte di natura pratica: greenpass sì o no, lockdown sì o no, e così via. Non è difficile intuire che le differenze erano di natura valoriale: per qualcuno le libertà individuali erano più importanti di un certo livello minimale di sicurezza collettiva e viceversa. Si deve tenere a mente, pertanto, che fatti e valori stanno su piani diversi, complementari ma indipendenti: per le scelte più complesse spesso non basta la conoscenza dei primi.
Se approfondiamo l’esame “antropologico” del tecnocrate, emergono ulteriori problemi: qualunque essere umano, per competente che sia, è affetto da considerevoli limiti cognitivi. Soprattutto in ambito decisionale, gli studi che mostrano bias e tendenze all’errore sono molto ben documentati, spesso proprio su persone ritenute massimamente competenti. Daniel Kahneman, psicologo e fondatore dell’economia comportamentale, ha studiato per anni i processi decisionali di esperti nell’area finanziaria, ritrovandovi gli stessi limiti delle persone comuni, talvolta persino più pronunciati: in breve, un’eccessiva fiducia in sé stessi e l’illusione di saper padroneggiare tutte le variabili in gioco possono portare più spesso fuori strada gli esperti che le persone comuni. Anche in questo caso, bisogna tenere concettualmente separata la disponibilità di buoni dati di partenza (di cui gli esperti sono senza dubbio ottimi custodi) dalla capacità di trarre in modo efficace conclusioni corrette, utili e pertinenti (un diverso genere di capacità di cui nessuno è “proprietario” esclusivo). Detto in uno slogan, competenza non è sinonimo di razionalità ed è difficile considerare i tecnocrati come le persone più adatte a priori a prendere qualunque tipo di decisione.
Le cose non vanno meglio se guardiamo al secondo genere di ragioni a favore della tecnocrazia. Alcuni studiosi sostengono che i rischi di scelte irrazionali aumentano laddove vi siano gruppi ristretti e omogenei, come quelli degli specialisti, rispetto a comunità più ampie e democratiche. Per esempio, commentando la crisi dell'Eurozona, Matthias Matthijs e Mark Blyth sostengono che «poiché non ci sono controlli democratici diretti sulle loro politiche, le élite tecnocratiche sono incentivate a scegliere politiche che le isolano dalle critiche (politicamente razionali) mentre riproducono politiche economiche che sono subottimali (economicamente irrazionali)». In altre parole, la mancanza di un feedback democratico non obbliga gli esperti a un confronto con informazioni alternative che potrebbero risultare migliorative. Ecco perché anche questo sostegno alla tecnocrazia collassa su sé stesso: essa tende a stabilire una forma di dominio da parte di una minoranza nei confronti dei comuni cittadini, impedendo a questi ultimi di metterne in discussione il potere e di contestare le decisioni che li danneggiano.
Ma c’è di più: le élite economiche più ricche e meglio organizzate sono in una posizione ottimale per influenzare le decisioni dei tecnocrati, attraverso think tank, fondazioni politiche, università private e altre organizzazioni. Possono infatti mascherare le politiche che le avvantaggiano a spese dei cittadini comuni con il linguaggio della neutralità tecnocratica, presentandole cioè come ciò che deve essere fatto, anziché come ciò che desidera un particolare gruppo di interesse: per esempio un sistema di tassazione che le favorisca a svantaggio della maggioranza della popolazione. In altre parole il ricorso alla tecnocrazia può diventare un pretesto per imporre decisioni di parte sottraendole al confronto democratico nel quale rischierebbero di essere sconfitte.
È bene essere il più chiari possibile su un punto finora sottinteso. Non si propone certo di ignorare le competenze degli esperti: nessuno più di noi del CICAP sa quanto oggi sia fondamentale consultare gli specialisti per affrontare i problemi e districarsi in un mondo dominato da informazione di scarsa qualità. Tuttavia, si deve evitare di farsi prendere dall’entusiasmo e mitizzare gli specialisti come adatti a risolvere ogni genere di problema.
Assegnare agli specialisti incarichi che garantiscono molto potere ma non impongono di risponderne ai cittadini produce più problemi di quanti ne risolva. Un sistema politico-istituzionale davvero razionale dovrebbe premiare gli sforzi e le competenze degli esperti istituendo uno scambio virtuoso di conoscenze laddove queste possono incidere positivamente. Al contempo, escludere dal processo decisionale (ancorché in forma rappresentativa) le classi meno scolarizzate e specializzate sarebbe, oltre che moralmente deprecabile, dannoso sul piano pratico. Molti studi affermano infatti che tutti i cittadini possono contribuire efficacemente all'identificazione e alla risoluzione dei problemi sociali. In definitiva, quindi, tecnica e competenza sì, tecnocrazia no.
Riferimenti bibliografici
- M. Cole, “What’s Wrong with Technocracy?”, in Boston Review, 22 agosto 2022.
- A. Taub. “The E.U. Is Democratic. It Just Doesn’t Feel That Way”, in The New York Times, 29 giugno 2016.
- M. Matthijs e M. Blyth. When Is It Rational to Learn the Wrong Lessons? Technocratic Authority, Social Learning, and Euro Fragility. Cambridge University Press, 2017.