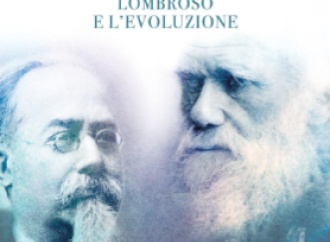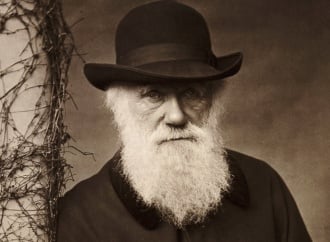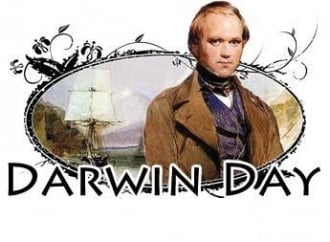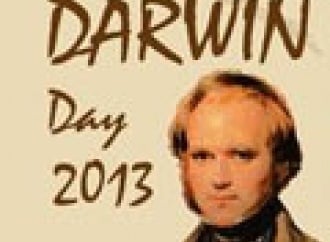Il concetto di "razze umane" è un'invenzione moderna, che è stata usata per giustificare e promuovere lo sterminio sistematico di intere popolazioni.
La consapevolezza delle tragedie che si sono consumate ha portato, dopo la seconda guerra mondiale a bandire il razzismo dal discorso pubblico. Oggi infatti dichiararsi esplicitamente razzisti è un atteggiamento socialmente non desiderabile. Nonostante ciò, il concetto di razza riemerge periodicamente, per esempio nell'espressione di pregiudizi antisemiti, o quando, come in questo periodo, si assiste a significativi movimenti di migranti che provengono da Paesi extra-europei.
Tagliato con l'accetta. Classificare, dicotomizzare, dividere, sono processi cognitivi fondamentali. Distinguere tra i cibi che fanno bene e quelli che fanno male, tra animali innocui e pericolosi, tra temporali e tempeste potrebbe essere stato il passo prima della morte ‒ o della sopravvivenza. Allo stesso modo è stata vitale la distinzione tra "noi" e "loro" quando i loro erano quelli della tribù accanto, della valle vicina, della città dall'altra parte della pianura. Che potevano essere nemici, o subdoli avversari. O amici, nel caso si fossero presentati con doni o profferte di alleanza. Questa tendenza a classificare ha portato per esempio Aristotele a sostenere che le popolazioni si dividevano in Greci che avevano comunità basate sulle città stato, e Barbari, che non le avevano. Così come i Romani si differenziavano dai non Romani per la presenza o l'assenza di particolari strutture legali. Ma ciò che ha caratterizzato il razzismo moderno è stato il fatto che l'intera specie umana è stata classificata in diverse "razze" (d'ora in poi senza virgolette, che sono implicite) basandosi su caratteri biologici. Per capire come si sia prodotto questo fenomeno, è necessario provare a ricostruirne brevemente la storia
Buon sangue non mente. Il primo esempio di discriminazione razziale sembra essere stato quello di Torquemada (sì, lui, il famoso inquisitore) che pretendeva dai suoi inquisiti, oltre che la fede, anche la limpieza de sangre (purezza di sangue), cioè una discendenza pura da antenati Cristiani, non Ebrei o Musulmani. Secondo George Fredrikson (Racism, a short history, Princeton University Press, 2002) sempre nel Quindicesimo secolo i mercanti di schiavi arabi assegnavano ai più "scuri" lavori bassi e gravosi, mentre a quelli "chiari" erano riservati compiti più complicati. Altre e più complesse discussioni sulla superiorità o inferiorità di popolazioni appena conosciute si ebbero dopo la scoperta dell'America e di altre regioni del mondo da parte degli europei.
Dalle discussioni religiose e pratiche (se sono inferiori o diverse queste popolazioni possono essere schiavizzate) si arriva a quelle filosofiche. Che cominciano a introdurre anche la biologia nella nascita delle razze umane Se siamo così differenti, ciò è dovuto a una nascita diversificata delle diverse razze, oppure a una successiva differenziazione? La specie umana è cioè poligenica o monogenica? Nel primo caso il "razzismo" è giustificato anche scientificamente, nel secondo è un po' difficile farlo, dato che discendiamo tutti dai figli di Noè (anche se un suo nipote fu maledetto perché il padre, cioè il figlio di Noè, prese in giro il patriarca nudo e ubriaco ‒ non chiedete troppo, la questione è complessa).
David Hume era per la netta distinzione tra le razze, che oggi chiamerebbe (quasi) specie, mentre Kant propendeva per una nascita comune e una successiva differenziazione in base alle condizioni ambientali. E aggiungeva che la possibilità di accoppiamenti fertili era a favore dell'origine comune delle razze. Uno studioso della questione delle razze, Ivan Hannaford, fa risalire la prima "teoria delle razze nell'Occidente a François Bernier, un medico francese che in un libro del 1684 divise l'uomo in varie specie in base ai caratteri esterni osservabili. Tutte queste divisioni erano, almeno in parte, basate sulla biologia; nel Diciottesimo secolo Johann Friedrich Blumenbach, il padre della moderna antropologia, affermava che le razze umane (prima quattro, poi cinque) si distinguevano per la forma del cranio, un carattere più "scientifico" del colore della pelle o della struttura dei capelli.
Il salto da una semplice disputa filosofica alla realtà fu fatto dal teorico delle razze Gobineau, che chiarì a tutti quanto quella bianca fosse meglio delle altre; il concetto di superiorità di una razza rispetto a un'altra era già presente nella discussione, ma Gobineau ne teorizzò a fondo anche l'origine e la possibile difesa ideologica. Il dibattito fra poligenisti e monogenisti si attenuò un po' con il successo dei libri di Darwin, che si schierò decisamente a favore dell'origine comune, giustificandola ancora con gli accoppiamenti fertili tra razze diverse. È interessante anche far notare come, secondo Adrian Desmond e James Moore nel libro Darwin's Sacred Cause (Houghton Mifflin Harcourt, 2009), una delle spinte che portarono Darwin alla teoria dell'evoluzione fu il suo odio per il razzismo.
Divide et impera. Uccidere il poligenismo, come fa notare Michael James, in "Race" (The Stanford Encyclopedia of Philosophy http://stanford.io/1I0E9vX , cui ci si può riferire anche per le discussioni sui punti di vista filosofici) non servì però a eliminare il concetto di razza. Saremo anche tutti figli di Noè, si diceva, ma la lunga storia ci ha diviso in razze ben distinte e facilmente collocabili in una scala di valore, dalla forza all'intelligenza alla cultura alla civiltà. L'"altro" dei nostri antenati diventa compiutamente un "altro più stupido, più incapace, meno civile e colto"; non che non lo fosse anche migliaia di anni fa, ma qui stiamo parlando di teorizzazioni delle differenze.
Da lì il passo che vede nel nemico un essere inferiore per natura, non per appartenenza a questa o quella tribù vicina, è stato breve. In Europa erano gli Ebrei, in America i neri discendenti degli schiavi, negli odierni Stati Uniti i cosiddetti latinos (non è chiaro chi siano). Un altro libro che mischiava scienza e ideologia allo scopo di dimostrare, in apparenza, la superiorità la superiorità della razza bianca fu "Le fondamenta del Diciannovesimo secolo" (Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts) di Houston Stewart Chamberlain. Gobineau e Chamberlain fornirono le basi ideologiche (insieme a un mal compreso darwinismo, unito alle idee di eugenetica di Francis Galton, cugino di Darwin stesso) per lo stato più ideologicamente razzista/antisemita, la Germania di Hitler.
Ecco la biologia. Neri ed ebrei erano distinti dagli altri popoli essenzialmente per il loro aspetto fisico. I primi per il colore della pelle, i secondi per esempio per il naso aquilino, spesso preso di mira dagli antisemiti (oppure per aspetti culturali, come i pe'ot, i boccoli portati dagli ebrei ultraortodossi). Come abbiamo visto all'inizio, un particolare che non era presente nei primi tentativi di divisione dei popoli. Alla ricerca di un qualche sistema che distinguesse i bianchi dagli "altri", il colore della pelle e la struttura dei capelli (insieme ad altri caratteri fenotipici) saltavano agli occhi. Lo studio della genetica ha però chiarito che questi caratteri sono tutt'altro che facili da determinare in base alla struttura del patrimonio genetico, perché sono come si dice poligenici (determinati cioè da più di un gene). Non solo, ma in popolazioni diverse e scure di carnagione (per esempio gli abitanti dell'India meridionale e quelli dell'Africa centrale) il colore della pelle è definito da fattori genetici differenti.
Infine, e se n'era accorto anche il francese Buffon nel 1749, il colore della pelle (e non solo) è difficile da dividere in "classi" ben definite,. Anche solo dal punto di vista fenotipico, le variazioni umane sono continue, non discrete. È impossibile quindi stabilire un gruppo di persone che appartengono a una certa classificazione, ed escluderne un altro, trovando una netta soluzione di continuità. L'aspetto esterno è quindi irrilevante per determinare una razza. Oltre a non considerare il fatto che il fenotipo di una popolazione non è invariabile, e muta secondo le condizioni ambientali e seguendo le dinamiche della selezione naturale. Che la pelle scura serva o meno a difendersi dall'eccesso di raggi ultravioletti non è determinato dalla "razza nera", ma dalle forze dell'evoluzione che possono cambiare l'aspetto di un popolo nel giro di alcune migliaia di anni. Questo dati di fatto non fermarono i teorici dal continuare nella loro ricerca di elementi che differenziassero l'intera specie in razze distinte. Basandosi ormai non più sul colore ma su altri caratteri come l'altezza o la forma di alcune parti del corpo, fino ad arrivare all'intelligenza (come vedremo). Quest'immonda mescolanza di scienza e ideologia è stata almeno teoricamente spazzata via dagli anni Sessanta del secolo scorso, quando si iniziò a scrutare all'interno della cellula, e a vedere che le differenze tra uomini erano del tutto superficiali. Al tempo il numero delle razze andava da 3 a 30, le divisioni erano quanto meno arbitrarie, ma la scienza non aveva ancora esaminato la questione a fondo.
A parte due figure importanti, come l'antropologo Franz Boas e il genetista Ashely Montagu, il punto focale della diatriba è stato un articolo del 1972 di Richard Lewontin (genetista statunitense, noto per le sue posizione egualitarie e socialiste), dal titolo The apportionment of human diversity (Evol. Biol. 6, 381–398). Lewontin dimostrò come la maggior parte della diversità umana sia all'interno di una popolazione, mentre ve ne è ben poca tra popolazioni diverse. Una frase spesso ripetuta, ma che ha forse bisogno di un minimo di spiegazione. Il patrimonio genetico della nostra specie è fatto da circa 3 miliardi di coppie di basi, divise in più o meno 22.500 geni (non entriamo nella diatriba su quali geni siano attivi e quali no), a loro volta collocati in 22 coppie di cromosomi, più due. I 22 sono detti somatici, i due in più sessuali ‒ i famosi X e Y che determinano il genere di una persona, grossolanamente. Ogni gene (cioè ogni regione del DNA che può esprimere un RNA) può presentarsi però in forme diverse, che si chiamano alleli. Ognuno di essi può avere funzioni differenti, essere dominante o recessivo, produrre o meno un determinato RNA e quindi una proteina, e così via. Questi differenti alleli costituiscono la variabilità di una specie. In base agli studi di Lewontin e successivi, il patrimonio genetico di ogni essere umano è uguale a quello di ogni altro in media per il 99,5%, forse di più. È quello 0,5% che varia tra una persona e un'altra, e il confronto si deve fare su questa percentuale, già di per sé minuscola.
Dunque, secondo Lewontin, tutta la variabilità della specie umana è presente per l'85,4% all'interno di un gruppo, una tribù, una piccola popolazione coesa. Una percentuale molto più piccola, l'8,3%, è invece presente in popolazioni simili, che appartengono alla stessa razza. La differenza tra diverse razze è di solo il 6,3%. Il dato di Lewontin è stato confermato da studi successivi effettuati con tecniche diverse (come per esempio quello intitolato An apportionment of human DNA diversity ‒ PNAS, Vol. 94, pp. 4516 – 4519, April 1997, un lavoro di tre studiosi italiani e uno statunitense. Uno degli studiosi è Guido Barbujani, che sulle razze ha scritto notevolissimi libri divulgativi, che invito a leggere). Cosa si ricava da questi dati? Che se una sfortunata (?) catastrofe facesse scomparire l'intera umanità a parte una piccola tribù del Sud America, quasi tutta la variabilità della nostra specie sarebbe salva. È dunque il 6,3% (ricordiamo, il 6,3% dello 0,5% menzionato prima, cioè lo 0,03% del patrimonio genetico) la differenza tra le quelle che una volta erano definite razze. Se una percentuale così minuscola di variabilità è da assegnare alle varie razze umane (qualsiasi esse siano) significa che questa divisione ha poca logica, perché praticamente non si riescono a trovare geni che appartengono esclusivamente all'una o altra razza. Alcuni esempi potrebbero chiarire la situazione. Tutti sanno che i gruppi sanguigni sono quattro (A, B, AB e 0) e che la loro prevalenza in varie parti del mondo è differente: i nativi americani (BlackFoot) hanno l'82% di A, e i Kikuyu del Kenya l'1% di AB. Altre etnie si suddividono i gruppi sanguigni in maniera più equa, ma (a parte piccole popolazioni) in nessuna parte del mondo un gruppo sanguigno è dominante in maniera assoluta.
Obiezioni respinte! Viene così a cadere una delle obiezioni più importanti nel dibattito sulla presenza o meno di razze umane. Che suona così: è vero che le differenze tra varie popolazioni sono irrisorie, ma qualcosa esiste, qualche gene variato (allele) di differenza c'è. E questo qualcosa non va esaminato singolarmente, ma a gruppi. Le razze, secondo questa ipotesi che è stata definita "la fallacia di Lewontin" dal genetista inglese Anthony Edwards, sono facilmente distinguibili in base a gruppi (cluster) di alleli. E quindi Lewontin, nella sua conclusione che "le razze non hanno significato biologico" aveva torto, secondo Edwards.
Le risposte alla critica di Edwards, che oltre che genetista è anche statistico e quindi sa fare i conti, non si sono fatte attendere. La più importante è questa: Edwards afferma che una parte della diversità all'interno dei geni umani (di tutti i geni umani, anzi alleli, che sono definiti pool genico) è correlata alla geografia delle persone prese in esame. È vero, ma una correlazione geografica, con tutto quello che è successo da quando siamo usciti dall'Africa, è piuttosto debole. È anche piuttosto banale dire che gli italiani sono più simili a loro stessi di quanto non siano con gli Inuit. Soprattutto la scoperta di Edwards non permette di trovare grandi gruppi di persone che abbiano la stessa struttura genica molto simile al loro interno e che non la condividano quasi per niente con altri gruppi. I gruppi (cluster) di geni che determinano le razze non sono identificabili. Le cosiddette razze quindi, continuano a non esistere, nonostante quello che dice Edwards.
Un questione di cultura. Ma c'è un altro fatto molto importante da considerare. I modelli della diversità umana studiati da Lewontin e molti altri non sono quasi per niente sovrapponibili ai modelli comportamentali e cognitivi. Nessuno nega che un gruppo o una tribù, un popolo o un'etnia siano diversi dai vicini (e ancora di più dai lontani). Ma i genetisti e gli antropologi negano che queste differenze siano all'interno del nostro DNA, siano cioè, per usare una parola desueta, innate. Che si nasca differenti insomma, e non si possa fare più niente per cambiare. Si tende cioè a dire che una razza non è all'interno di una persona, ma gliela si impone dopo, quando cresce. È cioè una caratteristica culturale. Che si stacca quasi del tutto dalle caratteristiche fisiche, anche se ovviamente la base stessa della cultura è il nostro cervello, che deriva dall'azione della selezione naturale ‒ e quindi ancora della biologia.
Intelligenza e pregiudizio. Ci sono ancora due aspetti che colpiscono molto coloro che pensano alle razze umane" come entità esistenti: uno è senza senso, all'altro è necessario fare un po' più d'attenzione. Il primo è l'intelligenza; non ci sarebbe stato nessun problema a considerare le razze esistenti se a questa categorizzazione non fosse stata sempre immancabilmente associata anche un'altra "scala", quella dell'intelligenza.
I bianchi erano inevitabilmente più brillanti, in base a test di intelligenza fatti guarda caso su misura per loro (vedi sotto). Il loro primato è stato poi conquistato dagli asiatici, il cui approccio ai test è plasmato quasi totalmente dall'impronta occidentale. Non più tardi del 1994 un libro diventato famosissimo, The Bell Curve (di Richard Herrnstein e Charles Murray ‒ Free Press), affermava che l'intelligenza è almeno parzialmente ereditabile, e che in generale i bianchi erano più intelligenti dei neri americani per ragioni genetiche.
In questo richiamando le idee di un altro psicologo, Arthur Jensen, che proclamava nel 1969 che i neri americani erano meno intelligenti dei bianchi, ancora, per ragioni genetiche. E che era quindi inutile cercare di educarli con programmi speciali, tanto non ci sarebbero mai arrivati. Le critiche a questi lavori, cui si aggiunse nel 2012 un rapporto della Heritage Foundation (un'organizzazione statunitense di destra che si oppone all'arrivo degli immigrati e ai programmi di aiuto), sono state piuttosto vivaci, sia scientificamente sia socialmente.
Per esempio The Bell Curve è stato aspramente criticato da Stephen Gould che vi ha individuato fallacie statistiche e di ragionamento: che l'intelligenza sia riducibile a un semplice numero, che in base a questo sia possibile classificare le persone da più a meno intelligenti, e che l'intelligenza stessa sia immutabile ed ereditabile dal 40 all'80%. Non ci sono prove di alcune di queste affermazioni (le critiche furono riprese in parte dall'antropologo Lorin Brace, autore di Race is a four letter word ‒ Oxford University Press, 2005).
Non tutto è così facile, ovviamente, da demolire: uno studio del 2003 di Eric Turkheimer et al. (Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children, su Psychological science) dimostra che è vero che l'intelligenza ha una certa "quantità" di ereditabilità, ma questo vale solo per bambini che vivono in uno stato socioeconomico fortunato, non per quelli che vivono in uno stato socioeconomico inferiore. Inoltre tutto il ragionamento è inficiato dal fatto che, come abbiamo visto prima, è difficilissimo determinare dove inizi una "razza umana" e ne finisca un'altra: e senza saperlo è altrettanto complicato assegnare all'una o all'altra categoria una persona di una certa intelligenza. Senza contare che i vari metodi di valutazione dell'intelligenza (IQ e altri) sono anch'essi soggetti a maggiori o minori critiche. Sarebbero gli stessi se progettati da un cacciatore/raccoglitore del deserto del Kalahari?
Razza e medicina. Ben diversa e forse più intricata è la situazione che riguarda la medicina. In particolare, se si vuole che la medicina personalizzata abbia un futuro, è quasi obbligato, prima di arrivare alla singola persona, suddividere i pazienti in gruppi distinti in base alla loro ascendenza. E cos'è questa suddivisione, si sostiene, se non una classificazione per razze? Un nero americano avrà maggiori probabilità di avere un allele (un gene mutato) che lo protegga dalla malaria di un bianco i cui antenati provengono dalla Norvegia. Significa forse che tutti coloro che hanno quel determinato allele appartengono all'etnia (non chiamiamola razza, stavolta) dei neri americani? Seguendo l'ipotesi di cui abbiamo parlato sopra, quella di Anthony Edwards, si potrebbe dire di sì. Ai tratti come la difesa dalla malaria sono associati altri caratteri, come la pelle più scura e i capelli crespi. E quindi è importante conoscere a quale gruppo appartiene una persona prima di cercare una cura per una determinata condizione. Ma anche qui i sostenitori dell'ipotesi commettono una fallacia logica. Se è vero, come dice ancora Lewontin, che c'è una distinzione chiara tra un finlandese e un ugandese, non si può dire lo stesso tra un mediterraneo e un abitante dell'Asia occidentale. Insomma, come al solito non si riesce a vedere una soluzione di continuità tra un gruppo "razziale" e un altro. Inoltre, se vogliamo andare a vedere le singole condizioni o i singoli rischi, gli alleli che difendono dalla malaria non sono presenti solo tra gli africani, ma anche in altre popolazioni tropicali o che abitavano vicino ai tropici e che avevano un alto rischio di contrarre la malattia. Basandosi su questo fatto, i sardi a che razza apparterrebbero, dato che anch'essi hanno una condizione che li protegge dalla malaria, la talassemia?
C'è infine una confusione tra razza e ascendenza che offusca tutta la questione. Non è detto che come un sol uomo tutti i discendenti di una data popolazione (piccola o grande) siano diventati ai giorni nostri i rappresentanti di una determinata razza. Conclude Lewontin: "In un questionario medico dovremmo chiedere non a che razza appartiene una persona, ma di quale gruppo etnico facevano parte i suoi antenati. Ancora una volta, la caratterizzazione razziale è un pessimo predittore della biologia".
La parola razza è spesso associata a continui giudizi di valore o scale di intelligenza o altro, e inoltre non ha neppure una solida base scientifica univoca e inequivocabile. In conclusione, per la biologia della specie umana, sarebbe meglio abolirla del tutto.
La consapevolezza delle tragedie che si sono consumate ha portato, dopo la seconda guerra mondiale a bandire il razzismo dal discorso pubblico. Oggi infatti dichiararsi esplicitamente razzisti è un atteggiamento socialmente non desiderabile. Nonostante ciò, il concetto di razza riemerge periodicamente, per esempio nell'espressione di pregiudizi antisemiti, o quando, come in questo periodo, si assiste a significativi movimenti di migranti che provengono da Paesi extra-europei.
Tagliato con l'accetta. Classificare, dicotomizzare, dividere, sono processi cognitivi fondamentali. Distinguere tra i cibi che fanno bene e quelli che fanno male, tra animali innocui e pericolosi, tra temporali e tempeste potrebbe essere stato il passo prima della morte ‒ o della sopravvivenza. Allo stesso modo è stata vitale la distinzione tra "noi" e "loro" quando i loro erano quelli della tribù accanto, della valle vicina, della città dall'altra parte della pianura. Che potevano essere nemici, o subdoli avversari. O amici, nel caso si fossero presentati con doni o profferte di alleanza. Questa tendenza a classificare ha portato per esempio Aristotele a sostenere che le popolazioni si dividevano in Greci che avevano comunità basate sulle città stato, e Barbari, che non le avevano. Così come i Romani si differenziavano dai non Romani per la presenza o l'assenza di particolari strutture legali. Ma ciò che ha caratterizzato il razzismo moderno è stato il fatto che l'intera specie umana è stata classificata in diverse "razze" (d'ora in poi senza virgolette, che sono implicite) basandosi su caratteri biologici. Per capire come si sia prodotto questo fenomeno, è necessario provare a ricostruirne brevemente la storia
Buon sangue non mente. Il primo esempio di discriminazione razziale sembra essere stato quello di Torquemada (sì, lui, il famoso inquisitore) che pretendeva dai suoi inquisiti, oltre che la fede, anche la limpieza de sangre (purezza di sangue), cioè una discendenza pura da antenati Cristiani, non Ebrei o Musulmani. Secondo George Fredrikson (Racism, a short history, Princeton University Press, 2002) sempre nel Quindicesimo secolo i mercanti di schiavi arabi assegnavano ai più "scuri" lavori bassi e gravosi, mentre a quelli "chiari" erano riservati compiti più complicati. Altre e più complesse discussioni sulla superiorità o inferiorità di popolazioni appena conosciute si ebbero dopo la scoperta dell'America e di altre regioni del mondo da parte degli europei.
Dalle discussioni religiose e pratiche (se sono inferiori o diverse queste popolazioni possono essere schiavizzate) si arriva a quelle filosofiche. Che cominciano a introdurre anche la biologia nella nascita delle razze umane Se siamo così differenti, ciò è dovuto a una nascita diversificata delle diverse razze, oppure a una successiva differenziazione? La specie umana è cioè poligenica o monogenica? Nel primo caso il "razzismo" è giustificato anche scientificamente, nel secondo è un po' difficile farlo, dato che discendiamo tutti dai figli di Noè (anche se un suo nipote fu maledetto perché il padre, cioè il figlio di Noè, prese in giro il patriarca nudo e ubriaco ‒ non chiedete troppo, la questione è complessa).
David Hume era per la netta distinzione tra le razze, che oggi chiamerebbe (quasi) specie, mentre Kant propendeva per una nascita comune e una successiva differenziazione in base alle condizioni ambientali. E aggiungeva che la possibilità di accoppiamenti fertili era a favore dell'origine comune delle razze. Uno studioso della questione delle razze, Ivan Hannaford, fa risalire la prima "teoria delle razze nell'Occidente a François Bernier, un medico francese che in un libro del 1684 divise l'uomo in varie specie in base ai caratteri esterni osservabili. Tutte queste divisioni erano, almeno in parte, basate sulla biologia; nel Diciottesimo secolo Johann Friedrich Blumenbach, il padre della moderna antropologia, affermava che le razze umane (prima quattro, poi cinque) si distinguevano per la forma del cranio, un carattere più "scientifico" del colore della pelle o della struttura dei capelli.
Il salto da una semplice disputa filosofica alla realtà fu fatto dal teorico delle razze Gobineau, che chiarì a tutti quanto quella bianca fosse meglio delle altre; il concetto di superiorità di una razza rispetto a un'altra era già presente nella discussione, ma Gobineau ne teorizzò a fondo anche l'origine e la possibile difesa ideologica. Il dibattito fra poligenisti e monogenisti si attenuò un po' con il successo dei libri di Darwin, che si schierò decisamente a favore dell'origine comune, giustificandola ancora con gli accoppiamenti fertili tra razze diverse. È interessante anche far notare come, secondo Adrian Desmond e James Moore nel libro Darwin's Sacred Cause (Houghton Mifflin Harcourt, 2009), una delle spinte che portarono Darwin alla teoria dell'evoluzione fu il suo odio per il razzismo.
Divide et impera. Uccidere il poligenismo, come fa notare Michael James, in "Race" (The Stanford Encyclopedia of Philosophy http://stanford.io/1I0E9vX , cui ci si può riferire anche per le discussioni sui punti di vista filosofici) non servì però a eliminare il concetto di razza. Saremo anche tutti figli di Noè, si diceva, ma la lunga storia ci ha diviso in razze ben distinte e facilmente collocabili in una scala di valore, dalla forza all'intelligenza alla cultura alla civiltà. L'"altro" dei nostri antenati diventa compiutamente un "altro più stupido, più incapace, meno civile e colto"; non che non lo fosse anche migliaia di anni fa, ma qui stiamo parlando di teorizzazioni delle differenze.
Da lì il passo che vede nel nemico un essere inferiore per natura, non per appartenenza a questa o quella tribù vicina, è stato breve. In Europa erano gli Ebrei, in America i neri discendenti degli schiavi, negli odierni Stati Uniti i cosiddetti latinos (non è chiaro chi siano). Un altro libro che mischiava scienza e ideologia allo scopo di dimostrare, in apparenza, la superiorità la superiorità della razza bianca fu "Le fondamenta del Diciannovesimo secolo" (Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts) di Houston Stewart Chamberlain. Gobineau e Chamberlain fornirono le basi ideologiche (insieme a un mal compreso darwinismo, unito alle idee di eugenetica di Francis Galton, cugino di Darwin stesso) per lo stato più ideologicamente razzista/antisemita, la Germania di Hitler.
Ecco la biologia. Neri ed ebrei erano distinti dagli altri popoli essenzialmente per il loro aspetto fisico. I primi per il colore della pelle, i secondi per esempio per il naso aquilino, spesso preso di mira dagli antisemiti (oppure per aspetti culturali, come i pe'ot, i boccoli portati dagli ebrei ultraortodossi). Come abbiamo visto all'inizio, un particolare che non era presente nei primi tentativi di divisione dei popoli. Alla ricerca di un qualche sistema che distinguesse i bianchi dagli "altri", il colore della pelle e la struttura dei capelli (insieme ad altri caratteri fenotipici) saltavano agli occhi. Lo studio della genetica ha però chiarito che questi caratteri sono tutt'altro che facili da determinare in base alla struttura del patrimonio genetico, perché sono come si dice poligenici (determinati cioè da più di un gene). Non solo, ma in popolazioni diverse e scure di carnagione (per esempio gli abitanti dell'India meridionale e quelli dell'Africa centrale) il colore della pelle è definito da fattori genetici differenti.
Infine, e se n'era accorto anche il francese Buffon nel 1749, il colore della pelle (e non solo) è difficile da dividere in "classi" ben definite,. Anche solo dal punto di vista fenotipico, le variazioni umane sono continue, non discrete. È impossibile quindi stabilire un gruppo di persone che appartengono a una certa classificazione, ed escluderne un altro, trovando una netta soluzione di continuità. L'aspetto esterno è quindi irrilevante per determinare una razza. Oltre a non considerare il fatto che il fenotipo di una popolazione non è invariabile, e muta secondo le condizioni ambientali e seguendo le dinamiche della selezione naturale. Che la pelle scura serva o meno a difendersi dall'eccesso di raggi ultravioletti non è determinato dalla "razza nera", ma dalle forze dell'evoluzione che possono cambiare l'aspetto di un popolo nel giro di alcune migliaia di anni. Questo dati di fatto non fermarono i teorici dal continuare nella loro ricerca di elementi che differenziassero l'intera specie in razze distinte. Basandosi ormai non più sul colore ma su altri caratteri come l'altezza o la forma di alcune parti del corpo, fino ad arrivare all'intelligenza (come vedremo). Quest'immonda mescolanza di scienza e ideologia è stata almeno teoricamente spazzata via dagli anni Sessanta del secolo scorso, quando si iniziò a scrutare all'interno della cellula, e a vedere che le differenze tra uomini erano del tutto superficiali. Al tempo il numero delle razze andava da 3 a 30, le divisioni erano quanto meno arbitrarie, ma la scienza non aveva ancora esaminato la questione a fondo.
A parte due figure importanti, come l'antropologo Franz Boas e il genetista Ashely Montagu, il punto focale della diatriba è stato un articolo del 1972 di Richard Lewontin (genetista statunitense, noto per le sue posizione egualitarie e socialiste), dal titolo The apportionment of human diversity (Evol. Biol. 6, 381–398). Lewontin dimostrò come la maggior parte della diversità umana sia all'interno di una popolazione, mentre ve ne è ben poca tra popolazioni diverse. Una frase spesso ripetuta, ma che ha forse bisogno di un minimo di spiegazione. Il patrimonio genetico della nostra specie è fatto da circa 3 miliardi di coppie di basi, divise in più o meno 22.500 geni (non entriamo nella diatriba su quali geni siano attivi e quali no), a loro volta collocati in 22 coppie di cromosomi, più due. I 22 sono detti somatici, i due in più sessuali ‒ i famosi X e Y che determinano il genere di una persona, grossolanamente. Ogni gene (cioè ogni regione del DNA che può esprimere un RNA) può presentarsi però in forme diverse, che si chiamano alleli. Ognuno di essi può avere funzioni differenti, essere dominante o recessivo, produrre o meno un determinato RNA e quindi una proteina, e così via. Questi differenti alleli costituiscono la variabilità di una specie. In base agli studi di Lewontin e successivi, il patrimonio genetico di ogni essere umano è uguale a quello di ogni altro in media per il 99,5%, forse di più. È quello 0,5% che varia tra una persona e un'altra, e il confronto si deve fare su questa percentuale, già di per sé minuscola.
Dunque, secondo Lewontin, tutta la variabilità della specie umana è presente per l'85,4% all'interno di un gruppo, una tribù, una piccola popolazione coesa. Una percentuale molto più piccola, l'8,3%, è invece presente in popolazioni simili, che appartengono alla stessa razza. La differenza tra diverse razze è di solo il 6,3%. Il dato di Lewontin è stato confermato da studi successivi effettuati con tecniche diverse (come per esempio quello intitolato An apportionment of human DNA diversity ‒ PNAS, Vol. 94, pp. 4516 – 4519, April 1997, un lavoro di tre studiosi italiani e uno statunitense. Uno degli studiosi è Guido Barbujani, che sulle razze ha scritto notevolissimi libri divulgativi, che invito a leggere). Cosa si ricava da questi dati? Che se una sfortunata (?) catastrofe facesse scomparire l'intera umanità a parte una piccola tribù del Sud America, quasi tutta la variabilità della nostra specie sarebbe salva. È dunque il 6,3% (ricordiamo, il 6,3% dello 0,5% menzionato prima, cioè lo 0,03% del patrimonio genetico) la differenza tra le quelle che una volta erano definite razze. Se una percentuale così minuscola di variabilità è da assegnare alle varie razze umane (qualsiasi esse siano) significa che questa divisione ha poca logica, perché praticamente non si riescono a trovare geni che appartengono esclusivamente all'una o altra razza. Alcuni esempi potrebbero chiarire la situazione. Tutti sanno che i gruppi sanguigni sono quattro (A, B, AB e 0) e che la loro prevalenza in varie parti del mondo è differente: i nativi americani (BlackFoot) hanno l'82% di A, e i Kikuyu del Kenya l'1% di AB. Altre etnie si suddividono i gruppi sanguigni in maniera più equa, ma (a parte piccole popolazioni) in nessuna parte del mondo un gruppo sanguigno è dominante in maniera assoluta.
Obiezioni respinte! Viene così a cadere una delle obiezioni più importanti nel dibattito sulla presenza o meno di razze umane. Che suona così: è vero che le differenze tra varie popolazioni sono irrisorie, ma qualcosa esiste, qualche gene variato (allele) di differenza c'è. E questo qualcosa non va esaminato singolarmente, ma a gruppi. Le razze, secondo questa ipotesi che è stata definita "la fallacia di Lewontin" dal genetista inglese Anthony Edwards, sono facilmente distinguibili in base a gruppi (cluster) di alleli. E quindi Lewontin, nella sua conclusione che "le razze non hanno significato biologico" aveva torto, secondo Edwards.
Le risposte alla critica di Edwards, che oltre che genetista è anche statistico e quindi sa fare i conti, non si sono fatte attendere. La più importante è questa: Edwards afferma che una parte della diversità all'interno dei geni umani (di tutti i geni umani, anzi alleli, che sono definiti pool genico) è correlata alla geografia delle persone prese in esame. È vero, ma una correlazione geografica, con tutto quello che è successo da quando siamo usciti dall'Africa, è piuttosto debole. È anche piuttosto banale dire che gli italiani sono più simili a loro stessi di quanto non siano con gli Inuit. Soprattutto la scoperta di Edwards non permette di trovare grandi gruppi di persone che abbiano la stessa struttura genica molto simile al loro interno e che non la condividano quasi per niente con altri gruppi. I gruppi (cluster) di geni che determinano le razze non sono identificabili. Le cosiddette razze quindi, continuano a non esistere, nonostante quello che dice Edwards.
Un questione di cultura. Ma c'è un altro fatto molto importante da considerare. I modelli della diversità umana studiati da Lewontin e molti altri non sono quasi per niente sovrapponibili ai modelli comportamentali e cognitivi. Nessuno nega che un gruppo o una tribù, un popolo o un'etnia siano diversi dai vicini (e ancora di più dai lontani). Ma i genetisti e gli antropologi negano che queste differenze siano all'interno del nostro DNA, siano cioè, per usare una parola desueta, innate. Che si nasca differenti insomma, e non si possa fare più niente per cambiare. Si tende cioè a dire che una razza non è all'interno di una persona, ma gliela si impone dopo, quando cresce. È cioè una caratteristica culturale. Che si stacca quasi del tutto dalle caratteristiche fisiche, anche se ovviamente la base stessa della cultura è il nostro cervello, che deriva dall'azione della selezione naturale ‒ e quindi ancora della biologia.
Intelligenza e pregiudizio. Ci sono ancora due aspetti che colpiscono molto coloro che pensano alle razze umane" come entità esistenti: uno è senza senso, all'altro è necessario fare un po' più d'attenzione. Il primo è l'intelligenza; non ci sarebbe stato nessun problema a considerare le razze esistenti se a questa categorizzazione non fosse stata sempre immancabilmente associata anche un'altra "scala", quella dell'intelligenza.
I bianchi erano inevitabilmente più brillanti, in base a test di intelligenza fatti guarda caso su misura per loro (vedi sotto). Il loro primato è stato poi conquistato dagli asiatici, il cui approccio ai test è plasmato quasi totalmente dall'impronta occidentale. Non più tardi del 1994 un libro diventato famosissimo, The Bell Curve (di Richard Herrnstein e Charles Murray ‒ Free Press), affermava che l'intelligenza è almeno parzialmente ereditabile, e che in generale i bianchi erano più intelligenti dei neri americani per ragioni genetiche.
In questo richiamando le idee di un altro psicologo, Arthur Jensen, che proclamava nel 1969 che i neri americani erano meno intelligenti dei bianchi, ancora, per ragioni genetiche. E che era quindi inutile cercare di educarli con programmi speciali, tanto non ci sarebbero mai arrivati. Le critiche a questi lavori, cui si aggiunse nel 2012 un rapporto della Heritage Foundation (un'organizzazione statunitense di destra che si oppone all'arrivo degli immigrati e ai programmi di aiuto), sono state piuttosto vivaci, sia scientificamente sia socialmente.
Per esempio The Bell Curve è stato aspramente criticato da Stephen Gould che vi ha individuato fallacie statistiche e di ragionamento: che l'intelligenza sia riducibile a un semplice numero, che in base a questo sia possibile classificare le persone da più a meno intelligenti, e che l'intelligenza stessa sia immutabile ed ereditabile dal 40 all'80%. Non ci sono prove di alcune di queste affermazioni (le critiche furono riprese in parte dall'antropologo Lorin Brace, autore di Race is a four letter word ‒ Oxford University Press, 2005).
Non tutto è così facile, ovviamente, da demolire: uno studio del 2003 di Eric Turkheimer et al. (Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children, su Psychological science) dimostra che è vero che l'intelligenza ha una certa "quantità" di ereditabilità, ma questo vale solo per bambini che vivono in uno stato socioeconomico fortunato, non per quelli che vivono in uno stato socioeconomico inferiore. Inoltre tutto il ragionamento è inficiato dal fatto che, come abbiamo visto prima, è difficilissimo determinare dove inizi una "razza umana" e ne finisca un'altra: e senza saperlo è altrettanto complicato assegnare all'una o all'altra categoria una persona di una certa intelligenza. Senza contare che i vari metodi di valutazione dell'intelligenza (IQ e altri) sono anch'essi soggetti a maggiori o minori critiche. Sarebbero gli stessi se progettati da un cacciatore/raccoglitore del deserto del Kalahari?
Razza e medicina. Ben diversa e forse più intricata è la situazione che riguarda la medicina. In particolare, se si vuole che la medicina personalizzata abbia un futuro, è quasi obbligato, prima di arrivare alla singola persona, suddividere i pazienti in gruppi distinti in base alla loro ascendenza. E cos'è questa suddivisione, si sostiene, se non una classificazione per razze? Un nero americano avrà maggiori probabilità di avere un allele (un gene mutato) che lo protegga dalla malaria di un bianco i cui antenati provengono dalla Norvegia. Significa forse che tutti coloro che hanno quel determinato allele appartengono all'etnia (non chiamiamola razza, stavolta) dei neri americani? Seguendo l'ipotesi di cui abbiamo parlato sopra, quella di Anthony Edwards, si potrebbe dire di sì. Ai tratti come la difesa dalla malaria sono associati altri caratteri, come la pelle più scura e i capelli crespi. E quindi è importante conoscere a quale gruppo appartiene una persona prima di cercare una cura per una determinata condizione. Ma anche qui i sostenitori dell'ipotesi commettono una fallacia logica. Se è vero, come dice ancora Lewontin, che c'è una distinzione chiara tra un finlandese e un ugandese, non si può dire lo stesso tra un mediterraneo e un abitante dell'Asia occidentale. Insomma, come al solito non si riesce a vedere una soluzione di continuità tra un gruppo "razziale" e un altro. Inoltre, se vogliamo andare a vedere le singole condizioni o i singoli rischi, gli alleli che difendono dalla malaria non sono presenti solo tra gli africani, ma anche in altre popolazioni tropicali o che abitavano vicino ai tropici e che avevano un alto rischio di contrarre la malattia. Basandosi su questo fatto, i sardi a che razza apparterrebbero, dato che anch'essi hanno una condizione che li protegge dalla malaria, la talassemia?
C'è infine una confusione tra razza e ascendenza che offusca tutta la questione. Non è detto che come un sol uomo tutti i discendenti di una data popolazione (piccola o grande) siano diventati ai giorni nostri i rappresentanti di una determinata razza. Conclude Lewontin: "In un questionario medico dovremmo chiedere non a che razza appartiene una persona, ma di quale gruppo etnico facevano parte i suoi antenati. Ancora una volta, la caratterizzazione razziale è un pessimo predittore della biologia".
La parola razza è spesso associata a continui giudizi di valore o scale di intelligenza o altro, e inoltre non ha neppure una solida base scientifica univoca e inequivocabile. In conclusione, per la biologia della specie umana, sarebbe meglio abolirla del tutto.