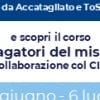Nelle torride giornate di inizio agosto 2017, la ministra dell’istruzione Valeria Fedeli, sia pure in sordina, ha dichiarato di fatto nuovi risparmi nel ministero da lei presieduto[1]. É vero che ha tenuto a precisare che non c’è nessun decreto che preveda tagli alla scuola, ma ha comunque annunciato (intervenendo a Studio 24 di Rai News) che vi saranno «spese di razionalizzazione che hanno toccato tutti i ministeri. Ciascun ministero ha scelto dove fare risparmi». Aggiungendo: «Anche io l’ho fatto, ma non ho toccato le voci fondamentali e non andranno a toccare le 52.000 assunzioni, gli insegnanti di sostegno, gli interventi per l’inclusione. Insomma, le cose fondamentali rimangono». A quale genere di tagli si riferisse però la Fedeli non è dato sapere con precisione.
Le «razionalizzazioni» annunciate dalla ministra si collocano in una lunga e politicamente trasversale tradizione tipicamente italiana, che vede da moltissimi anni un progressivo taglio alle spese destinate a istruzione e ricerca. Anche il successivo annuncio dell’avvio della sperimentazione relativa alla riduzione a quattro anni della durata delle scuole superiori si colloca, evidentemente, in un’ottica di risparmio[2].
È oramai un dato tristemente noto che l’Italia sia uno dei Paesi che ha meno a cuore la formazione dei propri cittadini.
Nel 2015 la percentuale del PIL italiano destinata all’istruzione è stata solo del 4%, contro il 7,5% dell’Islanda, il 7% della Danimarca, il 6,5% della Svezia e il 6,4% del Belgio. Anche considerando la percentuale per l’educazione della spesa pubblica totale, il quadro non migliora. Nella classifica l’Italia si colloca, infatti, al 30° posto (dopo di noi solo la Grecia), con una spesa per l’istruzione pari al 7,9% del totale, a fronte di una media europea del 10,3%. Siamo ben lontani da Paesi come l’Islanda (17,4%) e la Svizzera (17,2%), ma anche da Paesi come l’Estonia (15,1%) o la Polonia (12,6%)[3].
Dati di questo tipo vengono periodicamente pubblicati dai media, suscitano qualche commento di indignazione occasionale, ma poi tutto resta come prima. Pochi, in genere, si chiedono perché questo accada. Qualche tentativo di risposta ha provato a fornirla Peppino Ortoleva, storico e studioso di mezzi di comunicazione, docente all'Università di Torino. In un interessante articolo[4], pubblicato, sempre nei primi giorni di agosto, su quotidiano genovese Il Secolo XIX, Ortoleva analizza innanzi tutto i dati grezzi in maniera più analitica:
«Il livello di spesa in Italia scende progressivamente se passiamo dall’elementare, dove la spesa è in linea con la media europea (anche se tutti sappiamo le disastrose condizioni dell’edilizia scolastica) alla scuola media, dove il nostro paese è decisamente sotto la media, all’università e ricerca, dove siamo a meno di metà della media europea».
Successivamente lo studioso cerca di comprendere le ragioni politiche di questa situazione:
«Certo è che la scelta di risparmiare pesantemente sull’istruzione, universitaria e non solo, si lega a un atteggiamento più generale, che non è quasi per nulla cambiato tra governi di destra e di sinistra: che va dal trascurato al decisamente punitivo».
E, entrando più nei dettagli, sostiene:
«Da parte della destra, tutto sommato, si spiega. Silvio Berlusconi e i suoi alleati hanno sempre considerato gli insegnanti la base di massa della sinistra; e hanno introdotto nella politica italiana un atteggiamento anti-intellettuale abbastanza nuovo in Europa, mentre ha una sua tradizione nella destra americana.
Ma perché anche la sinistra al potere ha fatto una politica analoga? Prima di tutto, proprio perché per molti anni ha considerato gli insegnanti come una base sicura, il cui consenso non sarebbe stato ridotto dai tagli sulla spesa. E poi perché almeno una parte dei politici democratici (Renzi è stato un caso evidente) ci tenevano a distanziarsi dall’immagine del “partito dei professori”. Dando comunque per scontato il loro consenso: uno dei maggiori errori che hanno portato alla sconfitta nel referendum istituzionale».
Al di là dei recenti protagonisti della politica italiana, Ortoleva cerca di individuare eventuali cause remote che possono aver determinato l’attuale situazione:
«Dopo un periodo, negli anni Novanta, in cui è stata fatta una politica dissennata e demagogica di moltiplicazione degli atenei, ora le università (ma anche in parte la stessa scuola media) sono presentate nell’insieme come uno spreco. Salvo che per poche categorie come medici o ingegneri nelle quali vige il numero chiuso, per il resto la retorica dominante è quella delle “fabbriche di disoccupati”. Se tanto i giovani restano disoccupati o sotto-occupati, perché spendere in una formazione inutile?»
Purtroppo, come abbiamo sottolineato altrove in questa rubrica, la percezione dell’inutilità della formazione è piuttosto diffusa, anche tra i giovani[5]. Ma che anche le istituzioni siano contagiate da un simile pessimismo appare poco giustificabile e piuttosto preoccupante.
Spesso i tagli all’istruzione e alla cultura sono motivati sulla base della dilagante crisi economica. Tuttavia è proprio nei momenti di crisi che l’investimento in formazione può risultare strategico. A questo proposito, Ortoleva cita due Paesi africani:
«È interessante notare che, nel mondo, i Paesi che investono di più in istruzione (sempre in proporzione al reddito nazionale) sono due stati africani, Zimbabwe e Namibia. Questa scelta é legata a un progetto che fino a vent’anni fa sembrava quasi impossibile in Africa: fare nascere un ceto medio, garanzia di stabilità sociale, e soprattutto ridurre le disuguaglianze. I dati sulla Namibia da questo punto di vista sono decisamente incoraggianti.
[...]Alcuni Paesi africani puntano sull’istruzione per ridurre la forbice tra i ceti, in termini di reddito e non solo. In Italia ci dovremmo chiedere se questa politica opposta, di disinvestimento sistematico dall’istruzione, non sia una delle cause per cui le diseguaglianze continuano ad aumentare».
E sempre riguardo all’Italia, commenta amaramente:
«Nel nostro Paese, viceversa, il disinvestimento nella scuola e nell’università è parte della stessa politica che rinuncia a qualsiasi progetto per le nuove generazioni, risparmiando su di loro per spendere là dove si compra consenso.
Una politica di università per tutti a costi relativamente contenuti può essere sostenuta solo da una spesa adeguata. Altrimenti si avvia un percorso involutivo, verso un’istruzione sempre più mediocre e insufficiente, e la retorica della “fabbrica di disoccupati” si auto-avvera. Con il risultato che molti giovani sono scoraggiati anche dal continuare a istruirsi, come dimostrano le statistiche su coloro che non lavorano né studiano: una scelta che non si può imputare tutta ai singoli, quando la qualità media dell’offerta formativa continua a calare».
Come uscire da questa impasse? Come rompere questo perverso circolo vizioso? L’autore dell’articolo non dà suggerimenti. Qualcuno ne ha?
Le «razionalizzazioni» annunciate dalla ministra si collocano in una lunga e politicamente trasversale tradizione tipicamente italiana, che vede da moltissimi anni un progressivo taglio alle spese destinate a istruzione e ricerca. Anche il successivo annuncio dell’avvio della sperimentazione relativa alla riduzione a quattro anni della durata delle scuole superiori si colloca, evidentemente, in un’ottica di risparmio[2].
È oramai un dato tristemente noto che l’Italia sia uno dei Paesi che ha meno a cuore la formazione dei propri cittadini.
Nel 2015 la percentuale del PIL italiano destinata all’istruzione è stata solo del 4%, contro il 7,5% dell’Islanda, il 7% della Danimarca, il 6,5% della Svezia e il 6,4% del Belgio. Anche considerando la percentuale per l’educazione della spesa pubblica totale, il quadro non migliora. Nella classifica l’Italia si colloca, infatti, al 30° posto (dopo di noi solo la Grecia), con una spesa per l’istruzione pari al 7,9% del totale, a fronte di una media europea del 10,3%. Siamo ben lontani da Paesi come l’Islanda (17,4%) e la Svizzera (17,2%), ma anche da Paesi come l’Estonia (15,1%) o la Polonia (12,6%)[3].
Dati di questo tipo vengono periodicamente pubblicati dai media, suscitano qualche commento di indignazione occasionale, ma poi tutto resta come prima. Pochi, in genere, si chiedono perché questo accada. Qualche tentativo di risposta ha provato a fornirla Peppino Ortoleva, storico e studioso di mezzi di comunicazione, docente all'Università di Torino. In un interessante articolo[4], pubblicato, sempre nei primi giorni di agosto, su quotidiano genovese Il Secolo XIX, Ortoleva analizza innanzi tutto i dati grezzi in maniera più analitica:
«Il livello di spesa in Italia scende progressivamente se passiamo dall’elementare, dove la spesa è in linea con la media europea (anche se tutti sappiamo le disastrose condizioni dell’edilizia scolastica) alla scuola media, dove il nostro paese è decisamente sotto la media, all’università e ricerca, dove siamo a meno di metà della media europea».
Successivamente lo studioso cerca di comprendere le ragioni politiche di questa situazione:
«Certo è che la scelta di risparmiare pesantemente sull’istruzione, universitaria e non solo, si lega a un atteggiamento più generale, che non è quasi per nulla cambiato tra governi di destra e di sinistra: che va dal trascurato al decisamente punitivo».
E, entrando più nei dettagli, sostiene:
«Da parte della destra, tutto sommato, si spiega. Silvio Berlusconi e i suoi alleati hanno sempre considerato gli insegnanti la base di massa della sinistra; e hanno introdotto nella politica italiana un atteggiamento anti-intellettuale abbastanza nuovo in Europa, mentre ha una sua tradizione nella destra americana.
Ma perché anche la sinistra al potere ha fatto una politica analoga? Prima di tutto, proprio perché per molti anni ha considerato gli insegnanti come una base sicura, il cui consenso non sarebbe stato ridotto dai tagli sulla spesa. E poi perché almeno una parte dei politici democratici (Renzi è stato un caso evidente) ci tenevano a distanziarsi dall’immagine del “partito dei professori”. Dando comunque per scontato il loro consenso: uno dei maggiori errori che hanno portato alla sconfitta nel referendum istituzionale».
Al di là dei recenti protagonisti della politica italiana, Ortoleva cerca di individuare eventuali cause remote che possono aver determinato l’attuale situazione:
«Dopo un periodo, negli anni Novanta, in cui è stata fatta una politica dissennata e demagogica di moltiplicazione degli atenei, ora le università (ma anche in parte la stessa scuola media) sono presentate nell’insieme come uno spreco. Salvo che per poche categorie come medici o ingegneri nelle quali vige il numero chiuso, per il resto la retorica dominante è quella delle “fabbriche di disoccupati”. Se tanto i giovani restano disoccupati o sotto-occupati, perché spendere in una formazione inutile?»
Purtroppo, come abbiamo sottolineato altrove in questa rubrica, la percezione dell’inutilità della formazione è piuttosto diffusa, anche tra i giovani[5]. Ma che anche le istituzioni siano contagiate da un simile pessimismo appare poco giustificabile e piuttosto preoccupante.
Spesso i tagli all’istruzione e alla cultura sono motivati sulla base della dilagante crisi economica. Tuttavia è proprio nei momenti di crisi che l’investimento in formazione può risultare strategico. A questo proposito, Ortoleva cita due Paesi africani:
«È interessante notare che, nel mondo, i Paesi che investono di più in istruzione (sempre in proporzione al reddito nazionale) sono due stati africani, Zimbabwe e Namibia. Questa scelta é legata a un progetto che fino a vent’anni fa sembrava quasi impossibile in Africa: fare nascere un ceto medio, garanzia di stabilità sociale, e soprattutto ridurre le disuguaglianze. I dati sulla Namibia da questo punto di vista sono decisamente incoraggianti.
[...]Alcuni Paesi africani puntano sull’istruzione per ridurre la forbice tra i ceti, in termini di reddito e non solo. In Italia ci dovremmo chiedere se questa politica opposta, di disinvestimento sistematico dall’istruzione, non sia una delle cause per cui le diseguaglianze continuano ad aumentare».
E sempre riguardo all’Italia, commenta amaramente:
«Nel nostro Paese, viceversa, il disinvestimento nella scuola e nell’università è parte della stessa politica che rinuncia a qualsiasi progetto per le nuove generazioni, risparmiando su di loro per spendere là dove si compra consenso.
Una politica di università per tutti a costi relativamente contenuti può essere sostenuta solo da una spesa adeguata. Altrimenti si avvia un percorso involutivo, verso un’istruzione sempre più mediocre e insufficiente, e la retorica della “fabbrica di disoccupati” si auto-avvera. Con il risultato che molti giovani sono scoraggiati anche dal continuare a istruirsi, come dimostrano le statistiche su coloro che non lavorano né studiano: una scelta che non si può imputare tutta ai singoli, quando la qualità media dell’offerta formativa continua a calare».
Come uscire da questa impasse? Come rompere questo perverso circolo vizioso? L’autore dell’articolo non dà suggerimenti. Qualcuno ne ha?
Note
1) A. Giuliani, “Fedeli: ancora risparmi sulla scuola, ma non su personale e alunni”, La Tecnica della Scuola, 3 Agosto 2017: https://tinyurl.com/y7vbacsc
2) Secondo alcune stime la riduzione a 4 anni del corso di studi superiori comporterebbe un risparmio di 1,4 miliardi di euro. Si veda: M. Bartoloni, “Maturità in 4 anni: dove è in vigore in Europa, In Italia farebbe risparmiare 1,4 miliardi”, Il Sole 24 Ore, 8 agosto 2017: https://tinyurl.com/yagtqn7x
3) Dati Eurostat 2017, tratti da: https://tinyurl.com/yc2jrwjw ;
4) P. Ortoleva, “I risparmi sull’istruzione e la miopia della politica”, Il Secolo XIX, 5 agosto 2017;