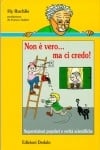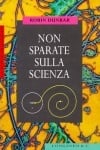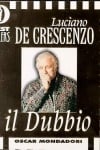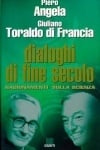Quando ero molto piccolo, secondo la leggenda famigliare, decisi di fare lo scienziato. Per essere precisi, fu la notte del 20 luglio 1969, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin misero piede sul suolo lunare per la prima volta nella storia dell’umanità. All’epoca volevo fare l’astronomo, poi invece ho deciso per la biologia evoluzionistica. A dispetto dello scetticismo di qualche amico e parente, ci sono riuscito. Ma poi, arrivato sulla quarantina, ho avuto una crisi di fede, diciamo così, e sono passato alla filosofia (della scienza). Colpa, in parte, della professoressa Enrica Chiaromonte, la mia insegnante di filosofia del liceo, che sapeva proprio come comunicare il suo entusiasmo per la materia. Comunque sia, da quando ho deciso di cambiare campo mi sono trovato a dover spiegare il perché, specialmente ai miei ex colleghi in biologia. Generalmente parlando, e con le obbligatorie eccezioni, la filosofia non ha una gran reputazione, specialmente tra gli scienziati, e particolarmente negli Stati Uniti, dove vivo. Il cosmologo Stephen Hawking, per esempio, comincia il suo libro Il Grande Disegno (Mondadori, 2011) con le parole: «La filosofia è morta. I filosofi non si sono tenuti al passo con gli sviluppi moderni della scienza - in particolare nella fisica». Lo stesso Hawking poi continua, per circa 190 pagine, a raccontarci di filosofia della cosmologia. Solo che lo fa malissimo, non essendo lui un filosofo.
Hawking si sbagliava clamorosamente, e in diversi aspetti. Primo, la filosofia decisamente non è morta. Non solo ogni anno i filosofi professionisti pubblicano migliaia di articoli tecnici su riviste specializzate, ma i libri di filosofia vendono bene in molti paesi, Italia inclusa. Secondo, i filosofi della scienza che conosco personalmente sanno più scienza di molti scienziati (anche se, ovviamente, non fanno scienza), per il semplice motivo che altrimenti non potrebbero lavorare nel campo della filosofia della scienza. Per esempio, una mia collega si specializza sia in filosofia della meccanica quantistica che in filosofia della relatività generale, cioè le due teorie portanti della fisica moderna. Per fare il suo lavoro, deve leggere in maniera molto più ampia dei fisici che si specializzano in quei due campi, e può permetterselo appunto perché non deve preoccuparsi di scrivere continuamente progetti di finanziamento per sovvenzionare la sua ricerca di laboratorio, né deve fare esperimenti complicati e costosissimi per poter pubblicare i suoi lavori.
E allora, uno potrebbe giustamente domandarsi, che fa, esattamente? Per poterlo capire forse è bene considerare tre campi di studio che si occupano di scienza ma non sono scienze: filosofia della scienza, storia della scienza, e sociologia della scienza. La storia della scienza, ovviamente, non è scienza. È storia. Gli storici della scienza non si pongono come obiettivo quello di risolvere problemi scientifici, come per esempio perché la meccanica quantistica e la relatività generale danno risposte diverse quando applicate ad alcuni problemi, come la fisica dei buchi neri. Gli storici si interessano, piuttosto, di come cambia la scienza stessa, della genesi di nuovi campi e nuove teorie, e anche del come e perché certe domande cessano di essere d’interesse per gli scienziati. Insomma, la storia della scienza è una disciplina descrittiva il cui oggetto di studio è la scienza stessa.
La sociologia della scienza, in maniera simile, tratta la scienza come un’attività umana, portata avanti da esseri umani e quindi caratterizzata da psicologie personali, relazioni interpersonali, e strutture di potere, sia interne (università, laboratori, e così via) che esterne (istituzioni che forniscono finanziamenti alla ricerca, organismi politici che determinano i limiti di tali finanziamenti, ecc.). Anche la sociologia della scienza, quindi, è una disciplina (principalmente) descrittiva che si pone le strutture organizzative della scienza come oggetto di studio.
Infine abbiamo la filosofia della scienza. Il suo scopo è capire la logica delle scoperte scientifiche nonché il tipo di giustificazioni epistemiche che vengono usate dagli scienziati quando dicono, per esempio, che la teoria X è migliore di quella Y. Tali giustificazioni e logiche interne possono essere corrette o meno, quindi la filosofia della scienza è, almeno in parte, una disciplina normativa avente per oggetto i meccanismi interni delle varie scienze.
Insomma, il trio appena descritto - storia, sociologia, e filosofia della scienza - studia la scienza dal di fuori, e quindi non ha assolutamente senso chiedersi, come fanno Hawking e altri, perché tali discipline non abbiano contribuito a risolvere problemi scientifici. Non è il loro lavoro: è come chiedersi perché gli arbitri non fanno gol. Ma così come gli arbitri, per fare il proprio lavoro, devono tenersi al corrente di quello che succede nel mondo del calcio, così gli storici, sociologi, e filosofi della scienza devono tenersi al corrente di quello che fanno gli scienziati.
Analizziamo un esempio specifico per chiarire ulteriormente la situazione. Negli ultimi anni il mio campo della biologia evoluzionistica è stato caratterizzato da una serie di controversie interne riguardanti la struttura stessa della teoria evolutiva. La teoria fu proposta nella sua forma originale da Charles Darwin e Alfred Russell Wallace nel 1858. Fu poi modificata leggermente (i dettagli non hanno importanza in questo contesto) verso la fine del XIX secolo. Ulteriori modifiche, queste di maggiore portata, furono adottate dagli anni '20 agli anni '40 del secolo scorso. La versione risultante della teoria si chiama “Sintesi Moderna”, ed è, appunto, una sintesi della teoria originale e di una serie di teorie addizionali emergenti principalmente dalla genetica statistica.
Tuttavia, a partire da qualche decennio fa, una serie di biologi (incluso il sottoscritto) hanno cominciato a proporre un ulteriore ampliamento del darwinismo, spesso chiamato “Sintesi Estesa”, perché a nostro parere una serie di scoperte e nuove teorie hanno sufficientemente cambiato le carte in tavola da rendere necessario un ripensamento della Sintesi Moderna.
Mentre i biologi ne discutono, i filosofi della scienza stanno usando il caso in questione per approfondire le loro ipotesi su come cambiano le teorie scientifiche e su cosa conta come giustificazione epistemica sufficiente per catalizzare tali cambiamenti. Ovviamente, anche gli storici e i sociologi della scienza sono molto interessati a questo episodio: i primi paragonando il passaggio dal darwinismo alla Sintesi Moderna con il possibile passaggio da quest’ultima alla Sintesi Estesa, i secondi studiando le dinamiche di potere che caratterizzato la discussione (per esempio, il fatto che molti dei biologi che sostengono la Sintesi Estesa sono più giovani e quindi a stadi più iniziali della propria carriera).
Tutto ciò dovrebbe interessare gli scienziati stessi? Forse sì, forse no. Magari uno diventa un ottimo calciatore anche senza sapere nulla di ciò che succede nel mondo dell’arbitraggio. Magari però uno può essere calciatore eppure essere curioso riguardo alle dinamiche di mestieri limitrofi. Tutto sommato, gli arbitri non fanno gol, ma hanno il potere di annullarli, in certe condizioni…
Hawking si sbagliava clamorosamente, e in diversi aspetti. Primo, la filosofia decisamente non è morta. Non solo ogni anno i filosofi professionisti pubblicano migliaia di articoli tecnici su riviste specializzate, ma i libri di filosofia vendono bene in molti paesi, Italia inclusa. Secondo, i filosofi della scienza che conosco personalmente sanno più scienza di molti scienziati (anche se, ovviamente, non fanno scienza), per il semplice motivo che altrimenti non potrebbero lavorare nel campo della filosofia della scienza. Per esempio, una mia collega si specializza sia in filosofia della meccanica quantistica che in filosofia della relatività generale, cioè le due teorie portanti della fisica moderna. Per fare il suo lavoro, deve leggere in maniera molto più ampia dei fisici che si specializzano in quei due campi, e può permetterselo appunto perché non deve preoccuparsi di scrivere continuamente progetti di finanziamento per sovvenzionare la sua ricerca di laboratorio, né deve fare esperimenti complicati e costosissimi per poter pubblicare i suoi lavori.
E allora, uno potrebbe giustamente domandarsi, che fa, esattamente? Per poterlo capire forse è bene considerare tre campi di studio che si occupano di scienza ma non sono scienze: filosofia della scienza, storia della scienza, e sociologia della scienza. La storia della scienza, ovviamente, non è scienza. È storia. Gli storici della scienza non si pongono come obiettivo quello di risolvere problemi scientifici, come per esempio perché la meccanica quantistica e la relatività generale danno risposte diverse quando applicate ad alcuni problemi, come la fisica dei buchi neri. Gli storici si interessano, piuttosto, di come cambia la scienza stessa, della genesi di nuovi campi e nuove teorie, e anche del come e perché certe domande cessano di essere d’interesse per gli scienziati. Insomma, la storia della scienza è una disciplina descrittiva il cui oggetto di studio è la scienza stessa.
La sociologia della scienza, in maniera simile, tratta la scienza come un’attività umana, portata avanti da esseri umani e quindi caratterizzata da psicologie personali, relazioni interpersonali, e strutture di potere, sia interne (università, laboratori, e così via) che esterne (istituzioni che forniscono finanziamenti alla ricerca, organismi politici che determinano i limiti di tali finanziamenti, ecc.). Anche la sociologia della scienza, quindi, è una disciplina (principalmente) descrittiva che si pone le strutture organizzative della scienza come oggetto di studio.
Infine abbiamo la filosofia della scienza. Il suo scopo è capire la logica delle scoperte scientifiche nonché il tipo di giustificazioni epistemiche che vengono usate dagli scienziati quando dicono, per esempio, che la teoria X è migliore di quella Y. Tali giustificazioni e logiche interne possono essere corrette o meno, quindi la filosofia della scienza è, almeno in parte, una disciplina normativa avente per oggetto i meccanismi interni delle varie scienze.
Insomma, il trio appena descritto - storia, sociologia, e filosofia della scienza - studia la scienza dal di fuori, e quindi non ha assolutamente senso chiedersi, come fanno Hawking e altri, perché tali discipline non abbiano contribuito a risolvere problemi scientifici. Non è il loro lavoro: è come chiedersi perché gli arbitri non fanno gol. Ma così come gli arbitri, per fare il proprio lavoro, devono tenersi al corrente di quello che succede nel mondo del calcio, così gli storici, sociologi, e filosofi della scienza devono tenersi al corrente di quello che fanno gli scienziati.
Analizziamo un esempio specifico per chiarire ulteriormente la situazione. Negli ultimi anni il mio campo della biologia evoluzionistica è stato caratterizzato da una serie di controversie interne riguardanti la struttura stessa della teoria evolutiva. La teoria fu proposta nella sua forma originale da Charles Darwin e Alfred Russell Wallace nel 1858. Fu poi modificata leggermente (i dettagli non hanno importanza in questo contesto) verso la fine del XIX secolo. Ulteriori modifiche, queste di maggiore portata, furono adottate dagli anni '20 agli anni '40 del secolo scorso. La versione risultante della teoria si chiama “Sintesi Moderna”, ed è, appunto, una sintesi della teoria originale e di una serie di teorie addizionali emergenti principalmente dalla genetica statistica.
Tuttavia, a partire da qualche decennio fa, una serie di biologi (incluso il sottoscritto) hanno cominciato a proporre un ulteriore ampliamento del darwinismo, spesso chiamato “Sintesi Estesa”, perché a nostro parere una serie di scoperte e nuove teorie hanno sufficientemente cambiato le carte in tavola da rendere necessario un ripensamento della Sintesi Moderna.
Mentre i biologi ne discutono, i filosofi della scienza stanno usando il caso in questione per approfondire le loro ipotesi su come cambiano le teorie scientifiche e su cosa conta come giustificazione epistemica sufficiente per catalizzare tali cambiamenti. Ovviamente, anche gli storici e i sociologi della scienza sono molto interessati a questo episodio: i primi paragonando il passaggio dal darwinismo alla Sintesi Moderna con il possibile passaggio da quest’ultima alla Sintesi Estesa, i secondi studiando le dinamiche di potere che caratterizzato la discussione (per esempio, il fatto che molti dei biologi che sostengono la Sintesi Estesa sono più giovani e quindi a stadi più iniziali della propria carriera).
Tutto ciò dovrebbe interessare gli scienziati stessi? Forse sì, forse no. Magari uno diventa un ottimo calciatore anche senza sapere nulla di ciò che succede nel mondo dell’arbitraggio. Magari però uno può essere calciatore eppure essere curioso riguardo alle dinamiche di mestieri limitrofi. Tutto sommato, gli arbitri non fanno gol, ma hanno il potere di annullarli, in certe condizioni…
MASSIMO PIGLIUCCI è titolare della cattedra di filosofia K.D. Irani al City College of New York. Socio onorario CICAP, ha scritto tra l'altro Nonsense on Stilts (Chicago Press, 2018) e Come essere stoici (Garzanti, 2017). Il suo sito è: https:massimopigliucci.org