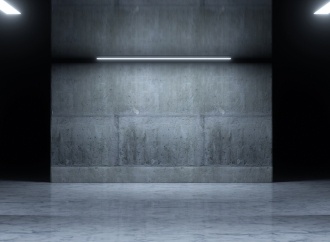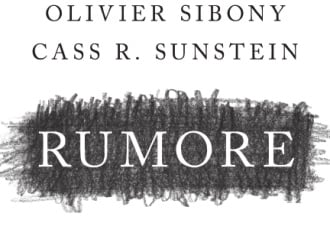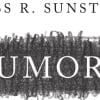Qualche tempo fa ho avuto un’interessante conversazione su Facebook a proposito dell’uso della parola “animalari”. Ne è nata qualche riflessione, che vorrei condividere in questa rubrica, su come affrontare le divergenze di opinioni.
Ma prima di tutto che cosa sono gli “animalari”, si chiederà qualcuno? I lettori di Query che frequentano Facebook probabilmente avranno già sentito questa parola. Per quei pochi eccentrici che ancora preferiscono la vita reale alle discussioni sui social network, “animalari” è l’espressione tra lo scherzoso e il dispregiativo con cui alcuni identificano coloro che in nome dell’animalismo sostengono idee assurde e antiscientifiche e arrivano a commettere atti violenti.
L’oggetto della discussione non erano le azioni degli “animalari”, dalle minacce di morte a chi fa sperimentazione sugli animali all’uso di immagini false e teorie pseudoscientifiche nelle campagne contro la “vivisezione”. Che questi comportamenti esistano e siano da condannare siamo tutti d’accordo, compresi molti animalisti che li considerano inaccettabili e controproducenti.
La questione che mi interessava, e che vorrei discutere in questo numero della rubrica, è un’altra: se usare etichette sarcastiche come “animalari”[1] sia un modo efficace ed eticamente corretto per affrontare le controversie e contrastare il fanatismo.
Io penso di no. In generale il dileggio e l’insulto non sono efficaci: servono a sfogare la rabbia e la frustrazione, ma non ad accreditarsi come obiettivi e imparziali di fronte a un pubblico che magari non ha un’idea precisa e vorrebbe sentire argomentazioni valide anziché scambi di insulti. Ma ho già pontificato a sufficienza su questo argomento[2] e non vorrei ritornarci: qui vorrei invece affrontare un altro aspetto specifico.
Nella mia chiacchierata su Facebook mi è stato obiettato che di solito chi usa la parola “animalari” non lo fa in pubblico, ma quando parla con amici, in un contesto ironico e con un linguaggio più rilassato. È un’osservazione corretta, che fa cadere il discorso dell’utilità nel dibattito pubblico, ma secondo me non chiude la questione. Rimane infatti aperto un altro punto.
Che cosa implica l’uso di etichette sarcastiche come questa, che venga esplicitato o meno? Ci sono due conseguenze negative, secondo me.
La prima è esasperare il conflitto. Un “animalaro”, che glielo dica in faccia oppure no, non è semplicemente qualcuno che, come me, ha idee giuste e sbagliate, e con il quale magari sono d’accordo su molti altri argomenti. È qualcuno che identifico in tutto e per tutto in base a quell’etichetta e che per definizione sta dalla parte del torto. Il confronto con questa persona non è più una normale discussione con torti e ragioni da entrambe le parti ma diventa una guerra tra la ragione e il torto... dove naturalmente io sto dalla parte giusta.
La seconda conseguenza è spostare il conflitto dal piano delle idee al piano personale: nel momento in cui considero qualcuno “animalaro” non gli sto chiedendo di cambiare idea su un singolo argomento, ma di abbandonare la propria identità di animalaro, di “convertirsi” a una visione differente.
Quanto è irritante che qualcun altro riduca tutta la mia complessa personalità a un singolo aspetto, per di più guardandomi con disprezzo e paternalismo? E quante probabilità ci sono che riesca a farmi cambiare idea? Se non è giusto e non funziona con me, perché dovrebbe essere giusto e funzionare con gli altri?
Si potrebbe ribattere che i veri interlocutori non sono gli estremisti, ma le persone ragionevoli; non gli “animalari” ma gli animalisti. Ammettiamo che sia così, ma questo non cambia i termini del problema: a che cosa serve classificare le persone con generalizzazioni discutibili? Serve a far capire che le loro idee sono sbagliate? Allora perché non criticare direttamente le idee?
Il fatto è che criticare le idee è molto più complicato. Stiamo parlando della validità scientifica della sperimentazione animale? o della sua sostenibilità etica? o delle condizioni in cui in pratica sono trattati gli animali da laboratorio? Si tratta il più delle volte di problemi complessi, che hanno una dimensione non solo scientifica ma anche etica e pratica, che bisogna affrontare per la civile convivenza. Questioni del genere difficilmente hanno una soluzione univoca; richiedono piuttosto una mediazione tra le diverse esigenze in gioco. Per esempio, si potrebbe trovare un accordo sulla sperimentazione animale per i nuovi farmaci ma non per i cosmetici o per i prodotti già abbondantemente testati, oppure si potrebbe cercare qualche altro compromesso.
Ecco che cosa succede se smetto di criticare le persone: non posso più cavarmela con uno slogan ma devo accettare una discussione alla pari, in cui l’obiettivo è quello di mettersi d’accordo su come stanno le cose e non semplicemente dimostrare che io ho ragione e l’altro ha torto. Certo, comincerò la discussione pensando che le mie idee siano giuste e quelle altrui siano sbagliate, ma se sono intellettualmente onesto sarò anche disposto a lasciarmi convincere che alcune delle mie idee possano essere sbagliate: altrimenti non sarebbe una discussione ma una trasmissione monodirezionale. Questo tra l’altro vale anche per il rapporto tra scienza e società: nell’attuale comunicazione della scienza è tramontata l'idea della comunicazione a senso unico in cui gli scienziati colmano il “deficit” di conoscenze dei cittadini e si è affermata, o dovrebbe averlo fatto, l’idea di uno scambio in cui ognuno ascolta le ragioni degli altri.
Se questo ragionamento non vi convince, provate a pensare che tutti noi abbiamo cambiato idea rispetto a qualcuna delle idee che avevamo in passato e che ora consideriamo sbagliata. Se siamo in grado di applicare il principio di induzione, dovrebbe esserci chiaro che anche nelle nostre idee attuali ce ne sono alcune che in futuro abbandoneremo perché sbagliate. Non possiamo sapere quali, altrimenti le avremmo già abbandonate. Quello che ci serve non è qualcuno che ci disprezzi perché non siamo perfetti, ma qualcuno che ci aiuti a capire perché certe nostre idee sono sbagliate. Tutto qui. È la stessa cosa di cui hanno bisogno gli altri.
Insomma, pensare che il mondo si divida in “animalari” e persone ragionevoli non aiuta a convincere gli altri, anzi crea una divisione artificiale che ostacola la comprensione reciproca.
Allora perché viene così spontaneo usare queste etichette? Per essere sincero, credo che il desiderio di classificare le persone non risponda a un’esigenza razionale, ma puramente emotiva: mi permette di fare ordine (per quanto illusorio) in una realtà complessa, mi rassicura sul fatto che il mio gruppo ha ragione e l’altro gruppo ha torto, mi dà un senso di superiorità e mi risparmia il faticoso compito di andare a vedere di volta in volta come stanno le cose. Ma è tutto il contrario dello spirito critico. Chi vuole esercitare lo spirito critico non può ragionare per schieramenti, altrimenti farebbe come i seguaci di Brian di Nazareth nel film dei Monty Python, che ripetono tutti in coro «Siamo tutti degli individui!» e «Ognuno di noi è diverso!»
Concentrarsi sulle idee anziché sulle persone secondo me ha un doppio vantaggio: non solo permette di criticare le opinioni degli altri in modo più costruttivo, ma dà anche la possibilità di essere più aperti al loro punto di vista e, di conseguenza, di imparare qualcosa di nuovo.
Ma prima di tutto che cosa sono gli “animalari”, si chiederà qualcuno? I lettori di Query che frequentano Facebook probabilmente avranno già sentito questa parola. Per quei pochi eccentrici che ancora preferiscono la vita reale alle discussioni sui social network, “animalari” è l’espressione tra lo scherzoso e il dispregiativo con cui alcuni identificano coloro che in nome dell’animalismo sostengono idee assurde e antiscientifiche e arrivano a commettere atti violenti.
L’oggetto della discussione non erano le azioni degli “animalari”, dalle minacce di morte a chi fa sperimentazione sugli animali all’uso di immagini false e teorie pseudoscientifiche nelle campagne contro la “vivisezione”. Che questi comportamenti esistano e siano da condannare siamo tutti d’accordo, compresi molti animalisti che li considerano inaccettabili e controproducenti.
La questione che mi interessava, e che vorrei discutere in questo numero della rubrica, è un’altra: se usare etichette sarcastiche come “animalari”[1] sia un modo efficace ed eticamente corretto per affrontare le controversie e contrastare il fanatismo.
Io penso di no. In generale il dileggio e l’insulto non sono efficaci: servono a sfogare la rabbia e la frustrazione, ma non ad accreditarsi come obiettivi e imparziali di fronte a un pubblico che magari non ha un’idea precisa e vorrebbe sentire argomentazioni valide anziché scambi di insulti. Ma ho già pontificato a sufficienza su questo argomento[2] e non vorrei ritornarci: qui vorrei invece affrontare un altro aspetto specifico.
Nella mia chiacchierata su Facebook mi è stato obiettato che di solito chi usa la parola “animalari” non lo fa in pubblico, ma quando parla con amici, in un contesto ironico e con un linguaggio più rilassato. È un’osservazione corretta, che fa cadere il discorso dell’utilità nel dibattito pubblico, ma secondo me non chiude la questione. Rimane infatti aperto un altro punto.
Che cosa implica l’uso di etichette sarcastiche come questa, che venga esplicitato o meno? Ci sono due conseguenze negative, secondo me.
La prima è esasperare il conflitto. Un “animalaro”, che glielo dica in faccia oppure no, non è semplicemente qualcuno che, come me, ha idee giuste e sbagliate, e con il quale magari sono d’accordo su molti altri argomenti. È qualcuno che identifico in tutto e per tutto in base a quell’etichetta e che per definizione sta dalla parte del torto. Il confronto con questa persona non è più una normale discussione con torti e ragioni da entrambe le parti ma diventa una guerra tra la ragione e il torto... dove naturalmente io sto dalla parte giusta.
La seconda conseguenza è spostare il conflitto dal piano delle idee al piano personale: nel momento in cui considero qualcuno “animalaro” non gli sto chiedendo di cambiare idea su un singolo argomento, ma di abbandonare la propria identità di animalaro, di “convertirsi” a una visione differente.
Quanto è irritante che qualcun altro riduca tutta la mia complessa personalità a un singolo aspetto, per di più guardandomi con disprezzo e paternalismo? E quante probabilità ci sono che riesca a farmi cambiare idea? Se non è giusto e non funziona con me, perché dovrebbe essere giusto e funzionare con gli altri?
Si potrebbe ribattere che i veri interlocutori non sono gli estremisti, ma le persone ragionevoli; non gli “animalari” ma gli animalisti. Ammettiamo che sia così, ma questo non cambia i termini del problema: a che cosa serve classificare le persone con generalizzazioni discutibili? Serve a far capire che le loro idee sono sbagliate? Allora perché non criticare direttamente le idee?
Il fatto è che criticare le idee è molto più complicato. Stiamo parlando della validità scientifica della sperimentazione animale? o della sua sostenibilità etica? o delle condizioni in cui in pratica sono trattati gli animali da laboratorio? Si tratta il più delle volte di problemi complessi, che hanno una dimensione non solo scientifica ma anche etica e pratica, che bisogna affrontare per la civile convivenza. Questioni del genere difficilmente hanno una soluzione univoca; richiedono piuttosto una mediazione tra le diverse esigenze in gioco. Per esempio, si potrebbe trovare un accordo sulla sperimentazione animale per i nuovi farmaci ma non per i cosmetici o per i prodotti già abbondantemente testati, oppure si potrebbe cercare qualche altro compromesso.
Ecco che cosa succede se smetto di criticare le persone: non posso più cavarmela con uno slogan ma devo accettare una discussione alla pari, in cui l’obiettivo è quello di mettersi d’accordo su come stanno le cose e non semplicemente dimostrare che io ho ragione e l’altro ha torto. Certo, comincerò la discussione pensando che le mie idee siano giuste e quelle altrui siano sbagliate, ma se sono intellettualmente onesto sarò anche disposto a lasciarmi convincere che alcune delle mie idee possano essere sbagliate: altrimenti non sarebbe una discussione ma una trasmissione monodirezionale. Questo tra l’altro vale anche per il rapporto tra scienza e società: nell’attuale comunicazione della scienza è tramontata l'idea della comunicazione a senso unico in cui gli scienziati colmano il “deficit” di conoscenze dei cittadini e si è affermata, o dovrebbe averlo fatto, l’idea di uno scambio in cui ognuno ascolta le ragioni degli altri.
Se questo ragionamento non vi convince, provate a pensare che tutti noi abbiamo cambiato idea rispetto a qualcuna delle idee che avevamo in passato e che ora consideriamo sbagliata. Se siamo in grado di applicare il principio di induzione, dovrebbe esserci chiaro che anche nelle nostre idee attuali ce ne sono alcune che in futuro abbandoneremo perché sbagliate. Non possiamo sapere quali, altrimenti le avremmo già abbandonate. Quello che ci serve non è qualcuno che ci disprezzi perché non siamo perfetti, ma qualcuno che ci aiuti a capire perché certe nostre idee sono sbagliate. Tutto qui. È la stessa cosa di cui hanno bisogno gli altri.
Insomma, pensare che il mondo si divida in “animalari” e persone ragionevoli non aiuta a convincere gli altri, anzi crea una divisione artificiale che ostacola la comprensione reciproca.
Allora perché viene così spontaneo usare queste etichette? Per essere sincero, credo che il desiderio di classificare le persone non risponda a un’esigenza razionale, ma puramente emotiva: mi permette di fare ordine (per quanto illusorio) in una realtà complessa, mi rassicura sul fatto che il mio gruppo ha ragione e l’altro gruppo ha torto, mi dà un senso di superiorità e mi risparmia il faticoso compito di andare a vedere di volta in volta come stanno le cose. Ma è tutto il contrario dello spirito critico. Chi vuole esercitare lo spirito critico non può ragionare per schieramenti, altrimenti farebbe come i seguaci di Brian di Nazareth nel film dei Monty Python, che ripetono tutti in coro «Siamo tutti degli individui!» e «Ognuno di noi è diverso!»
Concentrarsi sulle idee anziché sulle persone secondo me ha un doppio vantaggio: non solo permette di criticare le opinioni degli altri in modo più costruttivo, ma dà anche la possibilità di essere più aperti al loro punto di vista e, di conseguenza, di imparare qualcosa di nuovo.
Note
1) Ma lo stesso ragionamento vale in molti altri campi, come la difesa dell’ambiente, le scelte alimentari, e così via.
2) “Non facciamo i cretini!” in Query n. 10, estate 2012