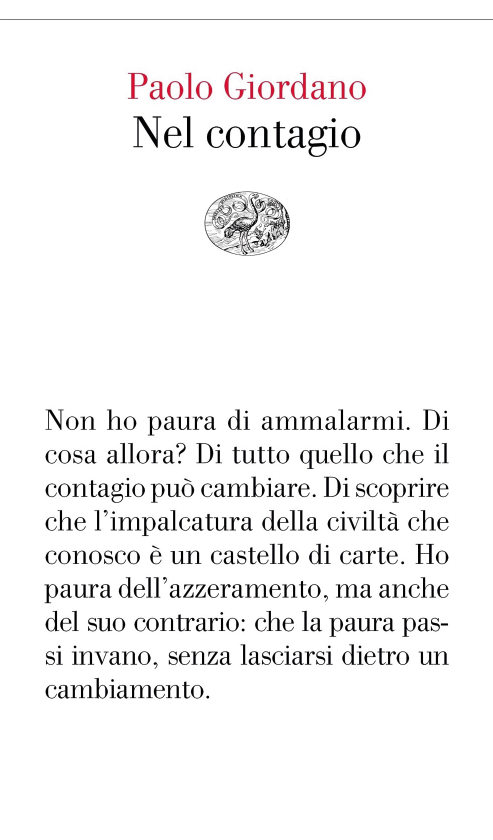Sulla pandemia e sulla conseguente situazione di grande incertezza hai riflettuto molto e fatto dell’ottima divulgazione, prima con una serie di articoli sul Corriere della Sera, poi con interventi televisivi e alla radio, e infine con un libro, Nel contagio, uscito con Einaudi. Non solo hai raccontato in tempo reale quello che stavamo vivendo, ma hai anche dato uno sguardo letterario e scientifico alla situazione, attento alla vita delle persone ma sempre ancorato ai dati. Come è nata l’esigenza di raccontare il contagio?
Ci sono momenti in cui non avere il tempo di pensare ti aiuta a pensare, perché diventa un passaggio istintivo necessario anche al racconto. Mi è successo un anno e mezzo fa, quando seguivo le notizie sparse che arrivavano quotidianamente sull’inizio dell’epidemia in Cina, e quando alla fine di febbraio è stato chiaro che l’epidemia era arrivata da noi: in quel momento non ho avuto il tempo di pensare, e quindi senza pensare ho reagito. Ho scritto un primo articolo sul Corriere della sera in uno stato quasi febbrile; ero molto suggestionato da quello che stava succedendo. L’articolo introduceva il parametro R0 con cui saremmo diventati tristemente familiari e che avrebbe addirittura gestito le nostre vite e la nostra libertà. Ho pensato di cominciare da quello perché mi sembrava un elemento semplice, simbolico ma molto specifico per capire cosa stava succedendo e cosa ci veniva richiesto.
È strano come le cose che hai letto o scritto negli anni ti vengono in soccorso. L’atto stesso della scrittura, così come della lettura, prepara a eventualità di vita anche strane. Mi sono reso conto solo con il tempo che la vera preparazione al parlare di pandemia mi era venuta dallo scrivere il romanzo Divorare il cielo. Al centro della storia c’è un’epidemia (anche se molto diversa), l’epidemia di Xylella che ha colpito gli olivi in Puglia. Studiarla e starci immerso nei molti anni in cui ho lavorato al libro, mi ha fatto osservare in modo molto meno drammatico molte delle dinamiche che si creano attorno a un fenomeno simile: comunicazione scientifica faticosa, scontri ideologici, paure, complottismi. Perciò, quando l’emergenza del nuovo coronavirus è diventata tristemente umana, mi sono reso conto che senza saperlo mi ero preparato scrivendo un romanzo che parlava di alberi.
Nei tuoi articoli e nel libro si sente anche la tua formazione scientifica. Ritorna costantemente e in maniera naturale la matematica, che a molti appare ostica; o come l’hai chiamata, la matematica del contagio. Scrivi anche che la matematica rappresenta la tua via di fuga nei momenti di angoscia.
Come tutti, credo, sono sempre in balia delle maree dell’ansia: quell’ansia quotidiana senza molto costrutto. Uno dei modi istintivi con cui la tengo a freno è mettere in ordine qualcosa; riordino maniacalmente lo studio, la libreria, i documenti e gli oggetti per casa, solo perché è un modo per calmarmi. Nella mia mente qualcosa di simile succede facendo certi calcoli matematici o capendo certe teorie matematiche. C’è sempre un senso di ordine nel caos che la matematica, almeno a me, trasmette. Non sempre: durante gli anni dell’università, quando affrontavo corsi più difficili, a volte la matematica era paralizzante se non riuscivo a capirla. Invece la matematica che sento di governare mi tranquillizza.
Con l’inizio della pandemia sappiamo quanto senso di smarrimento e disordine abbiamo sentito tutti. All’improvviso abbiamo avuto bisogno di padroneggiare tante discipline diverse, e com’era prevedibile abbiamo rivolto moltissima attenzione alle materie mediche e biologiche. Soprattutto nei primi mesi, però, uno strumento ancora più forte per astrarci dalla paura individuale e capire cosa stava succedendo alla popolazione è stata proprio la matematica, o meglio: l’epidemiologia basata su concetti matematici abbastanza semplici.
Questo modo di considerare il contagio come qualcosa che riguarda grandi numeri e statistiche è ancora una delle chiavi di lettura più necessarie. Nei mesi ho capito che rapportarsi alla statistica è stata una delle difficoltà maggiori per tutti noi: è difficile capire che certe verità istintive, valide per noi singole persone, non sono estrapolabili alla popolazione intera o ai grandi numeri. Anzi, a volte nel comportamento collettivo da mantenere valgono regole controintuitive, come abbiamo visto prima con il distanziamento e le mascherine, poi ancora di più coi vaccini. Ma per me è questo il tipo di ragionamento proprio della matematica: non un sapere avanzato, ma l’attitudine all’astrarre dal proprio circondario un modo di ragionare che ci tiene in considerazione come molteplicità e moltitudine.
Dicevi che mettere in ordine ti aiuta a calmare l’ansia. Lo facciamo un po’ tutti: andiamo alla ricerca di ordine, di significato, di un collegamento tra le cose, e lo troviamo dappertutto, anche quando non c’è. Soprattutto in una situazione di incertezza.
In questo c’è stata spesso, secondo me, anche una visione distorta della matematica del contagio, che per noi si è ridotta moltissimo a contabilità del contagio. Certo, anche quella è importante: ci ha dato la misura sia di quanto potevamo essere o meno sicuri, sia soprattutto della reale tragedia che abbiamo vissuto in certi momenti: in Italia abbiamo avuto proporzioni numeriche in assoluto molto gravi, e se guardiamo adesso al resto del mondo non c’è di che essere troppo sollevati. Ma concentrandoci sulla contabilità abbiamo perso talvolta l’idea della matematica come studio delle interazioni e relazioni tra i vari elementi, che invece sono esattamente ciò che muove il contagio e ciò che ci permette di affrontarlo.
Quando si trovano significati dove non esistono, fioriscono le falsità e le teorie del complotto. Con la pandemia questo è stato un elemento costante, soprattutto nei primi mesi, ma continua ancora oggi.
Andando a cercare analogie con altre epidemie del passato, come la poliomielite e la peste, viene fuori che il moltiplicarsi delle teorie del complotto durante i periodi di epidemia è una costante storica. Deve esserci per forza qualcosa che lega una situazione del genere alla nostra tendenza a cercare spiegazioni alternative. È successo anche con la Xylella, in modo minore ma comunque drammatico per un territorio: le teorie del complotto non solo sono state un sottofondo, ma hanno agito decisamente col risultato di frenare e osteggiare molto le misure che si sarebbero dovute adottare. Si è detto di tutto: che gli ulivi morissero a causa di trattamenti sbagliati, che il batterio fosse stato introdotto volutamente per fare spazio a campi da golf o altre colture. Questo chiaramente ha creato sfiducia in gran parte della popolazione che poi è diventata ostile ai comportamenti da seguire. Con la COVID abbiamo visto la stessa cosa, ma su scala molto più allargata.
Ricercando questa sottile connessione fra epidemie e psiche emerge qualcosa di molto ragionevole: laddove c’è molta confusione, disordine, un’assenza apparente di disegno, la nostra mente tende a inventarsi delle forme. Esistono studi psicologici in merito. Vediamo formule dove non ci sono perché abbiamo bisogno di dare una traiettoria a un momento spaventoso e confusionario; in questo, le teorie del complotto funzionano come una consolazione rispetto all’apparente mancanza di senso e di costrutto.
Stavolta sono state particolarmente striscianti. Durante il primo lockdown moltissimi complottismi giravano su Whatsapp, che era un mezzo piuttosto nuovo e subdolo. Infatti finché le notizie false, tendenziose o poco verificate girano su Facebook o Twitter c’è un’apparenza possibile di contraddittorio, esiste un confronto per quanto molto limitato. Se girano su Whatsapp vuol dire che ti arrivano da persone vicine, alle quali istintivamente attribuisci una veridicità maggiore. Penso che l’infodemia che si è associata alla pandemia di COVID sia uno degli elementi su cui dovremmo soffermarci di più, anche quando il lato sanitario sarà risolto, perché riguarda veramente tutti gli ambiti e sarà sempre più esasperato ogni volta che si presenteranno situazioni analoghe. Siamo suscettibili in modo pericolosissimo al contagio da false informazioni.
Tra le tante cose che ci devono spaventare, hai segnalato l’idea che tutta la situazione attuale passi senza lasciarsi dietro un cambiamento autentico. Ma è davvero possibile che tutto torni come prima?
È dall’inizio che oscilliamo su questa idea. Dopo un anno e mezzo, mi limito a osservare come l’inerzia del nostro modo di vivere precedente sia molto forte. Questa interruzione che ci è parsa lunghissima, in realtà, risulta forse insufficiente a inaugurare cambiamenti sostanziali in un arco globale di vita. Secondo me è importante non attribuire troppo moralismo all’idea del cambiamento: perché mai un’epidemia dovrebbe essere portatrice di un cambiamento morale?
Ci sono però elementi insostenibili del nostro stile di vita che conoscevamo da prima, dato che in ambito scientifico se ne parla e straparla ma che faticano ad arrivare a tutti gli strati della popolazione. Forse la pandemia dovrebbe avere come esito almeno quello di mostrare questi livelli di insostenibilità: di mostrare cioè che lo stile di vita a cui siamo abituati (con il percorso di velocizzazione, di esasperato aumento dei contatti e della mobilità, di sfruttamento delle risorse naturali e via dicendo) non è l’unico possibile e inevitabile. In fondo fino a un mese prima era impensabile quello che è successo nel marzo 2020, o le limitazioni che esistono tuttora. Se già questo diventa un precedente, e se riusciamo a unirlo con la comunicazione e qualche altro elemento, forse un inizio di cambiamento è possibile.
Tuttavia mi dispiace vedere che si è sprecata una grande occasione per parlare di paradigmi in tutto questo. Quando ho scritto Nel contagio a marzo 2020, ho visto nella tragedia che stava iniziando anche una possibile finestra per parlare di tematiche più grandi e interconnesse, e ci sarebbe stato lo spazio per farlo. Almeno in Italia, invece, siamo stati completamente assorbiti dall’emergenza, addirittura con un eccesso informativo. Forse abbiamo tutti perso un’occasione per inaugurare qualche discorso di più lungo respiro.
Vediamo che molti hanno ancora difficoltà a rispettare regole basilari per contenere la diffusione del virus; vivono tutto come una privazione di libertà, senza rendersi conto che non possiamo più pensare solo al nostro interesse personale, ma che siamo parte di qualcosa di più grande. Come mai molte persone continuano ad affrontarla così?
Questo sì che è un cambio di paradigma enorme e molto difficile da assorbire. Sarò pessimista, ma credo che questo nuovo pensiero non troverà terreno fertile in noi adulti. C’è da augurarsi che si insinui invece nell’esperienza dei più giovani, in chi cioè ha vissuto la pandemia in un’età molto più fertile per la formazione di una visione del mondo. Questo mi sembra il portato politico-filosofico in assoluto più dirompente della pandemia.
Mai come oggi generazioni come le nostre hanno vissuto una tale torsione estrema tra l’esperienza individuale e quella collettiva. Come tutti, anch’io sono cresciuto nell’idea implicita che la mia missione fosse di impegnarmi per me stesso in modo serio e onesto, e che così facendo la collettività ne avrebbe indirettamente beneficiato. All’improvviso è arrivata la pandemia, ovvero una situazione radicalmente diversa in cui quell’idea non è più sufficiente: abbiamo dovuto pensare a noi stessi e contemporaneamente alla collettività, fare sacrifici individuali perché avessero una ripercussione collettiva. Non ci siamo abituati. Incidentalmente, sarebbe anche il tipo di pensiero di cui avremmo bisogno per affrontare emergenze ancora più complesse, come il cambiamento climatico e le migrazioni che ne seguiranno. Non so se riusciremo a farlo nostro, per noi adulti sarà molto difficile. Di sicuro, però, questa esperienza segna un cambiamento istintivo nella formazione dei giovanissimi; può darsi quindi che in loro questo nuovo pensiero politico diventi sostanziale.
Nella comunicazione della pandemia si sono viste le differenze di vedute fra scienziati e gli errori che sono stati fatti, inevitabilmente, trattandosi di un fenomeno al quale non eravamo preparati. Ma spesso ci si dimentica che nessuno può dare certezze e soluzioni pronte, come invece a volte viene richiesto agli scienziati. Questa mancanza di consapevolezza di come funziona la scienza contribuisce ad aumentare il rumore.
Gli scienziati proprio non le avevano, le certezze. Forse oggi, vista a distanza, è ancora più straordinaria la situazione che abbiamo vissuto. Tutti noi siamo cresciuti con l’idea quasi ovvia che, se ci coglie un male di qualche tipo, sia minore che grave, esiste comunque un protocollo da seguire: esistono esami, cure, medicinali; si consulta questo o quel medico. Invece, da una settimana all’altra, ci ritroviamo alle prese tutti quanti con un virus tecnicamente nuovo per la specie umana e per il quale all’inizio non esistono cure, né vaccini, né protocolli. Ancora peggio: non conosciamo lo spettro dei possibili sintomi e dei possibili esiti, non sappiamo come impatta su diversi tipi di persone, non sappiamo niente. Questo tipo di non-conoscenza è un altro elemento nuovo e imprevisto, seppure forse prevedibile. Credo che in quei primi mesi tutte le reazioni delle persone siano state comprensibili.
Poi in meno di un anno (e devo dire che non me lo sarei aspettato) ci ritroviamo con non uno, ma più vaccini in distribuzione, e con protocolli di cura che diventano sempre più efficienti. Tutto ciò è avvenuto sotto i nostri occhi, mentre noi eravamo bloccati e un po’ impauriti. È stato molto strano assistere a un progresso scientifico che ci si dipanava davanti con tutte le correzioni in corsa, i tentativi, gli errori e le false piste. Abbiamo visto un’azione straordinaria, anche per me che non sono un fanatico scientista: gli sforzi mondiali della comunità scientifica in vari campi si sono concentrati su un problema trovandone le possibili vie d’uscita in pochissimo tempo. Dovremmo riflettere molto sulla nostra scarsa propensione ad ammettere una realtà che qualunque scienziato conosce bene, e i fisici ancora di più: cioè che qualsiasi azione, misura o verità è accompagnata dalla sua incertezza. La comunicazione di quell’incertezza è importante tanto quanto il dato in sé a livello informativo. Questo sarebbe un altro cambiamento intero di pensiero, se entrasse nel nostro sentire.
Nel tuo libro Nel contagio sollevi un concetto importantissimo: siamo portati a pensare che i virus, e quest’epidemia in particolare, per qualche motivo inspiegabile abbiano preso di mira gli esseri umani. Le cose però non stanno proprio così.
Dare intenzioni al virus è una strada molto invitante e molto pericolosa. Io stesso, soprattutto nelle prime settimane, quando scrivevo gli articoli o una prima stesura del saggio, mi accorgevo che ogni tanto mi scappava la tentazione di personificare il virus e di dargli addirittura un’intenzione implicita. E ogni volta rileggendo evitavo questo passaggio, attuando una forma di igiene di pensiero che ritengo molto importante.
Abbiamo bisogno di vedere in questo virus il nemico invisibile. Tutto il lessico bellico che abbiamo usato, e che ci serviva forse a fomentare gli animi e spingerci alla mobilitazione, in realtà a livello di pensiero scientifico diffuso non ci fa così bene; pone infatti un’alterità di principio tra noi e il mondo naturale. Virus e batteri non sono nemici votati, ma fanno parte di un ecosistema in cui ci siamo anche noi, e in cui siamo noi probabilmente gli ospiti più invadenti. Attraverso i nostri stili di vita e la nostra spinta verso il progresso andiamo a perturbare moltissimi ambiti ecologici in cui esistono potenziali minacce, e spingiamo specie all’adattamento anche a nostre spese. Questi ragionamenti più complessi, purtroppo, sono stati spesso falciati dall’idea di esseri a noi nemici. Il virus però non è un alieno che ci attacca: il virus è parte di questo mondo, esattamente come noi.
Oltre a questo, sin dall’inizio (lo riporto già nel mio saggio di marzo 2020) c’è stata la doppia ipotesi sull’origine del virus: quella per così dire ecologica che voleva un’origine naturale, com’era stato per la SARS 1, e quella della fuga dal laboratorio di Wuhan. Per una questione di probabilità e di evidenze disponibili propendo sempre per la via che si è già verificata in natura moltissime volte, ovvero lo spillover tra specie. Nel corso dei mesi, tuttavia, ha guadagnato quanto meno enfasi mediatica e istituzionale l’ipotesi di un’origine antropica, con l’idea di verificare se non sia coinvolta qualche sperimentazione, come quelle che vengono davvero fatte sui coronavirus. È una questione molto complicata; di fatto a oggi, mentre parlo, non esistono evidenze né da una parte né dall’altra, e siamo dunque in una situazione di totale indecidibilità.
La mia impressione è che non lo sapremo; mi sembra molto difficile che a un certo punto troveremo la pistola fumante dell’origine del virus, poiché il campo è già troppo inquinato da ovvie complicazioni politiche. Se anche dovesse succedere, se anche venisse fuori che invece c’è una componente legata alla sperimentazione, è importante ricordarsi che questo non cambia le considerazioni sul rapporto tra possibili nuovi patogeni da un lato, e civilizzazione e stili di vita umani dall’altro. I nostri comportamenti che turbano gli ecosistemi restano una fonte di possibili minacce pandemiche.
Per finire, c’è qualcosa che ti aspetti, o che speri che ci resti, da tutta questa esperienza?
Spero che resti il tratto di vulnerabilità che abbiamo scoperto, che sporca un po’ l’eccessiva tracotanza che abbiamo. Una vulnerabilità non solo a livello personale, ma anche come civilizzazione; non solo come cittadini, ma anche come scienziati. Se ne rimanesse qualcosa, sarebbe già un grandissimo traguardo.
Ci sono momenti in cui non avere il tempo di pensare ti aiuta a pensare, perché diventa un passaggio istintivo necessario anche al racconto. Mi è successo un anno e mezzo fa, quando seguivo le notizie sparse che arrivavano quotidianamente sull’inizio dell’epidemia in Cina, e quando alla fine di febbraio è stato chiaro che l’epidemia era arrivata da noi: in quel momento non ho avuto il tempo di pensare, e quindi senza pensare ho reagito. Ho scritto un primo articolo sul Corriere della sera in uno stato quasi febbrile; ero molto suggestionato da quello che stava succedendo. L’articolo introduceva il parametro R0 con cui saremmo diventati tristemente familiari e che avrebbe addirittura gestito le nostre vite e la nostra libertà. Ho pensato di cominciare da quello perché mi sembrava un elemento semplice, simbolico ma molto specifico per capire cosa stava succedendo e cosa ci veniva richiesto.
È strano come le cose che hai letto o scritto negli anni ti vengono in soccorso. L’atto stesso della scrittura, così come della lettura, prepara a eventualità di vita anche strane. Mi sono reso conto solo con il tempo che la vera preparazione al parlare di pandemia mi era venuta dallo scrivere il romanzo Divorare il cielo. Al centro della storia c’è un’epidemia (anche se molto diversa), l’epidemia di Xylella che ha colpito gli olivi in Puglia. Studiarla e starci immerso nei molti anni in cui ho lavorato al libro, mi ha fatto osservare in modo molto meno drammatico molte delle dinamiche che si creano attorno a un fenomeno simile: comunicazione scientifica faticosa, scontri ideologici, paure, complottismi. Perciò, quando l’emergenza del nuovo coronavirus è diventata tristemente umana, mi sono reso conto che senza saperlo mi ero preparato scrivendo un romanzo che parlava di alberi.
Nei tuoi articoli e nel libro si sente anche la tua formazione scientifica. Ritorna costantemente e in maniera naturale la matematica, che a molti appare ostica; o come l’hai chiamata, la matematica del contagio. Scrivi anche che la matematica rappresenta la tua via di fuga nei momenti di angoscia.
Come tutti, credo, sono sempre in balia delle maree dell’ansia: quell’ansia quotidiana senza molto costrutto. Uno dei modi istintivi con cui la tengo a freno è mettere in ordine qualcosa; riordino maniacalmente lo studio, la libreria, i documenti e gli oggetti per casa, solo perché è un modo per calmarmi. Nella mia mente qualcosa di simile succede facendo certi calcoli matematici o capendo certe teorie matematiche. C’è sempre un senso di ordine nel caos che la matematica, almeno a me, trasmette. Non sempre: durante gli anni dell’università, quando affrontavo corsi più difficili, a volte la matematica era paralizzante se non riuscivo a capirla. Invece la matematica che sento di governare mi tranquillizza.
Con l’inizio della pandemia sappiamo quanto senso di smarrimento e disordine abbiamo sentito tutti. All’improvviso abbiamo avuto bisogno di padroneggiare tante discipline diverse, e com’era prevedibile abbiamo rivolto moltissima attenzione alle materie mediche e biologiche. Soprattutto nei primi mesi, però, uno strumento ancora più forte per astrarci dalla paura individuale e capire cosa stava succedendo alla popolazione è stata proprio la matematica, o meglio: l’epidemiologia basata su concetti matematici abbastanza semplici.
Questo modo di considerare il contagio come qualcosa che riguarda grandi numeri e statistiche è ancora una delle chiavi di lettura più necessarie. Nei mesi ho capito che rapportarsi alla statistica è stata una delle difficoltà maggiori per tutti noi: è difficile capire che certe verità istintive, valide per noi singole persone, non sono estrapolabili alla popolazione intera o ai grandi numeri. Anzi, a volte nel comportamento collettivo da mantenere valgono regole controintuitive, come abbiamo visto prima con il distanziamento e le mascherine, poi ancora di più coi vaccini. Ma per me è questo il tipo di ragionamento proprio della matematica: non un sapere avanzato, ma l’attitudine all’astrarre dal proprio circondario un modo di ragionare che ci tiene in considerazione come molteplicità e moltitudine.
Dicevi che mettere in ordine ti aiuta a calmare l’ansia. Lo facciamo un po’ tutti: andiamo alla ricerca di ordine, di significato, di un collegamento tra le cose, e lo troviamo dappertutto, anche quando non c’è. Soprattutto in una situazione di incertezza.
In questo c’è stata spesso, secondo me, anche una visione distorta della matematica del contagio, che per noi si è ridotta moltissimo a contabilità del contagio. Certo, anche quella è importante: ci ha dato la misura sia di quanto potevamo essere o meno sicuri, sia soprattutto della reale tragedia che abbiamo vissuto in certi momenti: in Italia abbiamo avuto proporzioni numeriche in assoluto molto gravi, e se guardiamo adesso al resto del mondo non c’è di che essere troppo sollevati. Ma concentrandoci sulla contabilità abbiamo perso talvolta l’idea della matematica come studio delle interazioni e relazioni tra i vari elementi, che invece sono esattamente ciò che muove il contagio e ciò che ci permette di affrontarlo.
Quando si trovano significati dove non esistono, fioriscono le falsità e le teorie del complotto. Con la pandemia questo è stato un elemento costante, soprattutto nei primi mesi, ma continua ancora oggi.
Andando a cercare analogie con altre epidemie del passato, come la poliomielite e la peste, viene fuori che il moltiplicarsi delle teorie del complotto durante i periodi di epidemia è una costante storica. Deve esserci per forza qualcosa che lega una situazione del genere alla nostra tendenza a cercare spiegazioni alternative. È successo anche con la Xylella, in modo minore ma comunque drammatico per un territorio: le teorie del complotto non solo sono state un sottofondo, ma hanno agito decisamente col risultato di frenare e osteggiare molto le misure che si sarebbero dovute adottare. Si è detto di tutto: che gli ulivi morissero a causa di trattamenti sbagliati, che il batterio fosse stato introdotto volutamente per fare spazio a campi da golf o altre colture. Questo chiaramente ha creato sfiducia in gran parte della popolazione che poi è diventata ostile ai comportamenti da seguire. Con la COVID abbiamo visto la stessa cosa, ma su scala molto più allargata.
Ricercando questa sottile connessione fra epidemie e psiche emerge qualcosa di molto ragionevole: laddove c’è molta confusione, disordine, un’assenza apparente di disegno, la nostra mente tende a inventarsi delle forme. Esistono studi psicologici in merito. Vediamo formule dove non ci sono perché abbiamo bisogno di dare una traiettoria a un momento spaventoso e confusionario; in questo, le teorie del complotto funzionano come una consolazione rispetto all’apparente mancanza di senso e di costrutto.
Stavolta sono state particolarmente striscianti. Durante il primo lockdown moltissimi complottismi giravano su Whatsapp, che era un mezzo piuttosto nuovo e subdolo. Infatti finché le notizie false, tendenziose o poco verificate girano su Facebook o Twitter c’è un’apparenza possibile di contraddittorio, esiste un confronto per quanto molto limitato. Se girano su Whatsapp vuol dire che ti arrivano da persone vicine, alle quali istintivamente attribuisci una veridicità maggiore. Penso che l’infodemia che si è associata alla pandemia di COVID sia uno degli elementi su cui dovremmo soffermarci di più, anche quando il lato sanitario sarà risolto, perché riguarda veramente tutti gli ambiti e sarà sempre più esasperato ogni volta che si presenteranno situazioni analoghe. Siamo suscettibili in modo pericolosissimo al contagio da false informazioni.
Tra le tante cose che ci devono spaventare, hai segnalato l’idea che tutta la situazione attuale passi senza lasciarsi dietro un cambiamento autentico. Ma è davvero possibile che tutto torni come prima?
È dall’inizio che oscilliamo su questa idea. Dopo un anno e mezzo, mi limito a osservare come l’inerzia del nostro modo di vivere precedente sia molto forte. Questa interruzione che ci è parsa lunghissima, in realtà, risulta forse insufficiente a inaugurare cambiamenti sostanziali in un arco globale di vita. Secondo me è importante non attribuire troppo moralismo all’idea del cambiamento: perché mai un’epidemia dovrebbe essere portatrice di un cambiamento morale?
Ci sono però elementi insostenibili del nostro stile di vita che conoscevamo da prima, dato che in ambito scientifico se ne parla e straparla ma che faticano ad arrivare a tutti gli strati della popolazione. Forse la pandemia dovrebbe avere come esito almeno quello di mostrare questi livelli di insostenibilità: di mostrare cioè che lo stile di vita a cui siamo abituati (con il percorso di velocizzazione, di esasperato aumento dei contatti e della mobilità, di sfruttamento delle risorse naturali e via dicendo) non è l’unico possibile e inevitabile. In fondo fino a un mese prima era impensabile quello che è successo nel marzo 2020, o le limitazioni che esistono tuttora. Se già questo diventa un precedente, e se riusciamo a unirlo con la comunicazione e qualche altro elemento, forse un inizio di cambiamento è possibile.
Tuttavia mi dispiace vedere che si è sprecata una grande occasione per parlare di paradigmi in tutto questo. Quando ho scritto Nel contagio a marzo 2020, ho visto nella tragedia che stava iniziando anche una possibile finestra per parlare di tematiche più grandi e interconnesse, e ci sarebbe stato lo spazio per farlo. Almeno in Italia, invece, siamo stati completamente assorbiti dall’emergenza, addirittura con un eccesso informativo. Forse abbiamo tutti perso un’occasione per inaugurare qualche discorso di più lungo respiro.
Vediamo che molti hanno ancora difficoltà a rispettare regole basilari per contenere la diffusione del virus; vivono tutto come una privazione di libertà, senza rendersi conto che non possiamo più pensare solo al nostro interesse personale, ma che siamo parte di qualcosa di più grande. Come mai molte persone continuano ad affrontarla così?
Questo sì che è un cambio di paradigma enorme e molto difficile da assorbire. Sarò pessimista, ma credo che questo nuovo pensiero non troverà terreno fertile in noi adulti. C’è da augurarsi che si insinui invece nell’esperienza dei più giovani, in chi cioè ha vissuto la pandemia in un’età molto più fertile per la formazione di una visione del mondo. Questo mi sembra il portato politico-filosofico in assoluto più dirompente della pandemia.
Mai come oggi generazioni come le nostre hanno vissuto una tale torsione estrema tra l’esperienza individuale e quella collettiva. Come tutti, anch’io sono cresciuto nell’idea implicita che la mia missione fosse di impegnarmi per me stesso in modo serio e onesto, e che così facendo la collettività ne avrebbe indirettamente beneficiato. All’improvviso è arrivata la pandemia, ovvero una situazione radicalmente diversa in cui quell’idea non è più sufficiente: abbiamo dovuto pensare a noi stessi e contemporaneamente alla collettività, fare sacrifici individuali perché avessero una ripercussione collettiva. Non ci siamo abituati. Incidentalmente, sarebbe anche il tipo di pensiero di cui avremmo bisogno per affrontare emergenze ancora più complesse, come il cambiamento climatico e le migrazioni che ne seguiranno. Non so se riusciremo a farlo nostro, per noi adulti sarà molto difficile. Di sicuro, però, questa esperienza segna un cambiamento istintivo nella formazione dei giovanissimi; può darsi quindi che in loro questo nuovo pensiero politico diventi sostanziale.
Nella comunicazione della pandemia si sono viste le differenze di vedute fra scienziati e gli errori che sono stati fatti, inevitabilmente, trattandosi di un fenomeno al quale non eravamo preparati. Ma spesso ci si dimentica che nessuno può dare certezze e soluzioni pronte, come invece a volte viene richiesto agli scienziati. Questa mancanza di consapevolezza di come funziona la scienza contribuisce ad aumentare il rumore.
Gli scienziati proprio non le avevano, le certezze. Forse oggi, vista a distanza, è ancora più straordinaria la situazione che abbiamo vissuto. Tutti noi siamo cresciuti con l’idea quasi ovvia che, se ci coglie un male di qualche tipo, sia minore che grave, esiste comunque un protocollo da seguire: esistono esami, cure, medicinali; si consulta questo o quel medico. Invece, da una settimana all’altra, ci ritroviamo alle prese tutti quanti con un virus tecnicamente nuovo per la specie umana e per il quale all’inizio non esistono cure, né vaccini, né protocolli. Ancora peggio: non conosciamo lo spettro dei possibili sintomi e dei possibili esiti, non sappiamo come impatta su diversi tipi di persone, non sappiamo niente. Questo tipo di non-conoscenza è un altro elemento nuovo e imprevisto, seppure forse prevedibile. Credo che in quei primi mesi tutte le reazioni delle persone siano state comprensibili.
Poi in meno di un anno (e devo dire che non me lo sarei aspettato) ci ritroviamo con non uno, ma più vaccini in distribuzione, e con protocolli di cura che diventano sempre più efficienti. Tutto ciò è avvenuto sotto i nostri occhi, mentre noi eravamo bloccati e un po’ impauriti. È stato molto strano assistere a un progresso scientifico che ci si dipanava davanti con tutte le correzioni in corsa, i tentativi, gli errori e le false piste. Abbiamo visto un’azione straordinaria, anche per me che non sono un fanatico scientista: gli sforzi mondiali della comunità scientifica in vari campi si sono concentrati su un problema trovandone le possibili vie d’uscita in pochissimo tempo. Dovremmo riflettere molto sulla nostra scarsa propensione ad ammettere una realtà che qualunque scienziato conosce bene, e i fisici ancora di più: cioè che qualsiasi azione, misura o verità è accompagnata dalla sua incertezza. La comunicazione di quell’incertezza è importante tanto quanto il dato in sé a livello informativo. Questo sarebbe un altro cambiamento intero di pensiero, se entrasse nel nostro sentire.
Nel tuo libro Nel contagio sollevi un concetto importantissimo: siamo portati a pensare che i virus, e quest’epidemia in particolare, per qualche motivo inspiegabile abbiano preso di mira gli esseri umani. Le cose però non stanno proprio così.
Dare intenzioni al virus è una strada molto invitante e molto pericolosa. Io stesso, soprattutto nelle prime settimane, quando scrivevo gli articoli o una prima stesura del saggio, mi accorgevo che ogni tanto mi scappava la tentazione di personificare il virus e di dargli addirittura un’intenzione implicita. E ogni volta rileggendo evitavo questo passaggio, attuando una forma di igiene di pensiero che ritengo molto importante.
Abbiamo bisogno di vedere in questo virus il nemico invisibile. Tutto il lessico bellico che abbiamo usato, e che ci serviva forse a fomentare gli animi e spingerci alla mobilitazione, in realtà a livello di pensiero scientifico diffuso non ci fa così bene; pone infatti un’alterità di principio tra noi e il mondo naturale. Virus e batteri non sono nemici votati, ma fanno parte di un ecosistema in cui ci siamo anche noi, e in cui siamo noi probabilmente gli ospiti più invadenti. Attraverso i nostri stili di vita e la nostra spinta verso il progresso andiamo a perturbare moltissimi ambiti ecologici in cui esistono potenziali minacce, e spingiamo specie all’adattamento anche a nostre spese. Questi ragionamenti più complessi, purtroppo, sono stati spesso falciati dall’idea di esseri a noi nemici. Il virus però non è un alieno che ci attacca: il virus è parte di questo mondo, esattamente come noi.
Oltre a questo, sin dall’inizio (lo riporto già nel mio saggio di marzo 2020) c’è stata la doppia ipotesi sull’origine del virus: quella per così dire ecologica che voleva un’origine naturale, com’era stato per la SARS 1, e quella della fuga dal laboratorio di Wuhan. Per una questione di probabilità e di evidenze disponibili propendo sempre per la via che si è già verificata in natura moltissime volte, ovvero lo spillover tra specie. Nel corso dei mesi, tuttavia, ha guadagnato quanto meno enfasi mediatica e istituzionale l’ipotesi di un’origine antropica, con l’idea di verificare se non sia coinvolta qualche sperimentazione, come quelle che vengono davvero fatte sui coronavirus. È una questione molto complicata; di fatto a oggi, mentre parlo, non esistono evidenze né da una parte né dall’altra, e siamo dunque in una situazione di totale indecidibilità.
La mia impressione è che non lo sapremo; mi sembra molto difficile che a un certo punto troveremo la pistola fumante dell’origine del virus, poiché il campo è già troppo inquinato da ovvie complicazioni politiche. Se anche dovesse succedere, se anche venisse fuori che invece c’è una componente legata alla sperimentazione, è importante ricordarsi che questo non cambia le considerazioni sul rapporto tra possibili nuovi patogeni da un lato, e civilizzazione e stili di vita umani dall’altro. I nostri comportamenti che turbano gli ecosistemi restano una fonte di possibili minacce pandemiche.
Per finire, c’è qualcosa che ti aspetti, o che speri che ci resti, da tutta questa esperienza?
Spero che resti il tratto di vulnerabilità che abbiamo scoperto, che sporca un po’ l’eccessiva tracotanza che abbiamo. Una vulnerabilità non solo a livello personale, ma anche come civilizzazione; non solo come cittadini, ma anche come scienziati. Se ne rimanesse qualcosa, sarebbe già un grandissimo traguardo.