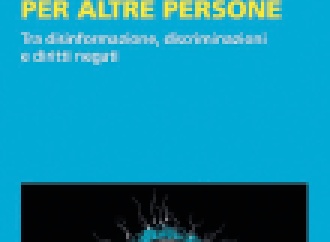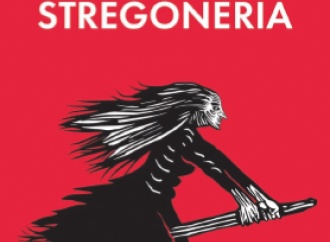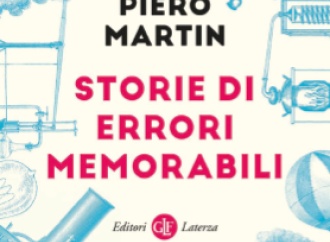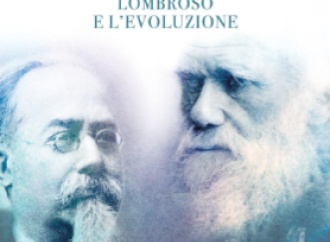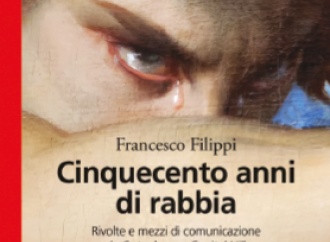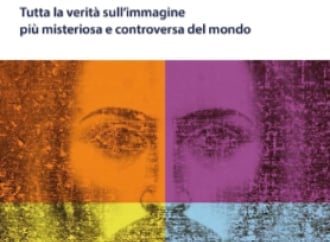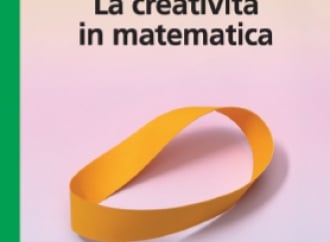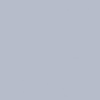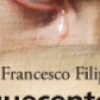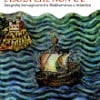Storia delle nostre paure alimentari
di Alberto Grandi
Aboca Edizioni, Sansepolcro (AR), 2023
pp. 252, euro 24,00
Nell’Italia dei Comuni, tra Medioevo e Età Moderna, gli ufficiali sanitari incaricati di controllare la carne in arrivo nelle città erano ossessionati dalla “lebbra suina”. Regolamenti e trattati medici spiegavano per filo e per segno come riconoscere i sintomi di questa malattia e in quali casi sequestrare la carne, il che è abbastanza sorprendente, se si pensa che la lebbra suina, semplicemente, non esiste: è una malattia immaginaria, un riflesso dei sospetti che si nutrivano verso i maiali e il loro consumo.
Negli anni in cui l’esercito di Carlo VIII calava in Italia e assediava Napoli, alla fine del XV secolo, si diffuse invece un’altra diceria: i casi di sifilide che falcidiavano i soldati erano colpa del tonno. All’epoca i pesci di mare erano considerati meno pregiati di quelli di acqua dolce, e il tonno era un alimento a basso costo che veniva impiegato per nutrire l’esercito. Così, i medici francesi ipotizzarono che fosse proprio quel cibo scadente a provocare il contagio; magari anche perché - come si vociferava tra le vie di Napoli - qualche malfattore aveva cominciato a vendere ai funzionari di Carlo VIII carne umana, spacciandola per pesce.
Nel 1609 Cosimo Salini pubblicò a Roma il suo Trattato del ber fresco: oggetto dei suoi strali erano sorbetti e granite, fatti con neve e ghiaccio importati dalle montagne, secondo un uso arabo che in quegli anni si stava diffondendo tra gli strati più ricchi della popolazione. Un’abitudine dannosa e pericolosa, spiegava Salini, che si appellava alla teoria degli umori di Galeno: i vapori umidi e freschi, immessi nello stomaco, potevano salire fino al cervello, portando alla pazzia. E ancor peggio potevano fare i sorbetti su una donna incinta: la gravidanza avrebbe portato alla nascita di una femmina, invece che di un maschietto come allora si desiderava.
Questi sono tre esempi dei timori irrazionali e delle dicerie sul cibo che racconta nel suo nuovo saggio Alberto Grandi, storico dell’alimentazione presso l’Università di Parma. L’autore analizza la storia di diversi prodotti che troviamo comunemente sulle nostre tavole, dallo zucchero al caffè, dalla farina all’hot dog. Si scoprono così inquietudini impensate su piatti ormai sdoganati, sospetti ormai superati di cui non è rimasta traccia.
Una parte importante del libro è infatti dedicata al novel food del passato, e in particolare ai prodotti provenienti dalle Americhe. Se peperoni e tacchini entrarono nella dieta europea senza traumi grazie alla loro somiglianza con alimenti nostrani, pomodori e patate ebbero vita difficile. Queste ultime, in particolare, erano di aspetto brutto e deforme, e poi crescevano sotto terra: un cibo per animali, accusato di provocare malattie come la scabbia negli esseri umani. Salvo poi diffondersi nel XVII secolo, quando l’aumento della popolazione portò al propagarsi di carestie e si passò così, in molte regioni, da un fermo ostracismo a una totale dipendenza. Ma i timori per i nuovi cibi potevano anche essere più impalpabili, il dibattito poteva svolgersi su piani più spirituali: per secoli si discusse sulla possibilità che la cioccolata potesse o meno interrompere il digiuno quaresimale, con i gesuiti (che possedevano numerose piantagioni di cacao in Brasile) schierati fortemente a favore della nuova bevanda, mentre i domenicani ne avversavano la diffusione.
Le paure alimentari, insomma, non sono da prendere alla leggera: sono uno dei fattori grazie al quale le comunità costruiscono la loro identità sociale e culturale, arrivando a plasmare lo sviluppo economico di intere regioni. Il libro di Alberto Grandi riesce a mettere ben in luce questo elemento, allineando vicende che attraversano tutto l’arco della storia: si va infatti dalla costruzione delle prime città - in cui gli abitanti non erano più produttori del proprio cibo, ma importavano le derrate dai territori circostanti, con conseguenti paure e regolamenti antiadulterazioni - fino ai giorni nostri, con i timori verso il sushi, gli insetti e la carne sintetica.
Se oggi il marketing insiste sul gastronazionalismo, i prodotti “senza” (cioè senza OGM, senza olio di palma, senza glutine, eccetera), l’ostracismo verso i piatti che provengono dall’estero, il migliore antidoto è forse proprio un libro come questo: ci fa capire quanto alcuni timori siano in realtà irrazionali, confrontati alla realtà. E, tutto sommato, frutto di sentimenti nemmeno troppo nuovi rispetto alla nostra storia.