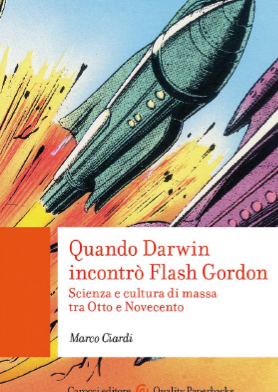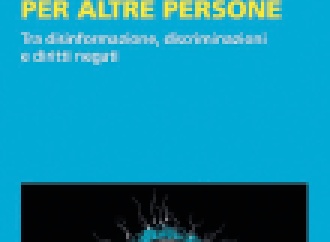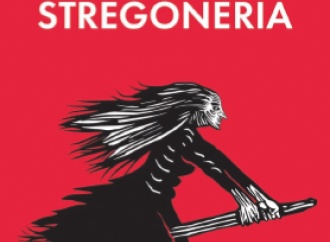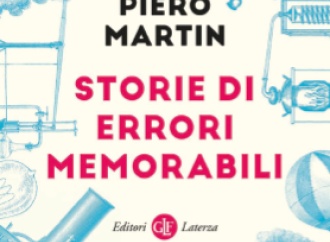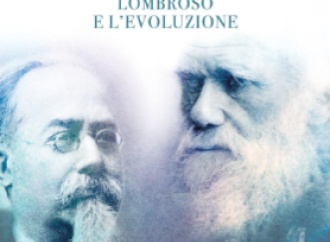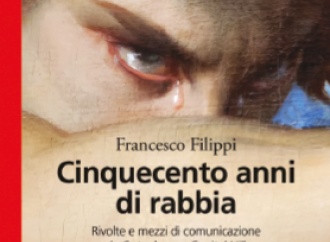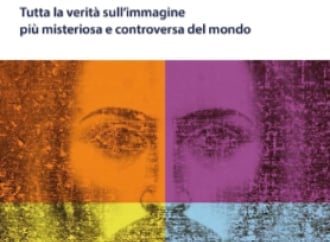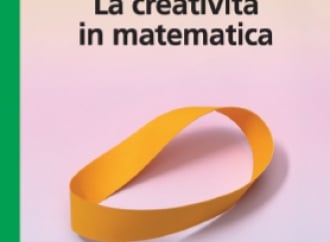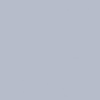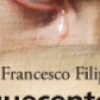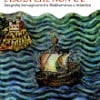Quando Darwin incontrò Flash Gordon
di Marco Ciardi
Carocci, Roma, 2023
pp. 211, euro 17,00
Che peso ha avuto la scienza nel definire l’immaginario occidentale moderno? E che peso ha avuto l’immaginario nell’impresa scientifica contemporanea? Sono due domande che possono riassumere l’itinerario intellettuale di Marco Ciardi, docente di storia della scienza all’Università di Firenze, che ha all’attivo una lunga serie di pubblicazioni con cui ha cercato di indagare il cortocircuito tra l’universo dei fatti e quello della finzione, tra le quali ricordiamo Galileo & Harry Potter (2014) – sorta di “opera-manifesto” –, Il mistero degli antichi astronauti (2017), Frankenstein. Il mito tra scienza e immaginario (2018, con Pier Luigi Gaspa), e i numerosi studi dedicati al mito di Atlantide.
In quest’ultimo volume, Ciardi mette in fila i diversi temi toccati negli anni per presentare una narrazione strutturata dei rapporti reciproci tra scienza e cultura di massa tra Otto e Novecento. “Reciproci”, perché non si tratta di guardare solo alle diverse influenze della chimica nel Frankenstein di Mary Shelly, o del darwinismo nei romanzi di Rice Burroughs, ma anche al modo in cui romanzi d’avventura, fumetti e racconti di fantascienza hanno stimolato l’immaginazione degli scienziati.
Ancora meglio: Ciardi ci invita a guardare il modo in cui immaginario e impresa scientifica si sviluppano di pari passo, spesso inconsapevolmente ma attingendo evidentemente a una sorgente comune che dà forma all’inconscio culturale. Un esempio tra tutti: quello dell’energia atomica.
È noto che The World Set Free di H.G. Wells (1914) avesse già immaginato le potenzialità di una guerra atomica, ma che dire di Topolino? Eppure Topolino e il mistero dell’uomo nuvola (1936-1937) di Floyd Gottfredson, mette in scena un’avventura in cui Topolino e Pippo si imbattono nella base segreta del professor Enigm (in originale Einmug, un chiaro riferimento a Einstein), che ha scoperto la formula per produrre energia atomica ma la custodisce in cassaforte perché consapevole dei suoi potenziali usi distorti.
La reazione a catena della fissione dell’uranio sarà scoperta solo due anni dopo, ma l’idea faceva parte di un bagaglio archetipale della cultura dell’epoca e non sappiamo se Oppenheimer avesse letto la storia di Topolino, ma di sicuro non si immedesimò in Pietro Gambadilegno, che non si fa invece scrupoli a tentare di rubare la formula di Enigm.
Poi, certo, ci sono le influenze esplicite. Che Ray Bradbury abbia scritto le sue Cronache marziane perché da bambino aveva desiderato volare su Marte come John Carter nell’indimenticabile ciclo di storie di Burroughs non stupisce; ma che dire dell’influenza che quegli stessi racconti ebbero su Carl Sagan? Il celebre astrofisico e divulgatore spesso indicato come campione del razionalismo sognava da bambino i canali marziani descritti da Percival Lowell, riconoscendo che, pur sbagliata, «la sua idea del pianeta ha avuto almeno un merito: ha spinto generazioni di ragazzi di otto anni – me compreso – a considerare possibile l’esplorazione dei pianeti, a chiederci se noi stessi non potremmo un giorno metterci in viaggio per Marte».
E ci sono anche i rapporti tra immaginario, scienza e pseudoscienza: tema anch’esso fondamentale degli studi di Ciardi, di cui riferimento imprescindibile è la sua Breve storia della pseudoscienza (2021). Troviamo così Arthur Conan Doyle che crea personaggi razionali come Sherlock Holmes – dotato di una «profonda conoscenza» della chimica – o il professor Challenger, modellato sulla figura di Ernst Rutherford, e che al tempo stesso accumula una biblioteca di 2000 volumi di spiritismo e si diletta a scrivere delle fate di Cottingley, celebre bufala creata da due ragazzine inglesi, o una Storia dello spiritismo in due volumi. Oppure la teosofia di Madame Blavatsky, che oltre ad aver influenzato romanzi come La razza ventura di Edward Bulwer-Lytton, «catalizzerà l’interesse […] di scienziati come Flammarion, Crookes ed Edison, a riprova della complessa circolazione delle idee tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del Novecento».
Anche se si ferma a Flash Gordon e ad Asimov, il libro di Ciardi è un invito a proseguire questo filone d’indagine per svelare le connessioni nascoste tra scienza e immaginario ai giorni nostri: una chiave di lettura per meglio comprendere non solo l’evoluzione delle idee scientifiche, ma anche la loro ricezione nella cultura di massa.