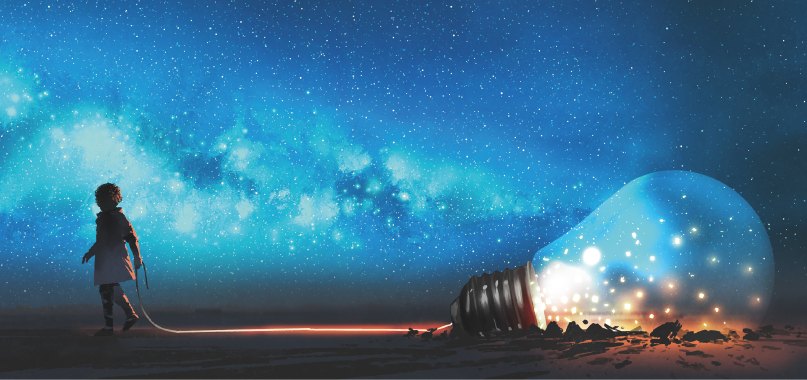Le inadempienze dei sogni giovanili, lo schiudersi di un fiore, la malinconia di un amore mancato, sulla scorta di una musica interiore: l'impulso a identificare la poesia esclusivamente con qualcosa del genere è forte, e non ingiustificato. La poesia, ci diciamo, è qualcosa che gioca di sponda tra il mondo esterno e le nostre sensazioni più intime, scandaglia le relazioni con gli altri e con noi stessi, cercando di fare di ogni particolare un indizio per ragionamenti universali. Ma questo è, storicamente, solo uno dei modi in cui si può fare poesia.
Da che l’essere umano ha cominciato a recitare versi, e poi a scriverli, la poesia si è occupata di ogni aspetto dell’umana esperienza: ha parlato, e cantato, di storia, di battaglie, di ipotesi sulla natura dell’universo, d’amore e di speranze, di scienza, di filosofia, di religione. Ha impastato la scienza con il mito fin dai tempi di Esiodo; ha dato voce a Parmenide e ai suoi tentativi organici di dare spiegazioni alla natura; in Virgilio, nelle Georgiche, ha parlato del lavoro dei campi, dell’arboricoltura, dell'allevamento e dell’apicoltura; Lucrezio ha usato gli esametri per dare conto della teoria di Epicuro sulla natura, parlando del ruolo degli atomi e del vuoto in un universo meccanicistico. Il Medioevo ha visto produrre poemi didattici e didascalici sulle creature viventi, sui minerali e sui cicli astronomici, dai meno noti lavori di Filippo di Thaon o Gautier de Metz al più celebre Tesoretto di Brunetto Latini: l’ha fatto spesso mescolando l’osservazione al mito, la natura al dettato biblico, e ricavandone precetti morali. E non è un’eresia collocare anche la Divina Commedia tra le opere che hanno trattato di filosofia e di scienza, ovviamente rapportate alle conoscenze dell’inizio del Trecento e rielaborate in una meravigliosa serie di allegorie e drammatizzazioni dialogiche. Nel Cinquecento, la poesia didascalica si espande ovunque si possano indagare la natura e la tecnica: ecco i versi sui bachi da seta (Girolamo Vida) o sulla sifilide (Girolamo Fracastoro) o sull’arte della navigazione (Bernardino Baldi), fino alle ricette culinarie per evitare la peste (Marcantonio Ciappi).
La fortuna di questo genere di poesie era vasta; non così solida, invece, la sua legittimazione. I dubbi si fondavano su un’antica direttiva di Aristotele, espressa nella Poetica e ripresa ed elaborata dagli interpreti dell’epoca, secondo cui il “vero” poeta non si occupa di temi scientifici: quella è al più materia per lo studioso della natura, il filosofo. I poeti che scrivevano di temi scientifici si opposero alla potenziale squalifica del loro lavoro e si misero a rivendicare la possibilità di unire in versi il bello e l’utile, dimostrando anzi come i versi riuscissero a nobilitare la materia terrena di cui si occupavano. L’Arte poetica in endecasillabi sciolti di Girolamo Muzio, a metà del XVI secolo, per esempio, parla proprio di questo, e si inserisce in un più generale dibattito sull’aristotelismo; sempre in quegli anni, la Poetica di Francesco Patrizi si spingerà esplicitamente a dire che è la forma, e non il contenuto, a definire cos’è una poesia e cosa no.
La poesia su argomento scientifico ebbe ancora modo di dire la sua nei secoli successivi: tanto per fare solo un nome, Erasmus Darwin, il nonno di Charles, divulgò in versi l’opera di Linneo, scrivendo il lungo poema Gli amori delle piante. Ma non doveva durare. In epoca più recente, infatti, il linguaggio poetico si è (quasi) totalmente scisso dalla questione scientifica. La scienza stessa si rende sempre più specialistica, e gli scienziati universali non esistono più. In molti, poi, si fanno affascinare dalle suggestioni, e dalla susseguente polarizzazione, dell’esistenza delle “due culture” fieramente contrapposte, umanistica e scientifica. Lo studio completo di quelle che erano le famose arti liberali, cioè il Trivio letterario che comprendeva la grammatica, la retorica e la dialettica, e il Quadrivio scientifico con l’aritmetica, la geometria, la musica e l’astronomia, è visto ormai, se non come un vezzo fuori moda, come un’impresa umanamente insostenibile data la mole e l’approfondimento che hanno raggiunto le rispettive discipline: anche i più volenterosi spesso non possono che limitarsi a un’infarinatura generale, con la prospettiva poco piacevole di diventare ben presto incomprensibili a chi invece ha approfondito un unico settore.
Nonostante Vladimir Nabokov, che era sia romanziere che entomologo, nelle sue Lezioni di letteratura accomunasse la passione dell’artista a quella dello scienziato, vedendole come due aspetti simili e complementari nel compito di affabulare il prossimo e di reinventare il mondo, i casi di poesia scientifica sono dunque diventati sporadici e ridotti perlopiù a giochi di metrica, note a margine, passatempi per scienziati col pallino della scrittura e un bel po’ di tempo libero: niente che valga la pena prendere sul serio. Abbiamo certo visto la poesia darsi alla matematica con gli esperimenti patafisici dell’OuLiPo, e in Italia per quanto riguarda le scienze possiamo citare la Chimica in versi di Alberto Cavaliere, composta a metà del secolo scorso, ma si tratta ormai di curiosità intellettuali. Al di là di tali eventi singoli, sembra che tutto ci dica: lo scienziato faccia lo scienziato, e il poeta faccia il poeta! E il poeta, soprattutto, si occupi appunto delle inadempienze dei propri sogni giovanili, della malinconia o della furia di un amore mancato; anche dello schiudersi di un fiore, se lo ritiene, ma senza approfondire tutti gli aspetti tecnici della riproduzione delle angiosperme.
Credo che sia un peccato: credo che i temi scientifici abbiano in sé una grande potenza evocativa a cui la poesia può dare corpo, e che questa potenza sia rimasta intatta nel corso del tempo. Anzi, il progredire delle conoscenze scientifiche ha aggiunto innumerevoli nuove potenzialità sugli argomenti da trattare. Certo, c’è il problema del linguaggio specialistico e, ancor più, di cosa fare con tutta la matematica che viene usata per descrivere i fenomeni con il dovuto rigore. Da questo punto di vista è bene chiarire subito: una poesia non potrà mai avere la stessa precisione, né la stessa accuratezza, né la stessa sensibilità, di un articolo scientifico, e nemmeno la stessa capacità comunicativa ad ampio spettro di un saggio o di un testo di divulgazione. Si tratta di un mondo espressivo diverso, che però presenta i suoi punti di forza.
Tali punti di forza, curiosamente, non si trovano soltanto nei contenuti: si trovano anche nella struttura di una poesia o di un poema. E qui, per capire meglio il perché e quali siano, bisogna entrare a fondo nell’universo della composizione poetica.
Siamo abituati perlopiù a leggere poesia contemporanea in verso libero, e a dimenticarci che la poesia nasce come struttura fortemente ritmata e vincolata, per questioni che hanno a che fare con la facilità di tenere a mente e ripetere lunghi brani (la poesia nasce come arte orale, è recitata a memoria: il supporto scritto arriva in un secondo momento).
La poesia ha a che fare con la scansione del tempo, con l’organizzazione ritmica, con la composizione ragionata delle forme: tutti principi che certo permangono nel verso libero, ma che non sono così evidenti. Nelle cosiddette forme chiuse, invece, come il sonetto, l’ottava, la terzina, la quartina o la ballata, l’esistenza e la natura della struttura compositiva saltano all’occhio. Spesso ci sono le rime, variamente articolate; ma, anche nel verso sciolto, si vedono comunque con chiarezza l’ordine della cadenza e l’impostazione regolare del discorso.
Tutto questo ha a che fare con la matematica: nella fattispecie, ha a che fare con la matematica che si occupa di strutture e di permutazioni, cioè con l’algebra e con il calcolo combinatorio. Detto così può sembrare eccessivamente artificioso, un mero espediente tecnico: ma, se bene usata, la struttura metrica ben si armonizza con il contenuto espresso e finisce col comporre una modalità espressiva nuova e peculiare. Non solo: una struttura metrica riecheggia di armonia e di simmetria, che sono concetti che nella matematica hanno trovato uno dei loro grandi linguaggi, anzi forse il linguaggio per eccellenza.
L’algebra è, come si sa, quella parte della matematica che studia il comportamento di strutture astratte, delle relazioni che intercorrono fra i loro elementi e delle operazioni che tra questi elementi si possono fare, a seconda delle leggi di composizione che tengono insieme una data struttura algebrica. Una poesia in forma chiusa o, per estensione, un poema, è di par suo una struttura: ha delle regole che ci dicono come devono essere scritti i versi, di quante sillabe devono comporsi, quali accenti interni devono rispettare, o che ci dicono dove vanno messe le cesure, cioè i silenzi, giacché una poesia, a maggior ragione essendo un mezzo che si porta dietro il suo retaggio di oralità, è fatta di parole tanto quanto di pause.
Una poesia può essere una struttura semplice o più elaborata, può prevedere delle variazioni o ripetersi uguale fino alla fine: dipende dalle scelte di chi scrive, da come ritiene che la struttura che elabora possa adattarsi ai concetti che esprime. Nella composizione delle poesie in forma chiusa è poi evidente l'apporto del calcolo combinatorio, che è il mezzo per ordinare gli elementi di un insieme finito, come può essere l’insieme dei versi in una determinata rima. Anche qui la scelta del metro non è univoca: dipende da quello che l’autore ha da dire, e in che modo intende farlo. Le rime possono essere ripetute secondo una data sequenza fissata, permutate con ripetizioni, permutate senza ripetizioni, dando fondo a tutti gli strumenti che il calcolo combinatorio ci mette a disposizione. Può risultare spesso un mero e arido esercizio di stile, ma talora la forma riesce ad armonizzarsi al contenuto e la macchinosità, come per incanto, scompare.
Il grande punto di forza di una poesia siffatta, quindi, è che lascia trasparire la matematica che c’è dietro. E la matematica è anche dietro alla scienza di cui la poesia parla: le tiene insieme.
Ho cominciato a interessarmi di poesia scientifica a vent’anni, con scarsi mezzi e idee poco chiare. I primi risultati sono stati talmente farraginosi che per anni non ho mai pensato che la scienza in versi potesse essere più di un gioco senza pretese. Il tempo mi ha costretto a cambiare idea. Mano a mano che imparavo qualcosa di più di matematica o di fisica, e mano a mano che mi esercitavo con le forme chiuse della metrica italiana, l’idea di tornare alla poesia scientifica si faceva sempre più allettante, fino a diventare una sorta di necessità espressiva. Il metodo e i contenuti del sapere scientifico diventavano un prerequisito per qualsiasi interpretazione rigorosa e profonda del mondo, e anche per l’esplorazione dello spazio poetico in quanto esperienza umana. Ritmo e sonorità dello scrivere in versi ben si conciliavano, d’altronde, con strutture e linguaggi della scienza e della matematica.
Ho cominciato con dei componimenti brevi, dedicati a questo o quel singolo fatto di scienza o di matematica, per poi prendere coraggio (o incoscienza) e tentare anche la strada dei poemi. La fatica dello studio preparatorio è ancora improba, ma la pratica e l’abitudine rendono la stesura dei brani molto più agevole di quanto fosse all’inizio.
Per quanto riguarda la scelta della forma ho due predilezioni, a seconda della lunghezza di ciò che voglio esporre. Per i componimenti brevi, quelli che possono riguardare il singolo fenomeno, la singola formula matematica, uso quasi sempre il sonetto. Il sonetto è rapido, conta soltanto 14 versi. È un po’ il formato tascabile delle poesie: è maneggevole e rigoroso nella forma ma, al contempo, permette anche una certa libertà di movimento. Un sonetto si compone tipicamente di due quartine in rima incrociata (ABBA ABBA) e di due terzine la cui rima è invece variabile: CDC DCD, oppure CDE CDE (che è quella di cui mi servo quasi sempre), o CDE EDC, o CDD CDD, o altre ancora, a seconda dei gusti e dei bisogni. Il metro è, altrettanto tipicamente, l'endecasillabo.
La suddivisione del sonetto in una prima parte di quartine e in una seconda di terzine è utile perché spezza il ritmo della composizione. Questo permette, a sua volta, di utilizzare le quartine per trattare l’argomento in generale e le terzine per scendere nel dettaglio, o di lasciare alle quartine un discorso introduttivo e chiosarlo poi nei sei versi finali. Non c’è alcun obbligo di farlo, in realtà; il sonetto può tranquillamente presentarsi come un corpo organico, come in questo esempio in cui si tenta di ragionare del ruolo del pensiero critico, e che è stato scritto appositamente per Query:
Non sa davvero in fondo come muove
se stesso a volte questo mio pensiero
che passa il guado, perenne straniero,
alla ricerca di fatti e di prove.
Non sa perché cammina, né per dove,
inebriato dall’arte del vero,
accoccolato all’ombra di un mistero
del quale vuol scoprire leggi nuove;
e ha, nella sua foga intransigente,
certezze sghembe sopra dubbi gracili
a cui già qualche regola comanda.
Mi restano, annegate nella mente,
ipotesi di soluzioni facili,
così, fino alla prossima domanda.
Quando ho a disposizione più spazio e posso parlare di argomenti che richiedono un'esposizione più lunga, la mia scelta cade quasi sempre su una qualche variazione della rima incatenata. È una rima incatenata la terzina dantesca: il primo verso rima col terzo, il secondo col quarto e col sesto, il quinto col settimo e col nono, e via così, in una struttura che può essere facilmente memorizzata come ABA BCB CDC DED…
Dalla terzina dantesca si possono derivare altre forme. Per esempio di recente ho sperimentato delle quartine incatenate a schema ABAC BCBD CDCE… Sono strutture che hanno una dinamicità molto pronunciata: si prestano alle narrazioni articolate, portano avanti il discorso senza che si areni su se stesso, senza che trovi una netta conclusione prima della fine del canto, che è composto di solito di un numero di versi nell’ordine del centinaio. Hanno, quindi, la capacità intrinseca di prestare alla poesia la scorrevolezza della prosa, senza per questo toglierle la musicalità propria delle forme chiuse.
Al di là dei meriti della forma, però, resta sempre il problema che il contenuto può essere scritto male: che sia sciatto, o banale, o che fraintenda questioni fondamentali. Per cercare di minimizzare i rischi almeno dal punto di vista stilistico, trovo sia necessario ricorrere a vari espedienti narrativi. Se la forma breve come il sonetto può essere dedicata interamente all’esposizione o all'interpretazione del fenomeno scientifico o della proposizione matematica di cui voglio parlare, infatti, quando scrivo lavori più lunghi cerco di evitare la mera giustapposizione di fatti e di dati e di inserire il tutto in una storia vera e propria, con personaggi, dialoghi, incisi e riflessioni.
Qui, per esempio (è in Teoria dei Canti, che è un poema in terzine sulla fisica, la matematica e il linguaggio), racconto di una macchina che cerca di spiegarmi la teoria della dimostrazione:
Ma nella macchina non si contiene
il sogno più fatale, eppure umano,
che fece Hilbert su tali questioni,
e invece gli crollò, disfatto, in mano.
Di consistenza e formalizzazioni
chiedeva, delle prove, con ampiezza;
del gran problema delle decisioni,
e dell’indipendenza e completezza
che rendono gli assiomi vera forza.
La logica, si vide con asprezza,
finché dei predicati si fa scorza,
completa non si fa, né mai si rende,
e sulla decisione ormai si smorza.
Il problema principale a questo punto, al di là dei vincoli metrici per i quali in fondo è sufficiente esercitarsi, è la scelta del linguaggio adeguato. Bisogna sfruttare le peculiarità del linguaggio poetico, che ama fare uso di metafore, similitudini e accostamenti arditi, e adattarle ai contenuti scientifici o matematici senza banalizzarli troppo. Sono dell’opinione che, quando si sceglie la poesia scientifica, sia sempre bene aver chiaro in mente che si tratta di poesia e non di un modo bizzarro di scrivere saggistica o di fare divulgazione. Si tratta, insomma, di reinterpretare dei concetti che in origine sono espressi in altre forme e di tradurli in forma poetica fino a farli diventare essi stessi materiale poetico, e non solo di scienza impacchettata in versi.
Ogni opera di traduzione comporta inevitabilmente delle distorsioni, ma ritengo che il linguaggio poetico abbia il grande vantaggio di riuscire a sottendere delle domande e a stimolare la curiosità di chi lo legge (e anche di chi lo scrive, lo ammetto) e di dare così forza ulteriore ai concetti scientifici di cui tratta: lo fa proprio in funzione della sua potenziale a-scientificità, cioè della sua intrinseca vaghezza, della sua capacità di percorrere strade oblique e “sentieri che si biforcano”, di cogliere punti di vista insoliti. L’idea è che la sua lettura lasci trasparire la struttura regolare che la sostiene, come si diceva prima, e che al contempo comunichi un senso di sospensione, di bisogno di una ricerca ulteriore; il senso, insomma, che dietro le risposte ci siano comunque altre domande, alcune sciocche, alcune profonde, e che non ci sia dato sapere in anticipo dove ci porteranno. E questo è un altro punto di forza.
Per ciò che riguarda lo stile, ogni componimento cerca di essere scorrevole e leggibile e di evitare gli ermetismi. Non è però, nel complesso, quasi mai una scrittura facile, anche perché deve tener conto dei vincoli di rima e di numero di sillabe metriche. Il rischio peggiore è che sia respingente sia perché tratta di scienza, sia perché lo fa in versi, e quindi che riesca a inimicarsi tanto gli amanti del rigore scientifico quanto quelli della poesia contemporanea. Se si dovesse darne una definizione, non sarebbe semplice rispondere a colpo sicuro. Non è scienza, anche se ne parla, perché difetta dell’approfondimento e dell’accuratezza che invece della scienza sono prerequisiti fondamentali; non è divulgazione, anche se racconta delle storie, perché non ha l’obiettivo di essere chiara e immediatamente fruibile a chi non abbia dimestichezza dei concetti.
Per quanto riguarda la forma e i contenuti, ciò che scrivo è una derivazione della poesia didascalica, riformulata secondo le esigenze narrative di chi si porta sulle spalle la consapevolezza di quella che è stata la letteratura negli ultimi secoli e secondo le esigenze scientifiche uscite dalle rivoluzioni anche epistemologiche che hanno plasmato la scienza moderna. Se poi nel fare ciò io riesca anche a giocare di sponda tra il mondo esterno e le nostre sensazioni più intime, come la poesia cui siamo tutti abituati, sarebbe un risultato eccezionale, ma anche del tutto accidentale. Tuttavia, è vero che tra una rima e l’altra tutto può succedere, e che una poesia finisce spesso con il cogliere di sorpresa in primo luogo chi la scrive. È il bello di trovarsi fra le parole, e fra le strutture che dalle parole riescono a emergere: è lo spaesamento che tocca ai curiosi, una sorta di inquietudine felice davanti alla ricchezza dell'esperienza sensibile a cui la scienza ha dato voce e a cui la poesia ha fornito il controcanto.
A tutto campo
Da che l’essere umano ha cominciato a recitare versi, e poi a scriverli, la poesia si è occupata di ogni aspetto dell’umana esperienza: ha parlato, e cantato, di storia, di battaglie, di ipotesi sulla natura dell’universo, d’amore e di speranze, di scienza, di filosofia, di religione. Ha impastato la scienza con il mito fin dai tempi di Esiodo; ha dato voce a Parmenide e ai suoi tentativi organici di dare spiegazioni alla natura; in Virgilio, nelle Georgiche, ha parlato del lavoro dei campi, dell’arboricoltura, dell'allevamento e dell’apicoltura; Lucrezio ha usato gli esametri per dare conto della teoria di Epicuro sulla natura, parlando del ruolo degli atomi e del vuoto in un universo meccanicistico. Il Medioevo ha visto produrre poemi didattici e didascalici sulle creature viventi, sui minerali e sui cicli astronomici, dai meno noti lavori di Filippo di Thaon o Gautier de Metz al più celebre Tesoretto di Brunetto Latini: l’ha fatto spesso mescolando l’osservazione al mito, la natura al dettato biblico, e ricavandone precetti morali. E non è un’eresia collocare anche la Divina Commedia tra le opere che hanno trattato di filosofia e di scienza, ovviamente rapportate alle conoscenze dell’inizio del Trecento e rielaborate in una meravigliosa serie di allegorie e drammatizzazioni dialogiche. Nel Cinquecento, la poesia didascalica si espande ovunque si possano indagare la natura e la tecnica: ecco i versi sui bachi da seta (Girolamo Vida) o sulla sifilide (Girolamo Fracastoro) o sull’arte della navigazione (Bernardino Baldi), fino alle ricette culinarie per evitare la peste (Marcantonio Ciappi).
La fortuna di questo genere di poesie era vasta; non così solida, invece, la sua legittimazione. I dubbi si fondavano su un’antica direttiva di Aristotele, espressa nella Poetica e ripresa ed elaborata dagli interpreti dell’epoca, secondo cui il “vero” poeta non si occupa di temi scientifici: quella è al più materia per lo studioso della natura, il filosofo. I poeti che scrivevano di temi scientifici si opposero alla potenziale squalifica del loro lavoro e si misero a rivendicare la possibilità di unire in versi il bello e l’utile, dimostrando anzi come i versi riuscissero a nobilitare la materia terrena di cui si occupavano. L’Arte poetica in endecasillabi sciolti di Girolamo Muzio, a metà del XVI secolo, per esempio, parla proprio di questo, e si inserisce in un più generale dibattito sull’aristotelismo; sempre in quegli anni, la Poetica di Francesco Patrizi si spingerà esplicitamente a dire che è la forma, e non il contenuto, a definire cos’è una poesia e cosa no.
La poesia su argomento scientifico ebbe ancora modo di dire la sua nei secoli successivi: tanto per fare solo un nome, Erasmus Darwin, il nonno di Charles, divulgò in versi l’opera di Linneo, scrivendo il lungo poema Gli amori delle piante. Ma non doveva durare. In epoca più recente, infatti, il linguaggio poetico si è (quasi) totalmente scisso dalla questione scientifica. La scienza stessa si rende sempre più specialistica, e gli scienziati universali non esistono più. In molti, poi, si fanno affascinare dalle suggestioni, e dalla susseguente polarizzazione, dell’esistenza delle “due culture” fieramente contrapposte, umanistica e scientifica. Lo studio completo di quelle che erano le famose arti liberali, cioè il Trivio letterario che comprendeva la grammatica, la retorica e la dialettica, e il Quadrivio scientifico con l’aritmetica, la geometria, la musica e l’astronomia, è visto ormai, se non come un vezzo fuori moda, come un’impresa umanamente insostenibile data la mole e l’approfondimento che hanno raggiunto le rispettive discipline: anche i più volenterosi spesso non possono che limitarsi a un’infarinatura generale, con la prospettiva poco piacevole di diventare ben presto incomprensibili a chi invece ha approfondito un unico settore.
Un malinconico addio, o forse un arrivederci
Nonostante Vladimir Nabokov, che era sia romanziere che entomologo, nelle sue Lezioni di letteratura accomunasse la passione dell’artista a quella dello scienziato, vedendole come due aspetti simili e complementari nel compito di affabulare il prossimo e di reinventare il mondo, i casi di poesia scientifica sono dunque diventati sporadici e ridotti perlopiù a giochi di metrica, note a margine, passatempi per scienziati col pallino della scrittura e un bel po’ di tempo libero: niente che valga la pena prendere sul serio. Abbiamo certo visto la poesia darsi alla matematica con gli esperimenti patafisici dell’OuLiPo, e in Italia per quanto riguarda le scienze possiamo citare la Chimica in versi di Alberto Cavaliere, composta a metà del secolo scorso, ma si tratta ormai di curiosità intellettuali. Al di là di tali eventi singoli, sembra che tutto ci dica: lo scienziato faccia lo scienziato, e il poeta faccia il poeta! E il poeta, soprattutto, si occupi appunto delle inadempienze dei propri sogni giovanili, della malinconia o della furia di un amore mancato; anche dello schiudersi di un fiore, se lo ritiene, ma senza approfondire tutti gli aspetti tecnici della riproduzione delle angiosperme.
Credo che sia un peccato: credo che i temi scientifici abbiano in sé una grande potenza evocativa a cui la poesia può dare corpo, e che questa potenza sia rimasta intatta nel corso del tempo. Anzi, il progredire delle conoscenze scientifiche ha aggiunto innumerevoli nuove potenzialità sugli argomenti da trattare. Certo, c’è il problema del linguaggio specialistico e, ancor più, di cosa fare con tutta la matematica che viene usata per descrivere i fenomeni con il dovuto rigore. Da questo punto di vista è bene chiarire subito: una poesia non potrà mai avere la stessa precisione, né la stessa accuratezza, né la stessa sensibilità, di un articolo scientifico, e nemmeno la stessa capacità comunicativa ad ampio spettro di un saggio o di un testo di divulgazione. Si tratta di un mondo espressivo diverso, che però presenta i suoi punti di forza.
Tali punti di forza, curiosamente, non si trovano soltanto nei contenuti: si trovano anche nella struttura di una poesia o di un poema. E qui, per capire meglio il perché e quali siano, bisogna entrare a fondo nell’universo della composizione poetica.
Pezzi di matematica
Siamo abituati perlopiù a leggere poesia contemporanea in verso libero, e a dimenticarci che la poesia nasce come struttura fortemente ritmata e vincolata, per questioni che hanno a che fare con la facilità di tenere a mente e ripetere lunghi brani (la poesia nasce come arte orale, è recitata a memoria: il supporto scritto arriva in un secondo momento).
La poesia ha a che fare con la scansione del tempo, con l’organizzazione ritmica, con la composizione ragionata delle forme: tutti principi che certo permangono nel verso libero, ma che non sono così evidenti. Nelle cosiddette forme chiuse, invece, come il sonetto, l’ottava, la terzina, la quartina o la ballata, l’esistenza e la natura della struttura compositiva saltano all’occhio. Spesso ci sono le rime, variamente articolate; ma, anche nel verso sciolto, si vedono comunque con chiarezza l’ordine della cadenza e l’impostazione regolare del discorso.
Tutto questo ha a che fare con la matematica: nella fattispecie, ha a che fare con la matematica che si occupa di strutture e di permutazioni, cioè con l’algebra e con il calcolo combinatorio. Detto così può sembrare eccessivamente artificioso, un mero espediente tecnico: ma, se bene usata, la struttura metrica ben si armonizza con il contenuto espresso e finisce col comporre una modalità espressiva nuova e peculiare. Non solo: una struttura metrica riecheggia di armonia e di simmetria, che sono concetti che nella matematica hanno trovato uno dei loro grandi linguaggi, anzi forse il linguaggio per eccellenza.
L’algebra è, come si sa, quella parte della matematica che studia il comportamento di strutture astratte, delle relazioni che intercorrono fra i loro elementi e delle operazioni che tra questi elementi si possono fare, a seconda delle leggi di composizione che tengono insieme una data struttura algebrica. Una poesia in forma chiusa o, per estensione, un poema, è di par suo una struttura: ha delle regole che ci dicono come devono essere scritti i versi, di quante sillabe devono comporsi, quali accenti interni devono rispettare, o che ci dicono dove vanno messe le cesure, cioè i silenzi, giacché una poesia, a maggior ragione essendo un mezzo che si porta dietro il suo retaggio di oralità, è fatta di parole tanto quanto di pause.
Una poesia può essere una struttura semplice o più elaborata, può prevedere delle variazioni o ripetersi uguale fino alla fine: dipende dalle scelte di chi scrive, da come ritiene che la struttura che elabora possa adattarsi ai concetti che esprime. Nella composizione delle poesie in forma chiusa è poi evidente l'apporto del calcolo combinatorio, che è il mezzo per ordinare gli elementi di un insieme finito, come può essere l’insieme dei versi in una determinata rima. Anche qui la scelta del metro non è univoca: dipende da quello che l’autore ha da dire, e in che modo intende farlo. Le rime possono essere ripetute secondo una data sequenza fissata, permutate con ripetizioni, permutate senza ripetizioni, dando fondo a tutti gli strumenti che il calcolo combinatorio ci mette a disposizione. Può risultare spesso un mero e arido esercizio di stile, ma talora la forma riesce ad armonizzarsi al contenuto e la macchinosità, come per incanto, scompare.
Il grande punto di forza di una poesia siffatta, quindi, è che lascia trasparire la matematica che c’è dietro. E la matematica è anche dietro alla scienza di cui la poesia parla: le tiene insieme.
Progetti per un ritorno
Ho cominciato a interessarmi di poesia scientifica a vent’anni, con scarsi mezzi e idee poco chiare. I primi risultati sono stati talmente farraginosi che per anni non ho mai pensato che la scienza in versi potesse essere più di un gioco senza pretese. Il tempo mi ha costretto a cambiare idea. Mano a mano che imparavo qualcosa di più di matematica o di fisica, e mano a mano che mi esercitavo con le forme chiuse della metrica italiana, l’idea di tornare alla poesia scientifica si faceva sempre più allettante, fino a diventare una sorta di necessità espressiva. Il metodo e i contenuti del sapere scientifico diventavano un prerequisito per qualsiasi interpretazione rigorosa e profonda del mondo, e anche per l’esplorazione dello spazio poetico in quanto esperienza umana. Ritmo e sonorità dello scrivere in versi ben si conciliavano, d’altronde, con strutture e linguaggi della scienza e della matematica.
Ho cominciato con dei componimenti brevi, dedicati a questo o quel singolo fatto di scienza o di matematica, per poi prendere coraggio (o incoscienza) e tentare anche la strada dei poemi. La fatica dello studio preparatorio è ancora improba, ma la pratica e l’abitudine rendono la stesura dei brani molto più agevole di quanto fosse all’inizio.
Per quanto riguarda la scelta della forma ho due predilezioni, a seconda della lunghezza di ciò che voglio esporre. Per i componimenti brevi, quelli che possono riguardare il singolo fenomeno, la singola formula matematica, uso quasi sempre il sonetto. Il sonetto è rapido, conta soltanto 14 versi. È un po’ il formato tascabile delle poesie: è maneggevole e rigoroso nella forma ma, al contempo, permette anche una certa libertà di movimento. Un sonetto si compone tipicamente di due quartine in rima incrociata (ABBA ABBA) e di due terzine la cui rima è invece variabile: CDC DCD, oppure CDE CDE (che è quella di cui mi servo quasi sempre), o CDE EDC, o CDD CDD, o altre ancora, a seconda dei gusti e dei bisogni. Il metro è, altrettanto tipicamente, l'endecasillabo.
La suddivisione del sonetto in una prima parte di quartine e in una seconda di terzine è utile perché spezza il ritmo della composizione. Questo permette, a sua volta, di utilizzare le quartine per trattare l’argomento in generale e le terzine per scendere nel dettaglio, o di lasciare alle quartine un discorso introduttivo e chiosarlo poi nei sei versi finali. Non c’è alcun obbligo di farlo, in realtà; il sonetto può tranquillamente presentarsi come un corpo organico, come in questo esempio in cui si tenta di ragionare del ruolo del pensiero critico, e che è stato scritto appositamente per Query:
Non sa davvero in fondo come muove
se stesso a volte questo mio pensiero
che passa il guado, perenne straniero,
alla ricerca di fatti e di prove.
Non sa perché cammina, né per dove,
inebriato dall’arte del vero,
accoccolato all’ombra di un mistero
del quale vuol scoprire leggi nuove;
e ha, nella sua foga intransigente,
certezze sghembe sopra dubbi gracili
a cui già qualche regola comanda.
Mi restano, annegate nella mente,
ipotesi di soluzioni facili,
così, fino alla prossima domanda.
Quando ho a disposizione più spazio e posso parlare di argomenti che richiedono un'esposizione più lunga, la mia scelta cade quasi sempre su una qualche variazione della rima incatenata. È una rima incatenata la terzina dantesca: il primo verso rima col terzo, il secondo col quarto e col sesto, il quinto col settimo e col nono, e via così, in una struttura che può essere facilmente memorizzata come ABA BCB CDC DED…
Dalla terzina dantesca si possono derivare altre forme. Per esempio di recente ho sperimentato delle quartine incatenate a schema ABAC BCBD CDCE… Sono strutture che hanno una dinamicità molto pronunciata: si prestano alle narrazioni articolate, portano avanti il discorso senza che si areni su se stesso, senza che trovi una netta conclusione prima della fine del canto, che è composto di solito di un numero di versi nell’ordine del centinaio. Hanno, quindi, la capacità intrinseca di prestare alla poesia la scorrevolezza della prosa, senza per questo toglierle la musicalità propria delle forme chiuse.
Al di là dei meriti della forma, però, resta sempre il problema che il contenuto può essere scritto male: che sia sciatto, o banale, o che fraintenda questioni fondamentali. Per cercare di minimizzare i rischi almeno dal punto di vista stilistico, trovo sia necessario ricorrere a vari espedienti narrativi. Se la forma breve come il sonetto può essere dedicata interamente all’esposizione o all'interpretazione del fenomeno scientifico o della proposizione matematica di cui voglio parlare, infatti, quando scrivo lavori più lunghi cerco di evitare la mera giustapposizione di fatti e di dati e di inserire il tutto in una storia vera e propria, con personaggi, dialoghi, incisi e riflessioni.
Qui, per esempio (è in Teoria dei Canti, che è un poema in terzine sulla fisica, la matematica e il linguaggio), racconto di una macchina che cerca di spiegarmi la teoria della dimostrazione:
Ma nella macchina non si contiene
il sogno più fatale, eppure umano,
che fece Hilbert su tali questioni,
e invece gli crollò, disfatto, in mano.
Di consistenza e formalizzazioni
chiedeva, delle prove, con ampiezza;
del gran problema delle decisioni,
e dell’indipendenza e completezza
che rendono gli assiomi vera forza.
La logica, si vide con asprezza,
finché dei predicati si fa scorza,
completa non si fa, né mai si rende,
e sulla decisione ormai si smorza.
Il problema principale a questo punto, al di là dei vincoli metrici per i quali in fondo è sufficiente esercitarsi, è la scelta del linguaggio adeguato. Bisogna sfruttare le peculiarità del linguaggio poetico, che ama fare uso di metafore, similitudini e accostamenti arditi, e adattarle ai contenuti scientifici o matematici senza banalizzarli troppo. Sono dell’opinione che, quando si sceglie la poesia scientifica, sia sempre bene aver chiaro in mente che si tratta di poesia e non di un modo bizzarro di scrivere saggistica o di fare divulgazione. Si tratta, insomma, di reinterpretare dei concetti che in origine sono espressi in altre forme e di tradurli in forma poetica fino a farli diventare essi stessi materiale poetico, e non solo di scienza impacchettata in versi.
Ogni opera di traduzione comporta inevitabilmente delle distorsioni, ma ritengo che il linguaggio poetico abbia il grande vantaggio di riuscire a sottendere delle domande e a stimolare la curiosità di chi lo legge (e anche di chi lo scrive, lo ammetto) e di dare così forza ulteriore ai concetti scientifici di cui tratta: lo fa proprio in funzione della sua potenziale a-scientificità, cioè della sua intrinseca vaghezza, della sua capacità di percorrere strade oblique e “sentieri che si biforcano”, di cogliere punti di vista insoliti. L’idea è che la sua lettura lasci trasparire la struttura regolare che la sostiene, come si diceva prima, e che al contempo comunichi un senso di sospensione, di bisogno di una ricerca ulteriore; il senso, insomma, che dietro le risposte ci siano comunque altre domande, alcune sciocche, alcune profonde, e che non ci sia dato sapere in anticipo dove ci porteranno. E questo è un altro punto di forza.
Per ciò che riguarda lo stile, ogni componimento cerca di essere scorrevole e leggibile e di evitare gli ermetismi. Non è però, nel complesso, quasi mai una scrittura facile, anche perché deve tener conto dei vincoli di rima e di numero di sillabe metriche. Il rischio peggiore è che sia respingente sia perché tratta di scienza, sia perché lo fa in versi, e quindi che riesca a inimicarsi tanto gli amanti del rigore scientifico quanto quelli della poesia contemporanea. Se si dovesse darne una definizione, non sarebbe semplice rispondere a colpo sicuro. Non è scienza, anche se ne parla, perché difetta dell’approfondimento e dell’accuratezza che invece della scienza sono prerequisiti fondamentali; non è divulgazione, anche se racconta delle storie, perché non ha l’obiettivo di essere chiara e immediatamente fruibile a chi non abbia dimestichezza dei concetti.
Per quanto riguarda la forma e i contenuti, ciò che scrivo è una derivazione della poesia didascalica, riformulata secondo le esigenze narrative di chi si porta sulle spalle la consapevolezza di quella che è stata la letteratura negli ultimi secoli e secondo le esigenze scientifiche uscite dalle rivoluzioni anche epistemologiche che hanno plasmato la scienza moderna. Se poi nel fare ciò io riesca anche a giocare di sponda tra il mondo esterno e le nostre sensazioni più intime, come la poesia cui siamo tutti abituati, sarebbe un risultato eccezionale, ma anche del tutto accidentale. Tuttavia, è vero che tra una rima e l’altra tutto può succedere, e che una poesia finisce spesso con il cogliere di sorpresa in primo luogo chi la scrive. È il bello di trovarsi fra le parole, e fra le strutture che dalle parole riescono a emergere: è lo spaesamento che tocca ai curiosi, una sorta di inquietudine felice davanti alla ricchezza dell'esperienza sensibile a cui la scienza ha dato voce e a cui la poesia ha fornito il controcanto.
ELENA TOSATO si occupa di tenere insieme poesia, matematica e scienza. Tra le altre cose ha pubblicato 32 sonetti sui paradossi in E tutto sembrò falso e sembrò vero (Scienza Express, 2022) e cura una newsletter settimanale, Sillabe (elenatosato.substack.com), in cui fa esperimenti di metrica italiana e poesia didascalica, principalmente su argomenti di matematica e fisica.