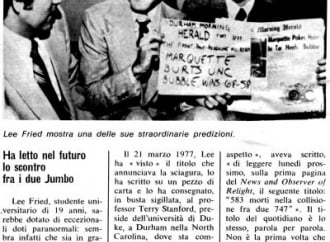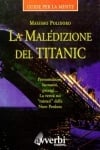Forse un po’ sorprendentemente, l’indagine “scientifica” e sperimentale sulla parapsicologia continua. “Scientifica” è tra virgolette perché se, come ha scritto Andrea Ferrero sullo scorso numero di Query, la pseudoscientificità di una disciplina si può generalmente asserire solo a posteriori dopo aver ricostruito il percorso che ha portato alla sua affermazione, nel caso della parapsicologia lo studio scientifico e accademico ricorda l’accanimento terapeutico su un paziente ormai con poche speranze. (Attenzione: non stiamo parlando della cosiddetta “psicologia anomalistica”, che cerca di spiegare le esperienze paranormali e simili fenomeni bizzarri all’interno del paradigma corrente della conoscenza scientifica, ma di studi che cercano tipicamente di dimostrare l’esistenza di veri e propri fenomeni paranormali).
Continuano infatti a comparire studi sperimentali, per lo più su riviste strettamente specializzate nel campo (il Journal of Parapsychology è tuttora pubblicato ogni due anni dalla Parapsychological Association, anche se l’European Journal of Parapsychology sembra aver cessato le pubblicazioni nel 2010) ma occasionalmente anche su riviste più generaliste, come il Journal of Personal and Social Psychology, autorevole pubblicazione dell’American Psychological Association. Proprio su quest’ultima rivista è uscito nel 2011 uno studio sperimentale[1] in cui Daryl J. Bem, psicologo sociale emerito alla Cornell University, presentava i risultati di nove esperimenti sulla precognizione, otto dei quali avevano risultati positivi in modo statisticamente significativo.
Il lavoro di Bem si inserisce in un filone di ricerca sul “presentimento”: si indaga se i partecipanti allo studio hanno reazioni (psicologiche o fisiologiche) a uno stimolo prima che lo stimolo sia somministrato. Sorprendentemente, le ricerche in questo filone non risalgono agli anni '60 ma iniziano nella seconda metà degli anni '90, e continuano ancora adesso. Come riporta Bem nell’articolo, tra il 1997 e il 2009 sono stati effettuati 24 studi su soggetti umani e due su animali in cui l’effetto sarebbe stato dimostrato attraverso il monitoraggio dell’attività cerebrale per mezzo della risonanza magnetica funzionale (fMRI), un esame che permette di osservare quali aree del cervello si attivino durante l’esecuzione di un compito. Alcune ricerche sono pubblicate su riviste dedicate alla parapsicologia, ma purtroppo molte non sono pubblicate affatto. Per esempio, il riferimento bibliografico dello studio con la fMRI è una presentazione a congresso, non un articolo, mentre quello per i due lavori sugli animali è una personal communication: gli studi non sono pubblicati da nessuna parte ma l’autore li ha descritti a Bem in privato, quindi non abbiamo informazioni sulla loro credibilità.
Il lavoro di Bem ha avuto particolare risonanza per due ragioni: da un lato, è stato pubblicato su una rivista autorevole non specializzata in parapsicologia, dall’altro è uscito proprio nel pieno della “crisi della riproducibilità” di cui abbiamo parlato molte volte in questa rubrica. Lo studio di Bem è stato un esempio ideale da discutere: come fa notare Felipe Romero, filosofo della scienza all'Università di Groningen, nei Paesi Bassi, «se da una parte i risultati non hanno convinto che pochissimi scienziati, la controversia ha generato diffidenza nei confronti del modo in cui gli psicologi conducono i loro esperimenti: Bem ha utilizzato procedure e strumenti statistici usati da molti psicologi sociali»[2]. Vale quindi la pena dare un’occhiata un po’ più approfondita alla questione.
I primi esperimenti sulla precognizione erano tipicamente del tipo a scelta obbligata, in cui ai soggetti era richiesto di indovinare quale di diversi possibili risultati sarebbe stato sorteggiato successivamente, come per esempio indovinare un lancio di dado o l’estrazione di una delle carte Zener (cerchio, croce, quadrato, stella e onda) spesso usate in questi contesti.
Bem, seguendo una tendenza generale nella psicologia sociale e cognitiva, si orienta verso esperimenti in cui lo stimolo tende a essere proposto in modo subliminale, e la reazione è indiretta o addirittura (come nel caso della fMRI) fisiologica. Per esempio, negli esperimenti sul priming, ai soggetti viene richiesto di giudicare più rapidamente possibile se una figura che viene mostrata loro è piacevole o sgradevole. Subito prima della figura, viene mostrata brevemente sullo schermo una parola positiva o negativa, come «bello» o «brutto»: l’idea è che se il carattere della parola è coerente con quello della figura mostrata (cioè, per esempio, «bello» in corrispondenza di una immagine gradevole) il tempo necessario per la valutazione sia più breve. In due degli esperimenti Bem fa esattamente la stessa cosa ma invertendo l’ordine: la figura da valutare veniva mostrata ai soggetti prima della parola, per valutare se ci fosse o meno un effetto di precognizione.
Questo è comunque lo schema di tutti e nove gli esperimenti: si prende un effetto psicologico ben noto e si rifà l’esperimento invertendo la sequenza temporale in modo che la reazione del soggetto sia ottenuta prima che lo stimolo venga prodotto. I protocolli sperimentali sono progettati in modo da prevenire possibili artefatti, come per esempio l’effetto sperimentatore (il test era somministrato attraverso un computer con minima partecipazione degli sperimentatori) o altri di cui di solito non si tiene conto negli esperimenti di psicologia più convenzionali. Per esempio, un risultato positivo è dovuto all’effetto cercato (la precognizione: il soggetto sa in anticipo quello che succederà), alla chiaroveggenza (ha accesso a informazioni “in tempo reale” su quello che sta succedendo), alla psicocinesi (è in grado di influenzare il generatore di numeri casuali del computer)?
I quattro effetti psicologici studiati negli esperimenti sono: approach/avoidance (approccio/evitamento), affective priming, (priming affettivo), habituation (assuefazione) e facilitation of recall (facilitazione del ricordo). Bem ottiene risultati statisticamente significativi in tutti gli studi tranne, per qualche ragione, uno sull’induzione retroattiva della noia, anche se la dimensione dell’effetto è in generale abbastanza piccola. Semplificando molto, questo vuol dire che quello che si osserva è una piccola differenza dovuta alla precognizione, ma questa differenza sarebbe comunque molto improbabile in assenza della precognizione.
L’impatto del lavoro di Bem sulla comunità scientifica si può intuire anche solo guardando il numero di citazioni che l’articolo ha ricevuto: secondo Scopus sono 543, il che basta a piazzarlo nel novantanovesimo percentile. Naturalmente, come primo effetto, la pubblicazione ha suscitato almeno una mezza dozzina di tentativi di replicazione, nessuno dei quali sembra aver ottenuto risultati positivi. Per esempio, pochi mesi dopo è uscito un lavoro di tre psicologi britannici[3] che hanno cercato senza successo di riprodurre tre degli esperimenti di Bem. In un altro molto recente, condotto durante la pandemia e pubblicato nel 2022 su Psychology of Consciousness[4], tre psicologhe dell’Università di Berna hanno usato Internet per raggiungere più di 2000 soggetti e tentato di replicare altri due degli esperimenti, sempre con risultati negativi.
Quello più interessante però è il secondo effetto: il lavoro di Bem ci può insegnare qualcosa sulla riproducibilità attraverso la discussione che ha stimolato, portando tra l’altro al Trasparent Psi Project discusso nel numero scorso. Ma lo spazio è finito e ne parleremo sul prossimo numero.
Continuano infatti a comparire studi sperimentali, per lo più su riviste strettamente specializzate nel campo (il Journal of Parapsychology è tuttora pubblicato ogni due anni dalla Parapsychological Association, anche se l’European Journal of Parapsychology sembra aver cessato le pubblicazioni nel 2010) ma occasionalmente anche su riviste più generaliste, come il Journal of Personal and Social Psychology, autorevole pubblicazione dell’American Psychological Association. Proprio su quest’ultima rivista è uscito nel 2011 uno studio sperimentale[1] in cui Daryl J. Bem, psicologo sociale emerito alla Cornell University, presentava i risultati di nove esperimenti sulla precognizione, otto dei quali avevano risultati positivi in modo statisticamente significativo.
Il lavoro di Bem si inserisce in un filone di ricerca sul “presentimento”: si indaga se i partecipanti allo studio hanno reazioni (psicologiche o fisiologiche) a uno stimolo prima che lo stimolo sia somministrato. Sorprendentemente, le ricerche in questo filone non risalgono agli anni '60 ma iniziano nella seconda metà degli anni '90, e continuano ancora adesso. Come riporta Bem nell’articolo, tra il 1997 e il 2009 sono stati effettuati 24 studi su soggetti umani e due su animali in cui l’effetto sarebbe stato dimostrato attraverso il monitoraggio dell’attività cerebrale per mezzo della risonanza magnetica funzionale (fMRI), un esame che permette di osservare quali aree del cervello si attivino durante l’esecuzione di un compito. Alcune ricerche sono pubblicate su riviste dedicate alla parapsicologia, ma purtroppo molte non sono pubblicate affatto. Per esempio, il riferimento bibliografico dello studio con la fMRI è una presentazione a congresso, non un articolo, mentre quello per i due lavori sugli animali è una personal communication: gli studi non sono pubblicati da nessuna parte ma l’autore li ha descritti a Bem in privato, quindi non abbiamo informazioni sulla loro credibilità.
Il lavoro di Bem ha avuto particolare risonanza per due ragioni: da un lato, è stato pubblicato su una rivista autorevole non specializzata in parapsicologia, dall’altro è uscito proprio nel pieno della “crisi della riproducibilità” di cui abbiamo parlato molte volte in questa rubrica. Lo studio di Bem è stato un esempio ideale da discutere: come fa notare Felipe Romero, filosofo della scienza all'Università di Groningen, nei Paesi Bassi, «se da una parte i risultati non hanno convinto che pochissimi scienziati, la controversia ha generato diffidenza nei confronti del modo in cui gli psicologi conducono i loro esperimenti: Bem ha utilizzato procedure e strumenti statistici usati da molti psicologi sociali»[2]. Vale quindi la pena dare un’occhiata un po’ più approfondita alla questione.
I primi esperimenti sulla precognizione erano tipicamente del tipo a scelta obbligata, in cui ai soggetti era richiesto di indovinare quale di diversi possibili risultati sarebbe stato sorteggiato successivamente, come per esempio indovinare un lancio di dado o l’estrazione di una delle carte Zener (cerchio, croce, quadrato, stella e onda) spesso usate in questi contesti.
Bem, seguendo una tendenza generale nella psicologia sociale e cognitiva, si orienta verso esperimenti in cui lo stimolo tende a essere proposto in modo subliminale, e la reazione è indiretta o addirittura (come nel caso della fMRI) fisiologica. Per esempio, negli esperimenti sul priming, ai soggetti viene richiesto di giudicare più rapidamente possibile se una figura che viene mostrata loro è piacevole o sgradevole. Subito prima della figura, viene mostrata brevemente sullo schermo una parola positiva o negativa, come «bello» o «brutto»: l’idea è che se il carattere della parola è coerente con quello della figura mostrata (cioè, per esempio, «bello» in corrispondenza di una immagine gradevole) il tempo necessario per la valutazione sia più breve. In due degli esperimenti Bem fa esattamente la stessa cosa ma invertendo l’ordine: la figura da valutare veniva mostrata ai soggetti prima della parola, per valutare se ci fosse o meno un effetto di precognizione.
Questo è comunque lo schema di tutti e nove gli esperimenti: si prende un effetto psicologico ben noto e si rifà l’esperimento invertendo la sequenza temporale in modo che la reazione del soggetto sia ottenuta prima che lo stimolo venga prodotto. I protocolli sperimentali sono progettati in modo da prevenire possibili artefatti, come per esempio l’effetto sperimentatore (il test era somministrato attraverso un computer con minima partecipazione degli sperimentatori) o altri di cui di solito non si tiene conto negli esperimenti di psicologia più convenzionali. Per esempio, un risultato positivo è dovuto all’effetto cercato (la precognizione: il soggetto sa in anticipo quello che succederà), alla chiaroveggenza (ha accesso a informazioni “in tempo reale” su quello che sta succedendo), alla psicocinesi (è in grado di influenzare il generatore di numeri casuali del computer)?
I quattro effetti psicologici studiati negli esperimenti sono: approach/avoidance (approccio/evitamento), affective priming, (priming affettivo), habituation (assuefazione) e facilitation of recall (facilitazione del ricordo). Bem ottiene risultati statisticamente significativi in tutti gli studi tranne, per qualche ragione, uno sull’induzione retroattiva della noia, anche se la dimensione dell’effetto è in generale abbastanza piccola. Semplificando molto, questo vuol dire che quello che si osserva è una piccola differenza dovuta alla precognizione, ma questa differenza sarebbe comunque molto improbabile in assenza della precognizione.
L’impatto del lavoro di Bem sulla comunità scientifica si può intuire anche solo guardando il numero di citazioni che l’articolo ha ricevuto: secondo Scopus sono 543, il che basta a piazzarlo nel novantanovesimo percentile. Naturalmente, come primo effetto, la pubblicazione ha suscitato almeno una mezza dozzina di tentativi di replicazione, nessuno dei quali sembra aver ottenuto risultati positivi. Per esempio, pochi mesi dopo è uscito un lavoro di tre psicologi britannici[3] che hanno cercato senza successo di riprodurre tre degli esperimenti di Bem. In un altro molto recente, condotto durante la pandemia e pubblicato nel 2022 su Psychology of Consciousness[4], tre psicologhe dell’Università di Berna hanno usato Internet per raggiungere più di 2000 soggetti e tentato di replicare altri due degli esperimenti, sempre con risultati negativi.
Quello più interessante però è il secondo effetto: il lavoro di Bem ci può insegnare qualcosa sulla riproducibilità attraverso la discussione che ha stimolato, portando tra l’altro al Trasparent Psi Project discusso nel numero scorso. Ma lo spazio è finito e ne parleremo sul prossimo numero.
Note
1) Bem D.J., 2011. “Feeling the future: experimental evidence for anomalous retroactive influences on cognition and affect”, in Journal of Personal and Social Psychology, n. 100
2) Romero F., 2019. “Philosophy of Science and The Replicability Crisis”, in Philosophy Compass n. 14
3) Ritchie S.J., Wiseman R., French, C. C., 2012. “Failing the future: Three unsuccessful attempts to replicate Bem’s 'retroactive facilitation of recall’ effect”, in PLoS ONE, vol. 7, n. 3
4) Muhmenthaler M. C., Dubravac M. , Meier B., 2022. “The Future Failed: No Evidence of Precognition in a Large Scale Replication Attempt of Bem (2011)”, in Psychology Conscious. Pubblicazione anticipata online
STEFANO BAGNASCO è fisico e lavora presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dove si occupa anche di divulgazione scientifica