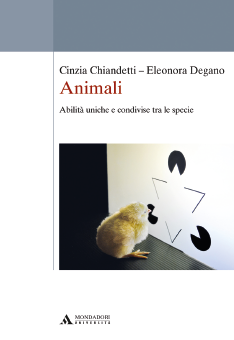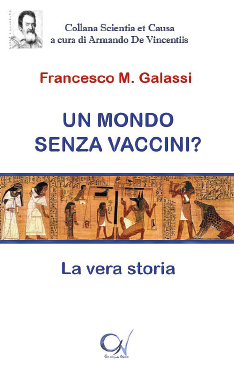Animali. Abilità uniche e condivise tra le specie
Cinzia Chiandetti, Eleonora Degano
Mondadori Education, 2017
pp. 179, € 16
Recensione e intervista di Simone Raho
Homo sapiens è una specie fin troppo egocentrica, diciamolo apertamente. Quante volte ha utilizzato se stessa e i suoi sensi come unico e infallibile metro di giudizio per rappresentare, descrivere o semplicemente raccontare le altre realtà esistenti nel mondo animale? Quasi a volerci vedere come il fine ultimo in una sorta di progetto della Natura (la maiuscola non è messa a caso), o per usare un termine sin troppo di moda, l’esito di “intelligent design” o creazionismo “scientifico” (che di scientifico non ha proprio nulla), tendiamo sin troppo spesso a considerarci degli esseri speciali, all’apice di una immaginaria e sin troppo semplicistica piramide che raggruppa tutte le specie viventi. Protagonisti unici e privilegiati, con un posto in poltrona e in prima fila all’interno di quel grande teatro che è il nostro pianeta.
Ma siamo davvero certi di essere così unici e singolari come specie? Davvero via via che ci si allontana da noi in questa ipotetica piramide della vita le capacità cognitive degli esseri viventi decrescono? Cosa, in realtà, condividiamo con il resto del mondo animale e cosa ci rende diversi?
Queste sono solo alcune delle domande a cui Cinzia Chiandetti (ricercatrice dell’Università di Trieste) e Eleonora Degano (giornalista scientifica) cercano di dare una risposta obiettiva nel loro bel libro Animali. Abilità uniche e condivise tra le specie.
Lo stile del libro è rigoroso e puntuale, ma questo rigore scientifico non sfocia mai nel tecnicismo, anzi la lettura scorre piacevole ed è pienamente fruibile anche per il lettore meno avvezzo alla terminologia biologica. Nel testo, inoltre, sono presenti anche alcuni episodi curiosi e divertenti, e la trattazione non si limita a menzionare esempi di animali conosciuti al grande pubblico, ma spazia agevolmente all’interno delle varie categorie tassonomiche, in maniera da fornire un quadro quanto più variegato e ampio possibile.
Un libro senz’altro consigliato, che, come le letture davvero utili, risponde a degli interrogativi e, nello stesso tempo, lascia il lettore con qualcosa in più a cui pensare.
A tal proposito, approfittiamo della gentilezza delle autrici per porre loro alcune domande.
Un testo divulgativo che parla, tra le altre cose, delle abilità cognitive degli animali. L’argomento è certamente interessante e in grado di fornire numerosi spunti di riflessione, non solo in ambito strettamente biologico o scientifico. Cosa vi ha spinto a collaborare per scrivere un libro su questo argomento?
Cinzia Chiandetti: All’Università di Trieste insegnavo Psicologia Animale e Comparata e negli anni avevo accumulato un corpus di studi che presentavo agli studenti, quando ho avuto modo di scoprire “una bella penna” in Eleonora, che mi mandò una ricca prima bozza della sua tesi di laurea. Scoprendo casualmente, qualche tempo dopo, che aveva intrapreso la strada del giornalismo scientifico, ho pensato di chiederle di aiutarmi a rendere quei contenuti “didascalici” più facilmente fruibili da un pubblico di ampio respiro. E così abbiamo iniziato la collaborazione trattando di svariati animali, più e meno noti, ciascuna approfondendo gli aspetti di sua competenza. Desideravo avere un testo di riferimento che riportasse i risultati di rigorosi studi scientifici sulle capacità mentali degli animali e i criteri condivisi dalla comunità scientifica sulle caratteristiche che questi devono avere per essere annoverati, ad esempio, come insegnamento o imitazione. Mancava, inoltre, tra i vari testi sugli animali in commercio, un approfondimento delle competenze di base che accomunano molti animali non umani ai bambini in età preverbale e agli adulti quando con degli stratagemmi è prevenuto l’uso del linguaggio verbale. Su questi mattoni di base si poggiano le successive occasioni di apprendimento che ogni animale ha nella propria nicchia e così si forgiano anche le differenze tra le specie. Siamo tutti molto simili, ma non uguali, e nella convivenza con le altre specie anche le differenze vanno considerate e rispettate.
Eleonora Degano: La collaborazione è nata svariati anni fa, perché Cinzia è stata la relatrice per la mia tesi di laurea sulle abilità cognitive degli uccelli giardinieri; sono uccelli famosi perché costruiscono e abbelliscono dei pergolati per attirare le femmine, sfruttando anche un’illusione ottica per rendersi più imponenti ai loro occhi. I pergolati sono “palcoscenici naturali” decorati con sassi, funghi, muschio ma anche elementi artificiali come bottoni, tappi di bottiglia e mollette per il bucato. Nel libro parliamo anche di loro, ma più in generale il testo è stato per me l’occasione di affrontare un tema che attira ancora poco i media, salvo i rari casi di video virali che hanno spesso per protagoniste specie già famose per la loro intelligenza, come scimpanzé o delfini. Dobbiamo prendere continuamente decisioni legate agli animali: quando scegliamo cosa mangiare e cosa no, come convivere con i pet come cani e gatti, che rapporto avere con compagni di sport come i cavalli. Poi andiamo in vacanza in luoghi esotici e ci vengono proposte attività legate alla fauna selvatica che dobbiamo scegliere se supportare o no, come trekking sugli elefanti, foto ricordo, escursioni e via dicendo. Conoscere le altre specie è importante per fare scelte informate, soprattutto ora che molte di esse sono in pericolo per il bracconaggio, i cambiamenti climatici, la deforestazione e in questo abbiamo una grande responsabilità. Ma allo stesso tempo non si può avere a cuore la sorte di ciò che non si conosce.
Per la tematica e gli argomenti esposti nel libro, appare evidente che un rigoroso approccio sperimentale è la condizione imprescindibile per ottenere dei risultati corretti e non falsati. E numerosi sono i riferimenti in tal senso nell’opera. Anche l’interpretazione dei risultati richiede la massima cautela e prudenza. Cosa si può fare secondo voi per evitare orientamenti eccessivamente antropocentrici? Si può essere perfettamente obiettivi o un minimo di condizionamento è in ogni caso inevitabile?
CC: Da un lato credo sia inevitabile dare significato alla realtà solo con i nostri occhi, umani. L’antropocentrismo è centrale in ogni ambito, anche ad esempio nella filmografia fantascientifica: perché ogni creatura aliena ha fattezze umanoidi? Non c’è alcuna ragione se non un antropocentrismo assoluto (che diventa addirittura antropomorfismo). Dall’altro lato, la tendenza opposta, una sorta di antropodiniego – come l’ha chiamata il grande primatologo Frans de Waal – è altrettanto rischiosa per chi studia il comportamento delle altre specie, perché può portare a perdere il significato del comportamento osservato. Sforzarsi di interpretare un’interazione o un gesto solo sulla base della topografia esclude ogni aspetto caratterizzante e ne fa perdere il valore. D’altro canto, anche le situazioni che creiamo in laboratorio per valutare le capacità di una certa specie soffrono sempre del nostro modo di ragionare e interpretare la realtà. Però, una buona conoscenza dell’ecologia della specie aiuta a evitare gli scivoloni più imbarazzanti. Pensare che gli scorpioni siano capaci di suicidio perché rivolgono il pungiglione verso loro stessi è un’ingenuità di chi indossa le lenti dell’antropocentrismo ma non è neppure consapevole del contesto in cui questo comportamento si manifesta, ovvero solo in seguito all’applicazione di uno stimolo nocivo all’estremità posteriore. Nel tentativo di colpire l’aggressore, lo scorpione colpisce se stesso. È con questa consapevolezza che possiamo limitare il più possibile i danni del confronto: cercando di entrare nella visione soggettiva delle altre specie.
ED: Da un punto di vista giornalistico, credo che la scelta del linguaggio possa spesso fare la differenza. Quando si riporta la notizia di una capacità animale, la formula usuale è dire che la tal specie è capace di qualcosa (ad esempio di empatia o cooperazione) “proprio come noi”. Andrebbe lasciato da parte il continuo confronto tra noi e gli altri animali come se l’essere umano fosse il metro di misura, come se dovessimo convincere il lettore che, sì, tutto sommato vale la pena di investire per salvare le altre specie perché ci somigliano. Insistendo su questo paragone, poi, si fa quasi passare il messaggio che le necessità quotidiane sono le stesse per tutte le specie. O meglio, che sono le nostre per tutte le specie! Abbandonare questo approccio antropocentrico non è semplice, credo che il continuo paragone e il ritrovarci in altri animali ci aiuti a sentirli più vicini e ad avere, così, a cuore la loro sorte. La sfida penso stia nel trovare una chiave di lettura che non sminuisca le altre specie e che non ceda all’eccessiva semplificazione per rendere lo studio delle loro menti più comprensibile. Sui media si può fare molto, partendo dal rinunciare al sensazionalismo e a etichettare come “eccezionali” quelle che sono alla fine una manciata di abilità scelte arbitrariamente da noi. Probabilmente dovremmo tutti essere più esigenti: chi produce i contenuti e chi ne usufruisce, i lettori.
Come avete ben spiegato, l’idea stessa che alcune strutture neurali siano specializzate in maniera congenita in specifiche funzioni è qualcosa che, con modalità differenti, risale addirittura al XIX secolo con lo sviluppo della frenologia, le cui pericolose derive razziste, in alcuni casi, sono state purtroppo sotto gli occhi di tutti. E allora, per chiarire bene la faccenda, quali sono stati gli errori dei frenologi?
CC: Il primo errore dei frenologi è stato quello di proporre facoltà mentali improbabili, chiamate peraltro attitudini non funzioni, prive di ogni fondamento scientifico. Troviamo, ad esempio, l’amore per la propria prole o il talento poetico, a indicare una psicologia ingenua e immatura. Il secondo errore è stato quello di pensare che lo sviluppo delle aree cerebrali fosse rivelato dalla conformazione esterna del cranio: i frenologi parlavano di veri e propri bernoccoli che, se rilevati, indicavano quanto quell’individuo fosse portato per un certo ambito. Darwin stesso è stato oggetto della loro analisi, come ci racconta nella sua autobiografia. I frenologi si sarebbero addirittura avvalsi della sola ispezione di una foto della testa di Darwin per determinare la sua attitudine al ruolo di pastore per via di «un bernoccolo della religione così sviluppato che sarebbe stato sufficiente per dieci preti».
I frenologi però avevano anticipato due concetti che le moderne neuroscienze hanno dimostrato empiricamente in modo robusto: da un lato un modularismo moderato, per cui vi sono aree cerebrali specializzate nella codifica e nell’analisi di certi stimoli e non di altri, una proprietà dell’organizzazione cerebrale più adeguata rispetto alla possibilità che ogni distretto del cervello possa computare ogni aspetto della realtà (abbiamo aree specifiche per il linguaggio, per la visione, per le informazioni spaziali). Oltre a questa divisione dei lavori, i frenologi avevano correttamente intuito che la pratica può modificare la rappresentazione corticale: non sotto forma di bernoccoli, ma in una più ampia rappresentazione corticale, ovvero di un numero maggiore di neuroni che si specializza in un certo compito per migliorare la prestazione.
ED: Aggiungerei che l’idea che una caratteristica fisica possa svelare dettagli su indole, personalità o altro non si può relegare a un passato remoto. È dello scorso anno uno studio che ha suscitato molto scalpore in una direzione simile. Gli scienziati di Stanford hanno sottoposto oltre 35.000 immagini di volti a un’intelligenza artificiale e l’hanno addestrata a distinguere le persone omosessuali da quelle eterosessuali. L’accuratezza avrebbe superato l’80% per i visi maschili e il 70% per quelli femminili e tra le spiegazioni addotte nello studio ci sarebbero tratti “atipici” per il genere di appartenenza: i volti di uomini gay sarebbero più “femminili” e viceversa per le donne gay, il che li renderebbe riconoscibili dall’IA. Le implicazioni sono preoccupanti e necessitano di una riflessione sotto molti punti di vista: la discriminazione verso le persone omosessuali non è affatto cosa superata e ci sono Paesi nei quali, anche se ci sembra incredibile, l’omosessualità è perseguita per legge. Mentre sui dettagli e i molti limiti dello studio si continua a discutere, questa è senz’altro un’occasione per iniziare a riflettere su come utilizzare al meglio le tecnologie avanzate che abbiamo sviluppato, affinché portino progresso e uguaglianza e non facilitino invece la discriminazione.
In un passaggio chiave del libro descrivete come i volti siano uno stimolo talmente potente, che ci capita di vederli anche in elementi che non hanno in alcun modo a che vedere con le facce. Possiamo dunque dire che tutto questo può essere considerato come una sorta di base biologica di quel fenomeno più vasto che va sotto il nome di pareidolia?
CC: Direi di sì. Evolutivamente parlando, la capacità di accorgersi, anche sulla base di indizi essenziali, che nelle nostre vicinanze c’è potenzialmente un altro organismo è fondamentale, visto che permette di identificare un predatore (e quindi di fuggire) oppure di scorgere una preda (e quindi di procacciarsi un pasto). Essendo iperattivo, ci aiuta anche in situazioni in cui la visibilità è ridotta o vi sono pochi indizi, magari perché preda o predatore sono parzialmente occlusi da un arbusto. Proprio studiando e scoprendo un meccanismo estremamente sensibile e universale come questo, capiamo che è possibile anche fornire una spiegazione razionale a ipotetiche apparizioni di volti sulle più disparate superfici o nei più svariati contesti.
ED: Sì e la pareidolia fornisce l’occasione perfetta per parlare di questi temi. Che si tratti del viso di Gesù comparso sulle bruciature dei toast o su una porta di legno da Ikea, del Volto su Marte o ancora del Monkey Tree Phenomenon (quando, una decina di anni fa, tra le nodosità di un grosso albero a Singapore si è palesata una divinità scimmia) è intrigante pensare di avere dei meccanismi innati e condivisi con altre specie per individuare i volti e riconoscerli come tali. Quando leggiamo di queste “apparizioni”, riportate in tutto il mondo da decenni, pensiamo inevitabilmente a persone molto suggestionabili. In realtà, perlomeno nella maggior parte dei casi, questo non è altro che il segno che il nostro cervello funziona come dovrebbe e oggi sappiamo che ci sono popolazioni di neuroni che si attivano proprio per “decodificare” le facce, nella loro classica composizione con due elementi in alto e uno più in basso.
Il fatto che diversi studi abbiano fatto emergere che alcune capacità cognitive basali sono condivise da diverse categorie tassonomiche nel regno animale potrebbe per certi versi essere interpretato come una sorta di “demolizione progressiva dell’antropocentrismo”? Un percorso iniziato da lontano, che parte dalla rivoluzione copernicana, prosegue con Darwin e arriva sino ai giorni nostri e agli ultimi studi sulle capacità cognitive degli animali esposte in libri come il vostro. Qual è la vostra idea al riguardo?
CC: L’uomo tende ancora a torreggiare sul gradino più alto di una graduatoria intuitiva delle specie animali: semplici e meno dotate intellettualmente (paguri) sul gradino più basso, complesse e molto capaci (delfini) sui gradini più alti. Oggi, grazie alla divulgazione dei risultati scientifici, ma anche grazie alla maggior disponibilità di dispositivi mobili con cui immortalare episodi singolari, le persone sono chiamate a una riflessione: si tratta di un animale addestrato, un aneddoto, o una caratteristica del gruppo o della specie? I ricercatori, poi, studiano in condizioni controllate se una certa specie sia davvero capace di un dato comportamento. Nel caso del gioco, ad esempio, non possiamo dire nulla sull’esperienza qualitativa (si divertono?), ma possiamo scoprire che è occasione di apprendimento negli adulti (non solo nei cuccioli che simulano la lotta per affinare le tecniche di combattimento). Quanto al corvo che fa snowboard, l’animale impara come funzionano le cose: il ghiaccio consente di scivolare, la neve fresca si accumula impendendo lo scorrimento della tavoletta, il tetto asciutto crea troppo attrito... Così capiamo anche perché possiamo osservare un corvo che sposta un cachi dall’asfalto – liscio – alla parte più terrosa dove una maggior aderenza consente di spolpare più agevolmente il frutto. Questa fisica intuitiva è una delle competenze di base che sembrano condivise da un gran numero di specie animali. Poi tutto dipende da che cosa serve per sopravvivere al meglio in un certo ambiente.
ED: Fino a pochi decenni fa, anche solo parlare di intelligenza in riferimento ad altre specie oltre all’essere umano sarebbe stato accolto con un certo scetticismo. Perciò, sì, la situazione è andata cambiando e si è presentata l’opportunità, nonché la sfida, di studiare approfonditamente la mente e le capacità degli animali ingegnandosi nell’elaborare esperimenti per farli esprimere al meglio. Ora si può discutere di cultura degli altri animali, le loro necessità (biologiche, etologiche, cognitive) vengono tenute in considerazione per il loro benessere e via dicendo. Allo stesso tempo, però, se andiamo a guardare i danni causati dalle attività antropiche sul pianeta e il nostro approccio allo sfruttamento delle risorse, non sembra eccessivo dire che viviamo ancora come se tutto ciò che ci circonda fosse lì per noi, a nostra completa ed esclusiva disposizione. Sono sempre le altre specie a doversi “fare un po’ più in là”. Dunque sì, sul fronte “intellettuale” stiamo progressivamente abbandonando l’antropocentrismo, ma poi nella pratica non sempre si vedono i risultati o si agisce in base alle conoscenze raggiunte.
Un mondo senza vaccini?
Francesco M. Galassi
C1V, 2017
pp. 160, € 15,00
Recensione di Simone Raho
Chissà, forse anche alcune teorie pseudoscientifiche possono essere considerate, per certi versi, di tendenza. Se, con un po’ di ironia, ci è concessa questa affermazione, allora senza ombra di dubbio, questo è il periodo in cui sono “di moda” le correnti antivacciniste. Il valore delle vaccinazioni è stato certamente messo in dubbio più volte da quando è stata introdotta questa pratica medica, ma forse mai come ai giorni nostri il dibattito è stato così aspro e acceso, tanto che è persino rientrato di prepotenza nella recente campagna elettorale, facendo spostare la questione dal piano scientifico a quello politico.
D’altro canto, la risposta della scienza, quella vera, non si è fatta attendere. La divulgazione scientifica seria ha proposto diverse pubblicazioni e libri sul tema, in maniera da spiegare in modo chiaro ed efficace ai non addetti ai lavori tutti i benefici derivanti dalla pratica vaccinale e, allo stesso tempo, smontare tutte le fake news (per usare un termine divenuto anch’esso di moda) tendenti ad alimentare preoccupazioni e paure infondate nella gente.
E allora perché, ci si chiederà, ancora un libro sui vaccini? Per farla breve: perché questo libro è diverso dagli altri. O, meglio, offre una prospettiva differente sull’argomento vaccini, legandola a filo doppio al contesto storico. L’autore, Francesco Maria Galassi, è medico, ma soprattutto è un esperto di paleopatologia, la scienza che studia le malattie direttamente sui resti fossili. Pertanto essa, insieme alla storia della medicina, ha l’importantissimo compito di poterci dare l’idea di quello che era il mondo prima che le vaccinazioni esistessero.
Il libro di Galassi ha l’indubbio merito di porre l’attenzione del lettore sui reali pericoli e sulle false aspettative che riguardano il sempre troppo vagheggiato ritorno ai “bei tempi che furono”, un mondo troppo spesso auspicato in quanto preso a modello di bucolico ritorno alla Natura, madre compassionevole e comprensiva, dispensatrice dei suoi frutti benevoli. Grazie a un viaggio virtuale attraverso la storia, l’autore accompagna noi lettori, fonti e dati scientifici alla mano, in una realtà che purtroppo può discostarsi molto da quell’ideale, forse un po’ troppo utopistico, impresso nelle nostre teste. La cruda verità dell’epoca prevaccinale è, infatti, anche quella di un mondo in cui l’umanità veniva spesso falcidiata da epidemie mortali. Galassi, attraverso esempi concreti, che vanno dai faraoni al Medioevo, sino ad arrivare ai giorni nostri, ricostruisce in maniera impeccabile l’evoluzione di molte malattie, dal vaiolo alla tubercolosi, sino al fin troppo sottovalutato morbillo.
La lezione storica che ci propone l’autore è cruda, reale, vivida ma estremamente efficace, in quanto la memoria collettiva può essere fallace: nell’epoca contemporanea tendiamo, infatti, a dimenticare gli enormi vantaggi e benefici che la pratica vaccinale ha introdotto in ambito medico. Come più di qualcuno ha ricordato, probabilmente i vaccini sono vittime incolpevoli del loro stesso successo. Per questo la storia, e libri come quello di Galassi, possono contribuire in maniera determinante ad aiutare noi tutti a ricordarne l’importanza.
Frankenstein. Il mito tra scienza e immaginario
Marco Ciardi, Pier Luigi Gaspa
Carocci editore, 2018
pp. 199, € 18,00
Recensione di Anna Rita Longo
Un volto dal colorito cereo, una fronte alta solcata da una grossa cicatrice e da punti metallici, le palpebre pesanti calate sugli occhi e due elettrodi che spuntano ai lati del collo: il nome di Frankenstein evoca istintivamente questa immagine, entrata nella cultura popolare all’apparire sul grande schermo del famosissimo film di James Whale del 1931. La Creatura ideata da Mary Shelley assumeva, così, il volto di Boris Karkoff, l’attore che la interpretava, rimanendovi definitivamente associata. Quella Creatura che, nel corso del tempo, aveva finito col diventare la protagonista della storia, rubando, contro la volontà della scrittrice inglese che l’aveva ideata, anche il nome al dottor Victor Frankenstein che le aveva infuso la vita.
Scritto nel duecentesimo anniversario della prima edizione del romanzo di Mary Shelley, questo libro di Marco Ciardi – storico della scienza dell’Università di Bologna – e Pier Luigi Gaspa – studioso dei media, del cinema e dei fumetti – traccia la storia non solo dell’opera letteraria, ma soprattutto del mito che ne è scaturito, il quale offre un’importante chiave interpretativa della cultura che lo ha prodotto.
Il saggio si apre con un necessario ragguaglio sulle circostanze in cui l’opera di Mary Shelley è stata concepita e scritta. Segue una parte dedicata alle fonti dell’opera, dove l’accento non è posto su quelle letterarie, su cui si è detto e scritto tantissimo, bensì su quelle scientifiche, che vengono illustrate in tutta la loro complessità e molteplicità, seguendo nel frattempo la trama del romanzo, che è necessario rispolverare perché spesso confusa e sovrapposta a quella dei film che ne sono stati tratti. È in particolare questa attenzione alla scienza e alla tecnica che, come dimostrano gli autori, rende innovativa l’opera di Mary Shelley e che fornisce le basi per il mito, che non mostra, a distanza di duecento anni, segni di invecchiamento. Segue un breve capitolo che tenta di desumere l’anno in cui la storia è ambientata sulla base di indizi interni. A partire dal quarto capitolo si apre la parte centrale del discorso, che esamina l’origine del mito di Frankenstein, nato con la trasposizione teatrale del 1823 e che si è consolidato nelle innumerevoli traduzioni di cinema, televisione, fumetti. Ciardi e Gaspa notano come, tra le molte chiavi di lettura che il romanzo offre, il mito scelga esclusivamente la condanna moralistica della hybris dello scienziato, accusato di manipolare le leggi della natura. Un elemento che, dalla critica al positivismo tipica del Romanticismo, arriva all’attuale scetticismo nei riguardi del progresso scientifico, che riempie di ammirazione e, insieme, di paura e diffidenza. Non a caso, nelle varie incarnazioni del mito di Frankenstein, si aggiornano le procedure attraverso le quali si infonde vita alla mostruosa Creatura, come riflesso del modificarsi delle paure legate alla scienza. Eppure, come notano gli autori, la vera lezione del mito di Frankenstein è che gli effetti positivi o negativi della scienza dipendono esclusivamente dalle scelte degli esseri umani e dalla loro disponibilità ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni. «Una responsabilità che si deve manifestare non solo attraverso la scoperta di nuove leggi e nuovi fenomeni dell’universo o la realizzazione di strumenti e prodotti, ma sforzandosi di spiegare quotidianamente, a partire dall’educazione scolastica, quali sono i principi e i valori fondamentali alla base della scienza moderna» (p. 184). Visti i riflessi della scienza sul benessere degli esseri umani, si tratta di una lezione importante, che riguarda tutti.
Fatti, misfatti e strane presenze
Alessandro Badaloni
Affinità elettive, 2017
pp. 92, € 12,00
Recensione di Valentina Sordoni
Di fantasmi è ricca la letteratura, dall’epica alla narrativa, dalla poesia al folklore. Più di altre creature fantastiche, gli spettri catalizzano le suggestioni del singolo e della collettività, scatenando una ricerca spasmodica di risposte, laddove l’irrazionale prevarica la ragione. Presenze evanescenti, spesso oniriche e sempre ineffabili, inquietano e solleticano l’immaginario umano, pronto a scommettere sulla loro esistenza, convinto di sentirle e, perché no, di vederle. Succede allora che qualche scettico non sia d’accordo e di fronte agli incalzanti interrogativi dei familiari, convinti di abitare una casa infestata di fantasmi nel cuore di Ancona, decida di smontare un’evidente assurdità con un viaggio a ritroso tra storia, mito e leggenda, che fa della città un teatro di delitti, eresie e violenze, storie oscure che circolano ancor oggi, alimentando stravaganti percezioni.
Alessandro Badaloni le racconta nel volume Fatti, misfatti e strane presenze. Ombre e misteri nella storia di Ancona, edito da Affinità elettive. Un libretto brillante che unisce allo studio delle fonti un taglio ironico e beffardo nel divertirsi e divertire di tanta ingenuità il lettore, trascinato nei vicoletti già crogiolo di mercanti, nei palazzi covo di eretici, di presunte streghe e inquisitori, dove la storia incontra la fantasia popolare confermandoci, alla prova dei fatti, che un solo spirito sopravvive adeguandosi al trascorrere inesorabile del tempo. Quale? Quello «ributtante dei predicatori di falsità che allora si manifestava in squallidi trattati oggi invece imperversa sui “social” e sulla carta stampata, in cui si sottoscrivono e diffondono continuamente false notizie per suscitare rabbia e risentimento, talvolta feroce, nei più stupidi creduloni».
Un testo, quello di Badaloni, che attraverso una leggera narrazione storica ha soprattutto il merito di focalizzarsi, en passant, tra spettri e assassini, pontefici e santi, sulla questione molto preoccupante delle fake news, così temibile che spaventerebbe persino i fantasmi, se solo esistessero!