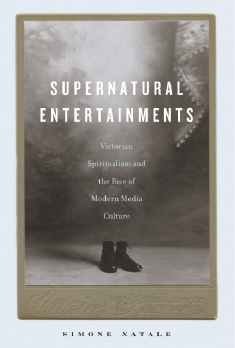Sotto i nostri piedi
di Alessandro Amato
Codice Edizioni, 2016
pp. 238, € 15
Recensione e intervista di Pasquale Supino
Quando non si trovano spiegazioni plausibili per comprendere un fenomeno, è più facile affidarsi all’irrazionale. Colpito da una malattia oscura e incurabile, l’essere umano spesso è spinto dalla disperazione ad affidarsi a santoni o presunti tali che, dietro pagamento di laute ricompense, promettono guarigioni o miglioramenti che non arriveranno mai. La situazione peggiora in caso di eventi che coinvolgono migliaia di persone. Prendiamo l’esempio del terremoto: colpisce all’improvviso, senza alcuna avvisaglia e ci lascia sgomenti il fatto che gli scienziati non riescano a prevederlo. Rischiamo, pertanto, di dare credito a personaggi di vario tipo che, con strumenti più o meno improbabili, promettono di regalarci la via per la salvezza, anticipando data e ora di ogni scossa che gli studiosi “cattivi” e gli immancabili “poteri forti”, per oscuri motivi, si rifiutano di farci conoscere.
Ad accendere un riflettore di scientificità su tutte le questioni che ruotano intorno ai terremoti è Alessandro Amato, sismologo e dirigente di ricerca all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che, con il suo recente Sotto i nostri piedi, compie un excursus storico e culturale chiaro e approfondito, allo scopo di spiegare, tra le altre cose, come nascono le scosse, perché attualmente sia impossibile prevederle con esattezza e, in definitiva, come il modo più sensato per evitare o ridurre al minimo i danni causati dai terremoti sia tanto semplice quanto inattuato: costruire edifici più sicuri.
Approfittiamo della disponibilità dell’autore per approfondire con lui alcuni argomenti trattati nel libro.
Dott. Amato, inizio la chiacchierata col chiederle del famigerato “Atroce”, l’essere dallo stravagante aspetto, ma dalla fine intelligenza, che l’ha tempestata di domande a seguito del terremoto che ha colpito l’Umbria e le Marche nel 1997: è da quell’episodio che è nata l’esigenza di scrivere un libro divulgativo sui terremoti, in modo da consentire anche ai non addetti ai lavori di avere una conoscenza scientifica dei fenomeni tellurici?
L’incontro con l’Atroce che racconto nel Prologo è stato importante, perché ha rappresentato uno dei miei primi impatti da ricercatore con la società. Era stato preceduto da un altro episodio analogo qualche anno prima. A Rocca di Papa (Roma), nel corso di un lungo sciame sismico che aveva provocato dei danni e innervosito molto gli abitanti dei Colli Albani, il Comune organizzò un incontro con i cittadini e invitò il mio collega Rodolfo Console e me. Rodolfo era uno dei migliori sismologi in circolazione in Italia, mentre io ero un giovane ricercatore alle prime armi che stava studiando quell’attività sismica. Feci una relazione tecnica in cui provai a spiegare le cause di quei terremoti, che avevano a che fare con la “recente” attività del Vulcano Laziale. Armato di decine di slide a colori, cercavo di far capire concetti geologici e sismologici a persone preoccupate, impaurite, che mi guardavano smarrite. Alla fine un signore anziano si alzò, venne verso di noi che eravamo al tavolo dei relatori insieme al sindaco, con fare minaccioso. Arrivato a due passi da me si alzò la canottiera mostrando un’orrenda ferita infetta e apostrofò il sindaco con parole irripetibili, reclamando un alloggio decente perché, disse, nel container che gli avevano assegnato non poteva stare. Ecco, nei corsi di geologia all’università non mi avevano insegnato niente di tutto questo. Iniziai a capire che fare il sismologo non era come fare l’astrofisico o il paleontologo; il rapporto con la società era molto importante. Più avanti, dopo numerosi terremoti disastrosi come quello in Umbria-Marche nel 1997, poi in Molise nel 2002, e ancora di più dopo i fatti dell’Aquila nel 2009, questo rapporto si è complicato e spesso inasprito. Dietro questo inasprimento c’è, a mio avviso, un’incomprensione di fondo sul significato delle conoscenze e sui loro limiti, sul metodo scientifico, sui linguaggi, sul valore dell’incertezza e sui concetti di probabilità e prevedibilità. Il dialogo con l’Atroce, però, ci fa ben sperare: un dialogo tra ricercatori e cittadini non solo è possibile, ma molto proficuo e istruttivo per entrambi.
Dopo ogni calamità naturale, non abbiamo l’abitudine di assumerci la responsabilità delle nostre scelte, che contribuiscono in maniera determinante a causare danni e vittime, per esempio nel caso dei terremoti. Nel libro si racconta, però, la storia del sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, che ha elaborato un programma trentennale per la riduzione del rischio sismico, che prevede una progressiva demolizione dei vecchi edifici e la successiva ricostruzione di strutture più sicure. In Italia accadrà mai qualcosa del genere?
Che non sia la natura ma l’uomo a provocare i disastri era chiaro già dai tempi della diatriba tra Voltaire e Rousseau dopo il grande terremoto di Lisbona del 1755, di cui parlo nel libro. In risposta al primo, che aveva scritto il Poema sul disastro di Lisbona scagliandosi contro la filosofia ottimista dominante nella prima metà del Settecento, Rousseau argomenta in questo modo: «Converrete che, per esempio, la natura non aveva affatto riunito in quel luogo ventimila case di sei o sette piani, e che se gli abitanti di quella grande città fossero stati distribuiti più equamente sul territorio e alloggiati in edifici di minore imponenza, il disastro sarebbe stato meno violento o, forse, non ci sarebbe stato affatto». Una lezione di prevenzione sismica, datata 1756.
Tornando ai giorni nostri, non solo a Los Angeles, ma anche in altre città e in altri Paesi si sta intervenendo in maniera decisa sul problema della vulnerabilità degli edifici. Oltre alla California e al Giappone, che sono i riferimenti da decenni in questo campo, nel libro ho voluto ricordare alcuni esempi virtuosi di Paesi non tanto ricchi e tecnologicamente avanzati, come il Cile e la Turchia. Il caso di Istanbul è emblematico: quindici milioni di abitanti, edilizia fatiscente, ma una legge del 2012 ha imposto un sistema molto efficace di ricostruzione e adeguamenti sismici. Ci vorranno venti anni forse, ma quando il prossimo forte terremoto colpirà la capitale turca ci saranno migliaia di morti in meno e danni meno estesi. Solo allora si capirà il valore della prevenzione. E in Italia? Forse dovremo aspettare un’altra tragedia per smuovere le acque e attivarci. Quella dell’Aquila evidentemente non è bastata. Anche andare a cercare colpevoli tra i sismologi e gli esperti, lasciando da parte ogni valutazione sul (non) operato della politica nei decenni precedenti il sisma, non ha aiutato a mettere a fuoco il problema. Che in Italia accada in futuro qualcosa di simile ai programmi di prevenzione attuati in California o Turchia me lo auguro. Purtroppo al momento i segnali positivi scarseggiano.
È un caso che in stati colpiti da terremoti di magnitudo potenzialmente distruttiva – come il Giappone – i danni a cose o persone sono spesso trascurabili, mentre in altri, come l’Italia, spesso bastano scosse di minima intensità per causare gravi catastrofi?
No, non è un caso. È il frutto di politiche di riduzione del rischio, maturate nel corso di molti anni in Paesi più attenti e più lungimiranti del nostro, nei quali i terremoti colpiscono più spesso e con impatto ancora maggiore che nel nostro Paese. Il problema principale è che, come disse anni fa Kofi Annan, i costi della prevenzione devono essere pagati nel presente, mentre i suoi benefici risiedono in un futuro lontano e non sono tangibili: sono i disastri che non sono avvenuti. Un concetto chiaro e importante, che però si scontra con gli orizzonti spesso limitati della politica attuale. Difficile che qualcuno pensi più in là di un paio di mandati elettorali.
Un elemento che condiziona il nostro atteggiamento nei confronti del problema del rischio sismico è quello della frequenza del terremoto, che tende a essere rimosso a livello individuale, collettivo e politico, tanto più laddove gli eventi sismici sono rari. Storicamente anche in Italia, subito dopo i grandi terremoti, sono state messe in campo delle valide politiche di riduzione del rischio. I terremoti di Messina e Reggio nel 1908 e quello della Marsica del 1915 determinarono l’emanazione di importanti decreti per la ricostruzione, che imponevano norme severe per i nuovi edifici: case basse, strade larghe e altro ancora. E, in effetti, se si va a vedere l’edilizia di quegli anni, si trovano interi quartieri progettati e realizzati con quei criteri. In seguito, tuttavia, ci si è “dimenticati” rapidamente del terremoto e si è ricominciato a costruire in maniera pericolosa. Basti pensare al boom edilizio degli anni ’60 e ’70 del Novecento, che ha portato alla costruzione di decine di migliaia di edifici, in molti casi progettati e realizzati prima del varo delle norme sismiche. Per questo motivo esiste oggi un enorme deficit di sicurezza in quasi tutte le regioni italiane.
In un suo romanzo, “Il martello dell’Eden”, Ken Follett racconta la storia di una comunità hippie che, per impedire la costruzione di una centrale elettrica, minaccia il governatore della California di provocare dei terremoti nei pressi della faglia di Sant’Andrea tramite un cosiddetto “vibratore sismico”. È davvero possibile che l’uomo possa causare artificialmente delle scosse telluriche o ciò rappresenta solo una fantasia da romanzi?
La storia del “vibratore sismico” appartiene alle fantasie del cinema, ma è vero che l’uomo è in grado di provocare dei terremoti. È dimostrata in molte aree del mondo una correlazione causale tra un certo tipo di terremoti e la creazione di dighe e di grandi invasi d’acqua, o con l’estrazione di petrolio e gas dal sottosuolo. Quest’ultimo caso, che è legato non tanto all’estrazione quanto alla reiniezione di acque reflue nel sottosuolo, è esploso negli USA centrali, dove i terremoti sono aumentati in maniera esponenziale negli ultimi anni. È un problema nuovo per i ricercatori, che stanno lavorando molto per capire il fenomeno ed effettuare delle previsioni probabilistiche a medio termine. Proprio all’inizio del 2016 l’U.S. Geological Survey ha pubblicato una mappa di hazard sismico del territorio nazionale su base annuale, da cui emerge che le aree più pericolose in quella finestra temporale sono proprio l’Oklahoma e gli stati limitrofi, ancor più della California (dove comunque la probabilità di un grande terremoto nei prossimi 30 o 50 anni resta superiore). Bisogna però anche fare attenzione a non pensare che ci sia sempre l’uomo all’origine dei terremoti. Una volta c’erano i pesci-gatto e le comete, oggi qualcuno li ha sostituiti con le antenne HAARP e le scie chimiche.
Una parte del libro è dedicata al terremoto che ha colpito L’Aquila nel 2009 e al successivo processo agli esperti e membri della Commissione Grandi Rischi. Tralasciando il piano prettamente giuridico (dei sette processati, dopo una condanna in primo grado, sei sono stati definitivamente assolti), ritiene che sia possibile muovere comunque qualche rimprovero agli esperti chiamati a L’Aquila qualche giorno prima del terremoto del 6 aprile 2009? È corretto dire che quello che si è celebrato è stato, come titolato da molti giornali, “un processo alla scienza”?
Non è chiaro chi usò per primo l’infelice espressione “processo alla scienza” dopo il verdetto di condanna in primo grado. Viene attribuita (credo impropriamente) all’allora ministro Clini, e fu poi ripresa da molti giornali. Credo che Clini volesse dire qualcosa di diverso da come fu inteso. Chi mai si sognerebbe di dire “la scienza va processata?”. Qui, si disse, si processano scienziati e responsabili di protezione civile, i quali hanno commesso errori che hanno portato alla morte di alcune persone quel 6 aprile 2009. Il fatto è che nessuno degli scienziati fece veramente quegli errori, come appurato dalla corte di Appello e confermato dalla Cassazione. Tuttavia, per dimostrare la colpevolezza dei sette imputati nel primo processo, si era effettivamente ignorato e bistrattato il metodo scientifico, quindi la scienza. E la scienza, soprattutto una non esatta come quella sismica, naviga in un oceano di forte incertezza e non può fornire le risposte che si vorrebbero. Numerose argomentazioni, perizie e testimonianze sono state trattate in modo molto poco scientifico, come ha stabilito chiaramente la Corte d’Appello riformando in modo sostanziale la sentenza di primo grado. Oltre ai sei imputati prosciolti (“perché il fatto non sussiste”), è rimasto, secondo la Corte di Cassazione, un unico colpevole, il vice capo del Dipartimento di Protezione Civile, il quale aveva rilasciato dichiarazioni scorrette e fuorvianti. Certo, dopo la vicenda processuale oggi siamo tutti portati a prestare molta più attenzione alla comunicazione, a distinguere i ruoli, a vigilare su quanto riporta la stampa. Sarebbe un errore, però, ricorrere a dei comportamenti “difensivi”, pensando a salvaguardare gli operatori del rischio più che i cittadini.
Sappiamo che, con le attuali conoscenze scientifiche, non è in alcun modo possibile prevedere con precisione data, ora e luogo di un terremoto. È plausibile immaginare che, in un futuro non troppo remoto, si possa giungere a previsioni con una buona dose di affidabilità, in modo da consentire evacuazioni sicure prima dell’arrivo delle scosse?
I sismologi fanno delle previsioni sismiche compatibili con il grado delle conoscenze attuali, considerata la scarsa regolarità con cui avvengono i terremoti nelle varie zone del mondo. Sono le carte di pericolosità, delle valutazioni probabilistiche a lungo termine (tipicamente 50 anni) utili per la pianificazione del territorio e per le norme di costruzione.
Per quanto riguarda la previsione a breve termine, forse prima o poi ci si arriverà. Ma nel frattempo è necessario mettere in sicurezza il territorio. Sarebbe assurdo, infatti, evacuare città che dopo ogni terremoto dovremmo ricostruire. Una volta raggiunto l’obiettivo della sicurezza edilizia, la previsione a breve termine tornerebbe a essere un interessante problema scientifico e non una questione dalla quale dipende la vita o la morte delle persone.
Personalmente, non credo che ci si arriverà tanto presto. Forse non ci si arriverà mai. Contrariamente ai meteorologi, le cui capacità previsionali sono aumentate enormemente da quando esistono i satelliti e le misure dei parametri dell’atmosfera, i sismologi non hanno la possibilità di osservare da vicino i processi sismici e difficilmente potranno averla nei prossimi decenni. Ma non possiamo sapere cosa verrà scoperto in futuro e quindi non possiamo fare previsioni neanche sul futuro della previsione. La ricerca sta proseguendo anche in questo campo, puntando innanzitutto alla comprensione del processo fisico del terremoto. Senza questa comprensione e senza un modello concettuale in grado di spiegare tutti i fenomeni che avvengono prima, durante e dopo un evento sismico, i tanti “precursori” raccontati nel libro, veri o immaginari, non serviranno mai a farci prevedere il prossimo terremoto.
Il mistero di Homo naledi
Damiano Marchi
Mondadori, 2016
pp. 176, € 19,00
Recensione di Elisa Frei
Questo breve e avvincente saggio racconta la storia della scoperta di Homo naledi (“uomo stella”), una nuova specie di ominine (gruppo che comprende «l’uomo moderno e tutti i suoi antenati caratterizzati da postura eretta e locomozione su due gambe», p. 8).
L’autore del libro ha potuto realizzare il sogno di ogni scienziato quando la sua candidatura per il workshop di studio dei fossili di Homo naledi è stata accettata.
Tutto aveva avuto inizio in Sudafrica, non lontano da Johannesburg, nel 2013, quando due speleologi si imbatterono per caso in una camera sconosciuta nel complesso di caverne Rising Star, dove erano adagiate centinaia di ossa, apparentemente umane.
Lee Berger, una sorta di Indiana Jones della paleoantropologia con uno spiccato senso del marketing (e infatti, in un primo momento, fu oggetto di molte critiche), subito intuì che poteva trattarsi di un’importante scoperta per lo studio dell’evoluzione umana e riuscì a trovare a tempo di record i finanziamenti per la campagna di recupero. Alle selezioni parteciparono circa 60 specialisti da tutto il mondo, individuati in base a criteri che in un primo momento potrebbero stupirci. Il bando, pubblicizzato tramite media innovativi quali Facebook e il passaparola digitale, richiedeva infatti, per questa specifica fase, oltre alle ottime competenze scientifiche, caratteristiche quali il buon allenamento, un fisico esile e nessun disturbo di claustrofobia. Tali requisiti vennero perfettamente incarnati dalle sei scienziate (“underground astronauts”) che si occuparono della prima fase, ossia il concreto e certosino recupero delle ossa, durato tre settimane.
Marchi è, per sua stessa ammissione, uno dei maggiori studiosi al mondo degli arti inferiori e soprattutto della fibula, osso lungamente ritenuto dalla scienza «la Cenerentola dello scheletro» (p. 89). La sua specializzazione gli consentì di dare un importante contributo alla fase successiva, ovvero allo studio delle numerosissime ossa fossili recuperate e trasportate nell’Evolutionary Studies Institute di Johannesburg, attrezzato per l’evento con le migliori tecnologie.
Durante i mesi del workshop, la giornata tipo di Marchi era caratterizzata da ritmi serrati: sveglia alle 6, colazione alle 7, trasferimento dall’hotel al campus, intenso lavoro dalle 8 alle 17,30 (intervallato da una rapida pausa pranzo). La sera in hotel, poi, davanti al computer continuava a dedicarsi ai dati raccolti oppure si confrontava con i colleghi, sfruttando al massimo ogni minuto di questa eccezionale opportunità.
Oggi di Homo naledi sappiamo che era bipede, camminava su lunghe distanze ma conservava l’abitudine di arrampicarsi sugli alberi; era alto circa 150 cm, pesava 45 kg e aveva un cervello di piccole dimensioni. In lui convivevano caratteristiche antiche e moderne; la sua datazione è ancora incerta e le varie ipotesi aprono interessanti scenari. Il mistero più affascinante di tutto il libro è tuttavia stabilire chi abbia portato quelle ossa nelle grotte, tramite un percorso talmente tortuoso (e che tale era sempre stato nel corso della storia) e, soprattutto, per quale motivo. Il fatto che non vi siano segni di aggressione o uccisione (da parte di animali o altri ominini) né di cedimenti del terreno potrebbe far pensare a una sepoltura... ma Homo naledi era abbastanza “intelligente” per avere un culto dei morti? Era in grado di pianificare, intenzionalmente, una simile operazione di spostamento dei defunti? In realtà, gli studi più recenti mostrano che anche le grandi scimmie antropomorfe soffrono per la perdita di membri del gruppo, e non è escluso che se fossero stanziali inizierebbero a praticare anche l’“accumulo funerario” (per evitare malattie dovute alla decomposizione e per tenere lontani i predatori). Questa potrebbe quindi essere la più importante lezione dataci da Homo naledi: il fatto che non dobbiamo considerarci separati dalle altre specie, perché tutti siamo parte del medesimo processo evolutivo.
L’emozione e l’entusiasmo di Marchi per questa scoperta eccezionale («eravamo stati chiamati a ricomporre il più grande puzzle in 3D del mondo: oltre 1550 "pezzi", conservati da un numero ancora imprecisato di anni nelle viscere della terra», p. 83) traspaiono da ogni riga della sua opera. È interessante, oltre all’aspetto scientifico, la descrizione della sua carriera accademica, di respiro internazionale, anche perché in Italia spesso mancano le condizioni che caratterizzano altri atenei nel mondo, ad esempio quelli statunitensi ben noti all’autore. Dopo gli anni trascorsi alla Duke University, concluso il sesto e non rinnovabile contratto, Marchi tornò in Italia e, affranto da una disoccupazione lunga quasi un anno, pensò di dover accantonare tutti i suoi progetti di studio, sui quali aveva tanto investito negli anni precedenti. Fortunatamente così non fece e la sua storia ci insegna che (almeno a volte) credere nei propri sogni di gioventù può davvero fare la differenza.
L’ineffabile colore del tempo
di Adalberto Piazzoli e Domenico Scannicchio
Edizioni ETS, 2013
pp. 196, € 19
Recensione di Silvano Fuso
«“Tutto quello che avreste voluto sapere sul tempo e non avete mai osato chiedere” potrebbe essere il sottotitolo di questo libro. Dalla psicoanalisi al principio di Fermat, dai calendari Maya all’entropia, dalle clessidre alla relatività. Viene anche insinuato il dubbio che il tempo esista, che trascorra ammesso che esista, che due secondi siano il doppio di un secondo, perché la scala potrebbe essere logaritmica invece che lineare».
Così si legge sulla quarta di copertina di L’ineffabile colore del tempo. Il libro, che si avvale della prestigiosa prefazione della compianta Margherita Hack, è stato scritto a quattro mani da Adalberto Piazzoli e Domenico Scannicchio. Il primo è un fisico “particellaro” (come lui stesso ama definirsi), professore emerito all’Università di Pavia, nonché eroico vicepresidente del CICAP per tanti lunghi anni. Il secondo è anch’egli fisico, ordinario di fisica medica all’Università di Pavia, ed è stato allievo del primo.
Non è certo la prima volta che dei fisici si occupano del concetto di tempo. Oltre ai fisici se ne sono occupati da tempo (è il caso di dirlo) anche schiere di filosofi e pensatori di ogni genere. Quella del tempo è insomma una vexata quaestio alla quale nessuno è mai stato in grado di fornire una risposta non solo esauriente, ma nemmeno appena appena soddisfacente. A scanso di equivoci, per evitare illusorie aspettative nei propri lettori, i due autori fin dall’introduzione dichiarano: «... non abbiamo alcuna ambizione didattica, cioè non ci proponiamo di spiegare a nessuno che cosa è il tempo e per almeno due buoni motivi: perché non l’abbiamo capito nemmeno noi e anche perché abbiamo forti sospetti che non l’abbia ancora capito nessuno».
Ciò nonostante L’ineffabile colore del tempo è un libro che vale la pena leggere. È infatti un testo piuttosto curioso e originale, e lo si capisce fin dalle prime pagine. Quale altro libro, infatti, farebbe immediatamente seguire all’introduzione la bibliografia e, soprattutto, una “Conclusione anticipata”? Piazzoli e Scannicchio lo fanno. A pag. 19 infatti si legge: «A beneficio di coloro che avessero avuto questo libro in regalo e non avessero ...TEMPO per leggerlo, oppure fossero stati scoraggiati dall’introduzione, vogliamo fornire una conclusione anticipata che, insieme con l’introduzione, può dare loro un’idea di ciò che si sono persi». E al termine della mezza paginetta di “Conclusione anticipata” scrivono: «Ma allora, cos’è il TEMPO? Boh! Che colore ha? Boh! A chi non riesce a vivere senza certezze potremmo suggerire questa definizione. “Il TEMPO è quella cosa misurata dagli orologi” e il suo colore è ... verde pisello. Ma non ne siamo tanto sicuri».
Amanti delle certezze, siete soddisfatti? Non credo. Scommetto quindi che ben pochi saranno i lettori che si accontenteranno di leggere l’introduzione e la conclusione anticipata. Fin dalle prime pagine, infatti, lo stile ironico e accattivante degli autori stimola la curiosità e induce anche il lettore più pigro a proseguire la lettura. E la curiosità non viene certo delusa.
I due autori, attraverso le pagine del libro, ci accompagnano attraverso un affascinante viaggio che sviscera in profondità ogni aspetto legato al tempo, e non solo dal punto di vista scientifico. Continue sono infatti le incursioni che gli autori fanno in ambito letterario, artistico, storico, filosofico, psicologico e, in generale, in ogni ambito del pensiero umano che abbia, in un modo o nell’altro, avuto a che fare con l’oscuro concetto di tempo.
Naturalmente, essendo entrambi scienziati, i due autori hanno un occhio di riguardo per la scienza e per la fisica in particolare. La relatività, la termodinamica, la meccanica quantistica e la cosmologia hanno infatti fornito fondamentali contributi per cercare di gettare luce sul concetto di tempo. Anche se, come commentano con tono dissacrante gli autori, esse non «hanno migliorato la situazione, anzi, dopo lo studio di queste severe discipline, abbiamo ancora le idee confuse, ma... a livello più alto».
Tema dominante delle infinite discussioni sul tempo, e quindi inevitabilmente anche del libro, è la contrapposizione tra tempo psicologico e tempo fisico. Tempi che ci appaiono maledettamente diversi. Terribilmente reale e dipendente dalle condizioni in cui ci troviamo il primo, semplice coordinata, indipendente dal nostro stato d’animo, il secondo. A tale proposito però, gli autori sembrano avere le idee abbastanza chiare. Tanto che affermano: «A nostro avviso non c’è contrasto con chi sostiene che esiste solo il tempo percepito e nient’altro: a percepirlo, e quindi a crearlo, sarebbe ancora il cervello, ma non in completa autonomia, bensì mediante l’elaborazione di stimoli provenienti dall’esterno. Per mal che vada, anche se il tempo è un’invenzione del cervello, è un’invenzione in qualche modo dipendente dalla realtà».
La recensione termina qui: è infatti difficile aggiungere altro poiché sarebbe impossibile sintetizzare in poche righe i numerosissimi argomenti affrontati nel libro. Ci limitiamo solo a esortare chiunque sia animato da curiosità intellettuale a leggerlo. Sarà sicuramente... tempo ben speso!
Supernatural Entertainments.
Victorian Spiritualism and the Rise of Modern Media Culture
Simone Natale
Penn State University Press, 2016
pp. 248, $ 79,95
Recensione di Anna Rita Longo
Da Ghostbusters a Paranormal Activity, dal divertente scetticismo in salsa mystery di Scooby-Doo a Mistero e Voyager… la cultura contemporanea è letteralmente disseminata di riferimenti al mondo dell’occulto e del soprannaturale. Fantasmi, vampiri, ectoplasmi, entità misteriose della più varia natura permeano quelli che dovrebbero essere gli anni in cui il progresso scientifico e tecnologico ha reso più stridente il richiamo all’intangibile. Eppure non c’è scienza che tenga: gli spiriti continuano a essere tra noi. O, almeno, a popolare il cinema, la letteratura e la televisione d’intrattenimento. La fascinazione per il soprannaturale è un ingrediente fondamentale dell’universo mediatico contemporaneo e si accompagna a un ritorno d’interesse nei riguardi della cultura vittoriana, almeno per quanto riguarda il suo lato “pop”. Perché è proprio nel XIX secolo che questo legame tra soprannaturale e media si consolida, in un rapporto destinato a durare nel tempo, che è giunto quasi inalterato fino ai nostri giorni.
L’originalità del lavoro di Simone Natale – docente di Communication and Media Studies presso l’università britannica di Loughborough – consiste nell’aver colto il debito che la moderna cultura mediatica ha nei riguardi dello spiritismo dell’età vittoriana. L’associazione tra due fenomeni che sembrano non aver nulla in comune sulle prime lascia piuttosto perplessi. Ma la ricca argomentazione dell’autore, che non trascura nessuno degli aspetti della questione, risulta nel complesso convincente. Attraverso un ricco corredo di esempi frutto della propria ricerca e degli studi precedenti, Natale dimostra come le sedute spiritiche, pratica assai comune nel XIX secolo, adoperassero strategie e modalità espressive per nulla dissimili da quelle dei media d’intrattenimento in contemporanea ascesa. Ciò avveniva sia in contesti pubblici sia nel corso delle frequenti sedute private, che assumevano comunque un carattere di intrattenimento e spettacolarizzazione. Per non trascurare nessun aspetto, dopo una ricca introduzione che riassume la tesi centrale del saggio, l’autore divide il discorso in tre parti. Nella prima si prendono in esame le sedute pubbliche e private e le loro caratteristiche. La seconda parte mette in evidenza l’uso di una serie di tecniche e mezzi che ricalcano i dettami del marketing e dello show business. La terza, infine, si sofferma su tutti quegli strumenti che contribuivano a rendere concreto il rapporto del pubblico con gli spiriti, tra cui spiccano le fotografie di fantasmi, antiche quanto la fotografia stessa.
Tra i vari aspetti illustrati da Natale vi è anche un’interessante nota sull’elemento della controversia circa l’autenticità del fenomeno, incoraggiata e spesso introdotta a bella posta dai medium vittoriani, consapevoli del fatto che il dubbio avrebbe alimentato un dibattito che si sarebbe tradotto in pubblicità. È un aspetto che induce a porsi delle domande sui limiti e l’ambivalenza del debunking, anche sulla scorta dei recenti studi scientifici sul tema.
La conclusione, che riporta il discorso all’età contemporanea, tira le somme su un presente che appare in stretta continuità con l’Ottocento in cui gli spiriti divennero intrattenimento di massa.
Ti si legge in faccia
Massimo Polidoro
ebook gratuito, 2016
Recensione di Anna Rita Longo
DI CHE COSA SI PARLA: L’ebook, disponibile gratuitamente per chi si iscrive alla newsletter dell’autore, riassume le conclusioni degli studi psicologici sul linguaggio del corpo, fornendo un’utile sintesi delle conoscenze scientifiche al riguardo e qualche rapido trucco per tentare di smascherare i bugiardi.
PERCHÉ LEGGERLO: Film e serie televisive hanno reso familiari personaggi in grado di leggere nella mente altrui, decifrando i significati nascosti di gesti ed espressioni del viso. Si tratta di un argomento affascinante: chi non sarebbe felice di capire a colpo d’occhio se il proprio interlocutore sta mentendo o dice la verità? Massimo Polidoro spiega al suo lettore realtà, mitologia e limiti della “lettura del pensiero”.