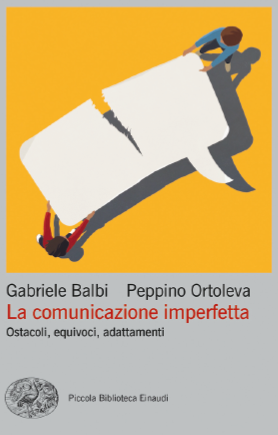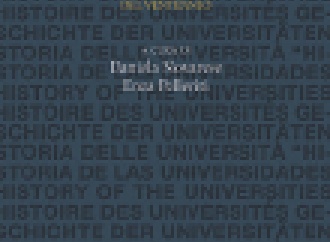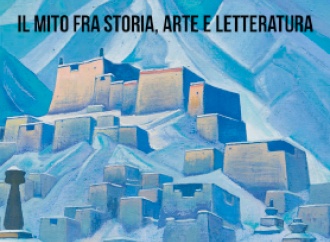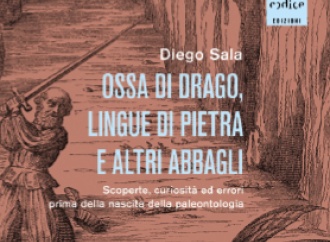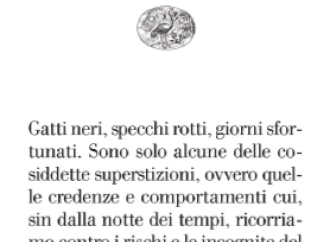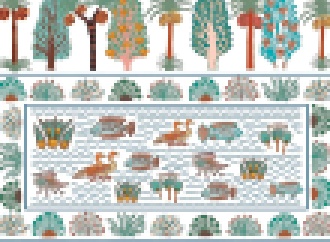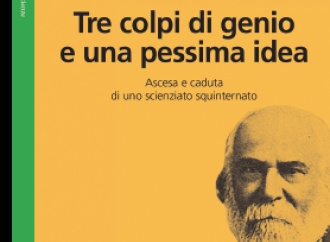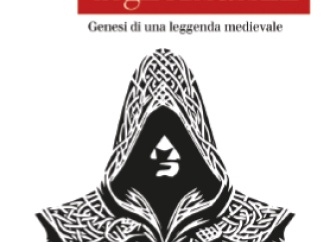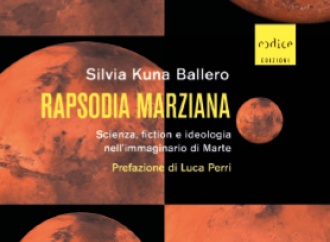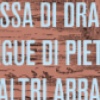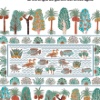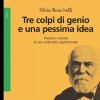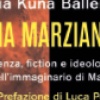La comunicazione imperfetta
di Gabriele Balbi e Peppino Ortoleva
Einaudi, Torino, 2023
pp. 223, euro 22,00
Il titolo del volume riassume in maniera inequivoca la tesi degli autori: la comunicazione è un’attività strutturalmente caratterizzata da imperfezioni e ostacoli che compromettono la possibilità di una piena comprensione e accettazione degli intendimenti e dei contenuti che qualcuno cerca di condividere. Questa visione viene contrapposta alle teorie classiche della comunicazione sviluppate nella seconda metà del '900, che descrivono la comunicazione come un processo lineare, un passaggio di informazioni guidato da un obiettivo razionalmente definito da parte di un emittente nei confronti di un ricevente, che avviene attraverso un canale e che può andare incontro a dei disturbi.
In molti corsi di formazione queste teorie sono ancora presentate come valide, mentre il testo giustamente le qualifica come archeologia della comunicazione: elaborate nello sforzo di sistematizzare un sapere nascente, ragionavano su singoli strumenti di comunicazione (il telefono, la televisione), i cui messaggi erano predisposti da attori identificabili (per esempio le redazioni di un giornale) e non potevano tenere conto della plurimedialità odierna, caratterizzata da disintermediazione e interazione costante. Teorie interessanti al tempo, superate oggi.
I primi quattro capitoli propongono una mappa «temporanea e parziale» delle forme di comunicazione imperfette e cioè un’analisi di «fenomeni che – per l’azione volontaria di qualche attore, per incidenti imprevisti, per caratteristiche intrinseche alla comunicazione stessa – possono interrompere o ostacolare il processo comunicativo, o deviarlo dagli intenti originari di uno o di tutti i partecipanti». Il primo capitolo mostra come il malinteso si possa produrre per una varietà di cause, tra cui quelle materiali legate ai possibili errori di comprensione di una parola o alla difficoltà di interpretare in modo univoco il non verbale. Il secondo capitolo analizza i malfunzionamenti della comunicazione legati al venir meno temporaneo di una tecnologia usata per comunicare, come accade quando la rete Internet rallenta. Qui si rende evidente la fragilità delle infrastrutture attraverso cui passa la comunicazione, ma anche il fatto che la riparazione del malfunzionamento può generare la scoperta di nuove modalità e tecnologie di comunicazione. Nel terzo capitolo si tratta la questione della scarsità e della sovrabbondanza della comunicazione. La sovrabbondanza genera incertezza e disorientamento, la scarsità si lega alla percezione che si è privati di qualcosa e che il proprio diritto alla conoscenza venga limitato. Il quarto capitolo si occupa del potere comunicativo dei silenzi come caso estremo di comunicazione imperfetta: «sono costitutivi, integrati, e di fatto normali in quasi tutti gli scambi comunicativi (ma) al tempo stesso polisemici, difficilmente interpretabili».
Nella seconda parte del volume si tracciano alcuni elementi di una teoria della comunicazione imperfetta. Tali elementi fanno riferimento al fatto che «il comunicare segue, spesso se non prevalentemente, andamenti tutt’altro che lineari, il che comporta e richiede continue attività di adattamento ai tanti imprevisti», o che la dinamica dei diversi media «pur nelle inevitabili differenze, presenta comunque aspetti comuni tra strumenti e forme di comunicazione che tendiamo a mantenere nettamente separati come la scrittura e l’oralità, la comunicazione interpersonale e quella detta “di massa”». Tali limiti possono costituire una forza del processo comunicativo; per esempio, per identificare e capire le specificità di una tecnologia di comunicazione. In questo quadro, «l’ambiguità è una ricchezza del comunicare umano» e la comunicazione «è sempre uno sforzo verso quel risultato così delicato, sfuggente e così essenziale insieme che si chiama capire, e farsi capire». Proponendo la loro visione gli autori ne sottolineano il realismo: «è in grado di restituire i fastidi, i problemi, le opportunità e i limiti della comunicazione», in quanto parte «dalla concreta esperienza del comunicare nel suo farsi, disfarsi, perfino arrangiarsi».
Nel finale c’è un’analisi delle azioni volte a correggere o a rimediare alla comunicazione imperfetta, dallo scusarsi alla smentita al fact-checking, un po’ sbrigativamente bollato come inutile perché finirebbe col «confermare ulteriormente la sfiducia reciproca tra i diversi schieramenti». Qualche perplessità me l’ha suscitata anche il fatto che gli autori si riferiscono alla programmazione neurolinguistica come una «tecnica utile», accreditando una teoria la cui validità è ancora di là da essere dimostrata.
Un testo nel complesso interessante, in alcuni punti un po’ prolisso nelle esemplificazioni e nelle spiegazioni di fenomeni e situazioni che si possono dare per note e condivise, il cui merito principale è quello di proporre una lettura articolata e stratificata dei processi comunicativi che rifugge da semplificazioni e banalizzazioni.