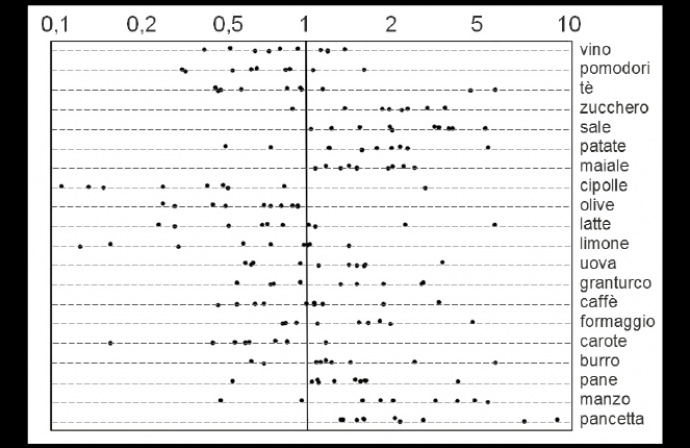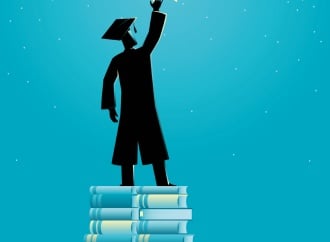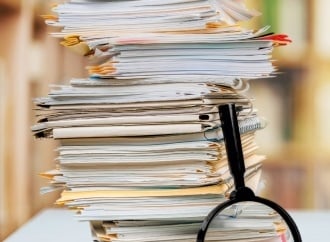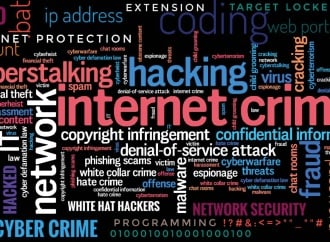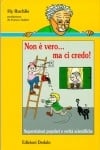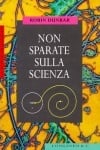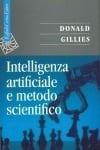Il risultato è sconcertante, ma prima di analizzarne le ragioni vediamo un altro esempio, relativo questa volta alla medicina[3]. Nel 2003 l’American Journal of Medicine si chiese quante delle scoperte biomediche che si presentano come rivoluzionarie nella ricerca di base si affermino davvero nel tempo e a questo scopo analizzò che cos’era accaduto nei vent’anni precedenti. La rivista esaminò 101 nuove tecnologie mediche che erano state annunciate come molto promettenti per la futura applicazione clinica in studi pubblicati sulle migliori riviste scientifiche tra il 1979 e il 1983. Vent’anni dopo, nel 2003, 27 di queste 101 tecnologie erano state sottoposte a studi clinici randomizzati pubblicati su riviste scientifiche, ma soltanto cinque erano arrivate sul mercato. Di questi cinque prodotti, soltanto uno - gli ACE inibitori, un insieme di farmaci per il trattamento dell’ipertensione arteriosa e di altre malattie cardiovascolari - era ancora molto diffuso nel 2003 (e lo è ancora oggi). Degli altri 100 non era rimasta traccia[4].
Come è possibile che le scoperte scientifiche si contraddicano tra loro e che i risultati annunciati negli studi più innovativi vengano poi smentiti o ridimensionati in modo così plateale?[5] Queste contraddizioni sono casi eccezionali oppure sono la norma?
Si tratta di un fenomeno piuttosto comune: ne abbiamo parlato altre volte in questa rubrica[6]. Addirittura, secondo alcune ricerche[7], più della metà dei risultati pubblicati nella ricerca scientifica è errata e solo una minoranza viene successivamente confermata come una scoperta autentica. Questo non vuol dire che la maggior parte degli studi sia fraudolenta o che non si facciano progressi, ma che all’inizio è normale seguire false piste e che i progressi avvengono lentamente, attraverso la laboriosa selezione delle poche scoperte davvero valide e importanti tra le molte che vengono evidenziate nella ricerca di base (e talvolta annunciate con enfasi sui media generalisti).
Le cause che rendono il progresso faticoso e contradditorio sono numerose e di tipo diverso.

La confusione è alimentata dal bias degli editori, sia quelli specialistici sia quelli generalisti: gli editori scientifici sono poco incentivati a pubblicare risultati negativi, che non faranno notizia e difficilmente saranno citati dai lavori successivi, mentre i mezzi di comunicazione privilegiano di gran lunga le novità, soprattutto se clamorose e sorprendenti. Lo spiega proprio Naomi Oreskes in un’intervista a Vox[8]: «C’è un’enorme differenza tra come i media considerano le novità scientifiche e come le considerano gli scienziati. Per voi media, N.d.T. ciò che le rende importanti è il fatto che sono novità – e questo spinge i media a cercare sempre risultati nuovi. Per me i risultati nuovi sono quelli che hanno più probabilità di essere sbagliati». Nell’intervista, Oreskes sottolinea che gran parte della ricerca scientifica consiste nell’affinare e consolidare conoscenze già note, come quelle sul riscaldamento globale; ma questi risultati sono “vecchi” e quindi interessano poco ai media, che invece danno un risalto sproporzionato alle novità, anche quando sono ancora incerte e richiederebbero verifiche: il pubblico viene investito da una raffica di notizie in contrasto fra loro ed è normale che sia confuso.
Dal nostro punto di vista è importante mettere in risalto che non è mai un unico studio a determinare lo stato delle conoscenze su un dato argomento, ma soltanto l’insieme della letteratura scientifica in merito, che impiega diversi anni per accumulare un numero sufficiente di dati e che richiede competenze specialistiche per essere valutata.
Per quanto riguarda invece le contraddizioni e le difficoltà della letteratura scientifica, molti scienziati ne sono al corrente e sono al lavoro per sviluppare processi più efficienti: è impossibile riassumere adeguatamente le loro proposte in poche righe, preferisco rimandare alla rubrica “Toolbox” di Stefano Bagnasco, che negli ultimi numeri di Query ha descritto approfonditamente la questione.
In questa sede vorrei invece sottolineare altri aspetti che mi sembrano interessanti per chi come il CICAP cerca di difendere la scienza e la mentalità scientifica.
La diffidenza del pubblico verso la scienza non è dovuta soltanto all’ignoranza in materia, ma è anche in misura rilevante una reazione del tutto comprensibile di fronte al bombardamento di notizie incompatibili tra loro, alla spinta sempre maggiore verso la spettacolarizzazione delle scoperte scientifiche e alla costante presenza di interessi economici e ideologici che da più parti tentano di influenzare la ricerca scientifica. Questo tipo di diffidenza non si elimina trattando con superiorità il “pubblico ignorante”, ma solo prendendo sul serio i problemi della ricerca e cercando gli strumenti per risolverli insieme alla società.

È indispensabile non perdere la prospettiva storica e ricordare quante scoperte apparentemente clamorose sono state ridimensionate in passato, in modo da trattare con una sana dose di scetticismo gli annunci più recenti. Non siamo entrati improvvisamente in un’età dell’oro in cui gli scienziati non sbagliano più: migliorare le nostre conoscenze sfuggendo agli infiniti bias della mente umana e agli interessi di parte continua a essere una sfida difficile come è sempre stato. Guardando alle conoscenze scientifiche di oggi, con ogni probabilità i posteri sorrideranno della nostra ingenuità proprio come noi facciamo con i nostri antenati. Ricordiamocelo e non abbassiamo mai la guardia dello spirito critico.