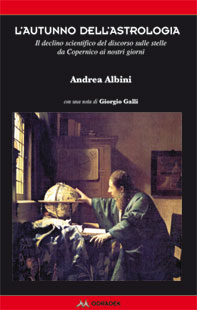L’autunno dell’astrologia.
Il declino scientifico del discorso sulle stelle da Copernico ai nostri giorni.
Andrea Albini
Roma: Odradek (2010)
219 pp., € 18,00
Recensione di Stefano Bagnasco
Dopo Oroscopi e cannocchiali (ne abbiamo parlato sul n. 82 di Scienza&Paranormale), Albini ritorna sul tema del difficile rapporto tra astrologia e pensiero scientifico, questa volta seguendone il cammino a cavallo della nascita della scienza moderna, attraverso l’illuminismo e fino ai nostri giorni. Come suggerisce il sottotitolo, questa non è una storia dell’astrologia ma un saggio su come questa si sia trasformata da un componente integrante della pratica medica e astronomica via via fino a qualcosa di sempre meno definibile, che al giorno d’oggi mescola pretese pseudoscientifiche a argomentazioni psicanalitiche e riflessioni filosofiche a volte un po’ più rispettabili.
Gli snodi fondamentali del percorso di Albini sono il punto di partenza e il punto di arrivo: la crisi dell’astrologia con l’avvento del pensiero scientifico e del metodo sperimentale e il progressivo affermarsi di un dualismo tra un’astrologia “popolare”, in fondo non molto diversa da quella degli almanacchi già ai tempi di Galileo, e un’astrologia “colta” che ruota intorno a interpretazioni simboliche e psicologiche e che, per lo meno quando è onesta, non ha più alcuna pretesa di scientificità e predittività.
Il discorso prende l’avvio da due padri fondatori dell’astronomia come Copernico e, in particolare, Keplero. La crisi era cominciata e, come scrive Albini, Keplero «fu l’ultimo grande astronomo e matematico a credere che l’astrologia potesse avere una base reale e potesse essere in qualche modo salvata, sia pure in una forma molto diversa e ridimensionata rispetto a quella tradizionale». È interessante notare come Keplero, nel tentativo di salvare le idee astrologiche che erano parte del suo modo di pensare, inaugurasse il dualismo che vediamo ancora oggi: le profezie popolari erano «orribili superstizioni» ma un’astrologia in qualche modo “riformata” era degna di attenzione e riflessione.
Dopo Galileo (del quale, essendo oggetto dell’altro suo libro, Albini parla solo di sfuggita) la crisi è completa. I tentativi di un’astrologia “sperimentale” ed empiricamente corroborata, da Francis Bacon in poi, fallirono scontrandosi con l’impossibilità di dimostrare qualunque influenza planetaria, e nei capitoli successivi Albini segue l’evoluzione di un’astrologia ormai completamente staccata dal pensiero scientifico attraverso l’enciclopedismo, le mode rosacrociane e gli strali dei polemisti come Jonathan Swift contro gli astrologi praticanti. In una delle appendici Albini riporta per esempio L’astrologia convinta di falso di Geminiano Montanari, un libello uscito nel 1685 e mai ripubblicato, in cui l’astronomo rivela la burla giocata compilando per anni il Frugnolo degl’Influssi del Gran Cacciatore di Lagoscuro, un autorevole almanacco zeppo di previsioni completamente inventate.
L’ultimo capitolo affronta il difficile problema dell’astrologia nel mondo contemporaneo, dalla nascita dell’astrologia “giornalistica” in Inghilterra tra XIX e XX secolo, le mode occultiste, poi il passaggio dall’occultismo allo “psicologismo” che dopo Jung pervade molta dell’astrologia più pretenziosa. A questo punto la scienza (e forse la cultura in senso più ampio) non ha più un discorso “di” astrologia ma un discorso “sull” astrologia, per discuterne la ricchezza simbolica o la funzione sociale. La conclusione di Albini è condivisibile:
La capacità di sopravvivenza [dell’astrologia] dipende molto dalla sua capacità di adattamento alle mode, ai “discorsi dominanti” e alla prassi del momento.
Chiude il volume una nota di Giorgio Galli, di cui sinceramente non si sarebbe sentita la mancanza. Il politologo ribadisce la sua nota posizione secondo la quale «l’approccio astrologico, visto come pura superstizione, [è] stato considerato con troppo disprezzo» dagli scienziati contemporanei e in particolare dal CICAP, tentando di argomentare senza troppo successo (forse a causa del limitato spazio a disposizione) come la scienza dovrebbe ancora in qualche modo riflettere sull’astrologia.
Insomma, un libro documentato e ricco di spunti, che mette anche a disposizione del lettore testi altrimenti poco accessibili (oltre al già citato testo di Geminiani, Albini traduce in appendice anche i libelli di Swift contro il celebre astrologo John Partridge). Infine, uno strumento utilissimo anche per evitare le eccessive schematizzazioni e semplificazioni con cui i critici dell’astrologia rischiano di trattare un percorso storico che è stato in realtà lungo e complesso.
L’incognita P.
Alla ricerca della psiche
Piero Paolicchi
Felici Editore, 2010, € 12,00
Recensione di Lorenzo Montali
Piero Paolicchi, si racconta così nella quarta di copertina di questo suo libro: «ha percorso tutte le tappe di una carriera come docente di psicologia sociale, anche se spesso da outsider se non da bastian contrario rispetto all’accademia e a chi conta in essa. Una volta libero dalle forche caudine di concorsi e finanziamenti di ricerca ha avviato una produzione di saggi non meno impegnativi», tra cui rientrano, oltre a questo, anche Il fattore I. Per una teoria generale dell’imbecillità e La variabile G. Perché ci vogliono tanti genitori per (non) fare un imbecille.
Appare quindi già chiaro che la cifra stilistica utilizzata nel testo è quella dell’ironia, una scelta che da un lato gli consente di avvicinare un pubblico più ampio e dall’altro è evidentemente affine allo spirito dell’autore. L’obiettivo del libro non è però quello di fare divulgazione su un tema, quello della psiche, a tal punto complesso che già nel titolo viene qualificato come “L’incognita P”. Piuttosto in esso si analizzano criticamente gli sviluppi della psicologia scientifica e di quella miriade di pseudo psicologie che offrono sul mercato le loro miracolose quanto banali ricette, capaci di rendere tutti leader di successo o di sviluppare con facilità qualsiasi capacità, dalla memoria al controllo delle emozioni. Questo non significa che l’autore metta una disciplina come la psicologia, che nella varietà dei suoi approcci è impegnata nello sforzo di produrre conoscenze empiricamente fondate, sullo stesso piano delle affermazioni non provate e non provabili di tanti autoproclamatisi guru; affermazioni che vengono divulgate senza preoccuparsi di mostrarne un qualche fondamento, ma solo in virtù del loro appeal commerciale. Come scrive Paolicchi, infatti, una delle differenze più immediate tra questi approcci e, per esempio, una terapia psicoanalitica, «sta nell’assenza di alcuni elementi, in primo luogo la consapevolezza di quanto sia difficile curare gli individui» che li caratterizza. Il libro è però interessante proprio come esercizio di spirito critico, applicato non solo alle pseudoscienze, ma alla scienza stessa.
Per quanto si tratti di argomenti anche complessi, il testo è di agevole lettura anche per chi non abbia competenze di tipo psicologico, ma sia interessato ai temi trattati. Questo perché il volume è costruito come una auto-riflessione che l’autore fa su se stesso e sul proprio sviluppo psicologico, in relazione alle concrete esperienze di vita e di socializzazione che ciascuno di noi ha avuto e in cui può facilmente riconoscersi. Ciò gli consente di confrontarsi, in relazione a problemi ed esempi concreti, con i modelli che la psicologia (e le pseudo psicologie) hanno prodotto per spiegare il funzionamento della psiche umana. Questo percorso viene delineato sin dalla nascita, “l’entrata in pista”, e passa attraverso la scoperta degli oggetti, la consapevolezza della centralità delle interazioni e delle relazioni sociali, la graduale costruzione di un mondo interno e di una rappresentazione stabile del mondo esterno, l’uso della parola “per fare” oltre che per dire qualcosa, l’esame di realtà e l’acquisizione di sufficienti competenze sociali. Nel tratteggiare ciascuno di questi passaggi Paolicchi prende le distanze da alcuni orientamenti della psicologia accademica - che sono stati o che sono tuttora spesso dominanti - e allo stesso tempo delinea le linee generali della sua proposta psicologica. In particolare emerge chiaro il rifiuto dell’equiparazione uomo-animale legata all’idea che l’articolazione e la complessità della psiche umana ne facciano un unicum, che non può essere concettualizzato secondo modelli lineari e di tipo semplice, per esempio quello stimolo-risposta. L’assunzione di questo punto di vista implica anche la critica verso una modellistica ipersemplificata, che pretende di definire pochi tratti di personalità sulla cui base spiegare il comportamento umano, o verso alcune metafore, come quella che equipara la mente a un elaboratore di informazioni, che vengono usate per concettualizzare i processi cognitivi.
Secondo questa stessa prospettiva, da un punto di vista metodologico viene criticato il fatto che la psicologia abbia mutuato dalle scienze della natura lo studio in laboratorio dei fenomeni psicologici, dal momento che le «condizioni di massima semplificazione e definizione di tutti gli elementi in gioco» che sarebbero necessarie «non sono mai raggiungibili per quanto riguarda i fatti umani». Si tratta di una presa di posizione rispetto alla quale esistono e sono legittime diverse valutazioni, come ben sa chi si è occupato di studiare le diatribe metodologiche in una disciplina multi paradigmatica come la psicologia. Il merito dell’autore è, credo, quello di aver collocato le sue critiche in una prospettiva coerente ed esplicita, quella della psicologia culturale, che valorizza le competenze del senso comune, la capacità della narrazione di costruire e comunicare senso agli eventi, la dimensione sociale e non solo individuale della psiche, l’apertura alla soggettività dell’altro quale chiave fondamentale di accesso e comprensione di quel mondo complesso che ciascuno di noi è.
Il fantasma di Canterville
Oscar Wilde
Mondadori, Oscar classici,
2001, pp. 224, € 8,50
Recensione di Anna Rita Longo
Dei fantasmi qualcuno potrà anche aver paura, ma forse conviene invece sorriderci su: questo il succo della lettura di un classico apprezzato dagli adulti come dai bambini, Il fantasma di Canterville. Nella letteratura inglese del Settecento e dell’Ottocento le ghost-stories sono un genere letterario fortemente in voga e le recenti tendenze del mercato editoriale segnalano ormai da qualche anno un ritorno di fiamma nei riguardi delle storie dalle tinte gotiche e venate di mistero.
Oggi come ieri nella letteratura di consumo non c’è avito maniero privo del corollario d’ordinanza delle presenze spettrali e non c’è notte che si rispetti che non sia rischiarata dal lume malfermo suscitato da una misteriosa apparizione. Il breve romanzo di Oscar Wilde è l’evidente parodia di questo fortunato filone letterario, nel quale al brivido e alla suspense si sostituisce il sorriso e il rivolgimento umoristico. Il meccanismo è semplice e geniale al tempo stesso: ad ogni stereotipo della classica ghost-story viene sostituito un equivalente parodico in un crescendo di surreale comicità.
Ogni storia di fantasmi non è tale senza un castello che sia la dimora di occulte e maligne presenze, incautamente abitato da inquilini che assistono terrorizzati a un’escalation di orrifiche manifestazioni. Anche qui c’è l’antico castello e l’incauto acquisto della proprietà infestata; peccato, però, che il signor Hiram B. Otis, viceambasciatore degli Stati Uniti, che ha deciso di comprarla per abitarvi con la propria famiglia, sia uno scettico convinto. Ben poca impressione gli fanno i racconti di Lord Canterville, primo proprietario dell’immobile, che parlano di scheletriche mani posatesi sulle spalle della vecchia prozia e amenità simili. Ovviamente non manca il terribile fantasma: ma qui il protagonista della storia ha ben poco in comune con gli orrendi spettri dalle cupe sembianze dei classici della letteratura gotica. Lo spettrale inquilino di Canterville Chase è una figura grottesca che comunica un senso di tenerezza nel lettore, attraverso i suoi patetici tentativi di far drizzare i capelli alla scettica famiglia, ben convinta assertrice del rasoio di Ockham, dal momento che «le leggi della Natura non verranno sospese per l’aristocrazia inglese». Che cosa è possibile opporre a chi, con serafico zelo, ripulisce senza batter ciglio il pavimento dove si è misteriosamente materializzata una sinistra macchia di sangue?
All’appello non manca neppure la gentile fanciulla che nel classico ghost novel è oggetto d’elezione delle attenzioni del fantasma. Ma la bella Virginia, figlia di Mr Otis, è ben lontana dalle eroine romantiche tutte palpiti e sospiri e, infatti, sarai lei a mettere definitivamente e impavidamente fine alle apparizioni del fantasma, ricevendo ricchi doni in cambio della propria intraprendenza.
Il mix, piacevolissimo e gustoso, farà scivolare via le pagine in modo che neppure il lettore più giovane e meno avvezzo alla prosa ottocentesca possa avvertirne il peso. L’ironia acutissima dell’autore gli strapperà più di un sorriso ed il finale, dalle sfumature patetiche, gli regalerà anche un pizzico di commozione. Il lettore adulto sarà, d’altra parte, attratto dalle molteplici interpretazioni possibili, che vanno dalla riflessione filosofica e sociale alle implicazioni critico-letterarie.
In generale, però, pochi fantasmi delle pagine di un libro hanno saputo essere così simpatici.