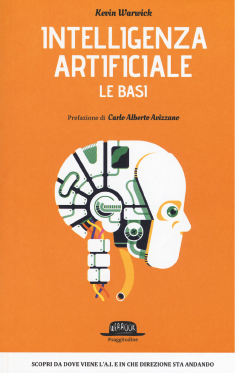Biologia dell’anima
Maurilio Orbecchi
Bollati Boringhieri, 2015
pp. 187, € 18,00
Recensione di Telmo Pievani
Perché tornare a riflettere sulle basi scientifiche della psicoterapia? Siamo nel secondo decennio del XXI secolo e molta acqua è passata sotto i ponti: il paesaggio culturale è cambiato e mutati sono i linguaggi. Oggi che le neuroscienze, la biologia evoluzionistica, l’etologia cognitiva e molte altre discipline comparative e integrate hanno riallacciato i ponti e permesso di comprendere in modo nuovo il sistema cervello-mente nel contesto della storia naturale, ha ancora senso dividersi in scuole analitiche fondate un secolo fa e spesso arroccate nelle loro settarie ortodossie? Da questo interrogativo radicale prende le mosse la coraggiosa “biologia dell’anima” dello psichiatra Maurilio Orbecchi, condensata in un testo liberatorio e necessario.
La prima mossa dell’autore è una disamina storica senza deferenze: che cosa avevano capito realmente Freud e Jung della rivoluzione darwiniana, cui apparentemente tributarono alti onori? Testi e citazioni alla mano, si scopre che Freud, più che darwiniano, era tecnicamente lamarckiano nella sua ricostruzione dell’evoluzione ancestrale umana. Non solo, in molti passaggi della sua opera egli confuse ontogenesi (lo sviluppo individuale) e filogenesi (la genealogia delle specie), prendendo alla lettera l’infondata teoria della ricapitolazione di Ernst Haeckel. Come già aveva notato l’evoluzionista Stephen J. Gould nella sua ultima raccolta di saggi del 2002, il racconto “preistorico” di Freud, tra ere glaciali e padri primordiali, è pura fantasia. Ne discende una mancanza di evidenze scientifiche anche per altri presupposti della psicoanalisi freudiana come la pulsione di morte, le fantasie sessuali infantili, la presunta felicità dell’originario stato di natura contrapposta all’attuale disagio della civiltà.
Nonostante l’iniziale debito verso la biologia evoluzionistica nel definire l’inconscio collettivo di specie e gli archetipi, una deriva speculativa e metafisica parallela a quella freudiana, ma con accezioni più mistiche e spiritualistiche, si impadronisce anche dell’opera junghiana, secondo Orbecchi. L’immaginazione prende il sopravvento, la psicologia diventa narrazione mitologica e la cura torna nell’alveo arcaico della magia. Per contro, la visione darwiniana (se correttamente intesa e non edulcorata a piacimento) è incompatibile sia con il determinismo psichico freudiano sia con il finalismo junghiano.
Se queste sono le congetture speculative dei due in materia di evoluzione, brilla in controtendenza la figura di uno psicologo francese molto caro a Orbecchi, e troppo rapidamente rimosso: quel Pierre Janet che prima di Freud e Jung aveva concepito l’inconscio come una stratificazione di contenuti di coscienza momentaneamente non attingibili, e l’Io come un insieme dinamico di processi, puntando sul ruolo dei piccoli traumi infantili cumulativi come precursori delle sofferenze psicologiche e delle dissociazioni. Ipotesi, queste, che trovano invece conferme crescenti nelle neuroscienze.
L’analisi dei fraintendimenti evoluzionistici dei “padri fondatori”, e degli scadimenti antiscientifici di alcuni dei loro continuatori, non è fine a se stessa. Orbecchi la intercala con un’interessante pars construens, una nuova psicoterapia interdisciplinare che nasca dal basso, mai più chiusa in se stessa e privatizzata. Dall’eredità genetica alle influenze epigenetiche, dai processi emotivi di base ai percorsi di sviluppo, dall’accudimento nella prima infanzia all’ambiente familiare e alle esperienze di vita: i costituenti della nostra multiforme e spesso contraddittoria personalità sono strutturati a più livelli e non ha più senso, secondo l’autore, rincorrere vetuste dicotomie fra innato e acquisito, naturale e culturale. Siamo un impasto di molteplici istanze, con ragioni evolutive distinte e talvolta conflittuali (soprattutto in fatto di aggressività e cooperazione). A fronte di questo mosaico, la psicoterapia del futuro sarà una disciplina pluralista in cui convergeranno e si intrecceranno conoscenze diverse, per raggiungere l’obiettivo di sempre, la cura: spiegare in modo più plausibile i comportamenti umani e quindi intervenire più efficacemente per fare star meglio i pazienti. Quella di Orbecchi è una psicoterapia razionale basata sull’evidenza scientifica (l’evoluzione come “meta-teoria essenziale della psicologia”), ma che non perde la sua saggezza relazionale (ancora una volta preconizzata da Janet), nella consapevolezza di quanto sia difficile interagire con la confederazione di entità che costituiscono la mente.
In un’epoca di risorgenti occultismi, di irrazionalismo dilagante online, di cure fai-da-te per ogni malessere, al termine della lettura si finisce per augurarsi caldamente che gli epigoni più intelligenti delle scuole storiche di psicoterapia accolgano queste critiche di Orbecchi in modo costruttivo e si riaprano i giochi in un mondo troppo a lungo lacerato da conventicole in guerra. A tutto vantaggio degli psicoterapeuti stessi, ma ancor più di chi ha bisogno del loro aiuto.
Originariamente pubblicata su L’Indice, dicembre 2015, per gentile concessione
Fate il nostro gioco
Paolo Canova, Diego Rizzuto
Add editore, 2016
pp. 256, € 14,00
Recensione di Giuliana Galati
Raramente mi capita di leggere un saggio con la velocità di un romanzo. Avendo assistito più volte alle brillanti conferenze sulla matematica del gioco d’azzardo tenute dal duo Paolo Canova e Diego Rizzuto, ho intrapreso la lettura del loro primo libro abbastanza sicura che non mi avrebbe deluso. Fate il nostro gioco è un libro brillante, che vi farà entrare nei meccanismi matematici che regolano i vari tipi di gioco d’azzardo: roulette, lotto, SuperEnalotto, Win for Life, Gratta e vinci, blackjack, slot machine.
Una semplice – e unica! – formula matematica sarà la chiave per decifrare le vostre probabilità di vincita. Calcolare la probabilità di vincere, però, non è sufficiente: bisogna anche saper interpretare il risultato ottenuto, cosa non banale quando si tratta, per esempio, di numeri come 1/622.614.630. I due autori hanno trovato ottimi escamotage per dare un’idea di cosa significhino frazioni come questa e nel libro, ogni tanto, ci sono simpatici quiz o semplici esperimenti che aiutano chi legge a non perdersi durante il percorso e a “toccare con mano” i numeri con cui ha a che fare.
Ma questo libro non parla solo di statistica. Se dietro il gioco d’azzardo ci fossero esclusivamente semplici calcoli, gli italiani non vi spenderebbero tra gli 85 e i 90 miliardi di euro l’anno, un trend in continuo aumento: basti pensare che 10 anni fa i miliardi spesi erano “appena” 16. Significa che gli italiani, mediamente, neonati e ultracentenari compresi, giocano circa 1400 euro l’anno!
I meccanismi che spingono a giocare, rigiocare, e continuare ancora a giocare nonostante si sia in evidente perdita, sono numerosi. I due autori spiegano i trucchi utilizzati, per esempio, nei gratta e vinci, per far affezionare i giocatori facendo provare loro l’ebbrezza di piccole vincite ripetute, purtroppo insignificanti, o la frustrazione del near-miss ovvero la sensazione di aver perso per un pelo, la stessa che si prova quando nelle slot machine si hanno due simboli uguali su tre.
Non è l’unico modo: uno studio di psicologia dimostra che slot machine con sembianze più “umane” inducono le persone a a rimanervi incollate più a lungo e, di conseguenza, a perdere di più.
Quelli citati sono solo alcuni dei sistemi che chi progetta tali giochi adopera e che possono far cadere in trappola anche noi, se non li conosciamo.
In questo libro troverete non solo matematica e psicologia, ma anche tante storie. Storie incredibili di chi ha sconfitto il banco con ingegnosi metodi, di chi ha trovato falle nel sistema, di chi è stato protagonista di eventi apparentemente o realmente così improbabili da non crederci.
Quando ho iniziato a leggere Fate il nostro gioco credevo mi sarei trovata di fronte al solito saggio di argomento interessante ma con contenuti tutto sommato noti a chi ha già seguito un paio di conferenze sull’argomento e ha studiato statistica in qualche esame universitario. Invece, già dalle prime pagine, Paolo Canova e Diego Rizzuto sono riusciti a tenermi incollata al libro, grazie al loro inconfondibile stile frizzante e alla loro esperienza sul tema, che si arricchisce di contenuti sempre nuovi.
Intelligenza artificiale: le basi
Kevin Warwick
Dario Flaccovio Editore, 2015
pp. 283, € 24,00
Recensione di Gianpiero Negri
L'intelligenza artificiale è per voi una perfetta sconosciuta? O ne avete una vaga infarinatura e vi piacerebbe approfondirne alcuni aspetti? Se avete risposto sì ad una o ad entrambe le domande precedenti, Intelligenza Artificiale: le basi di Kevin Warvick è esattamente quello che fa per voi.
E, del resto, l’autore è di sicuro uno specialista nel campo, dal momento che insegna cibernetica all’Università di Reading, conducendo avanzate ricerche, appunto, nell’ambito dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni alla robotica e alle macchine.
Tuttavia, questa forte specializzazione non impedisce a Warvick di calarsi nei panni nel neofita, affrontando in successione le questioni che ogni interlocutore comune potrebbe porsi, e porre, su queste complesse tematiche, primo fra tutti l’enigma cruciale: che cos’è, davvero, l’intelligenza?
Piuttosto che concentrarsi su una definizione univoca, e, in molti casi, inevitabilmente influenzata dalle caratteristiche dell’intelligenza umana, lo studioso si spinge oltre, analizzando la questione da punti di vista molteplici, come, ad esempio, il ruolo e l’impatto dell’educazione di un individuo sullo sviluppo delle sue facoltà intellettive. Il lettore può quindi apprendere i fondamenti dell’approccio classico all’intelligenza artificiale, il cui scopo sostanziale è far sì che le macchine riproducano una specifica azione o compito che, quando svolti dall’uomo, vengono ritenuti “intelligenti”.
Prima di passare in rassegna gli sviluppi più recenti nel campo, l’autore ritorna poi sugli aspetti filosofici: Che cosa significa, davvero, pensare? Che cos’è davvero la coscienza? E, a questo punto, non potevano mancare i riferimenti (indiretti) a David Chalmers e (assai diretti) a Roger Penrose. L'autore de La mente cosciente viene infatti richiamato nella distinzione tra AI debole e forte, evidenziando i limiti dell’approccio classico. Una vera e propria autorità nel campo, ossia il Roger Penrose de La mente nuova dell’imperatore, viene invece chiamata in causa per contestarne veementemente una tesi, ritenuta da Warvick, senza mezzi termini, “ridicola”: quella secondo cui, dal momento che l’autentica intelligenza richiede capacità di comprensione, e che le macchine non saranno mai dotate di capacità reali di comprensione come quelle umane, di conseguenza non potrà mai essere concepita o costruita una macchina realmente intelligente.
Non può, naturalmente, mancare una sezione abbastanza ampia dedicata a un altro totem nell’ambito dell’intelligenza artificiale: il test di Turing. Le regole del gioco sono, ormai, note ai più: se un computer è in grado di trarre in inganno, con una certa frequenza, l’interrogatore, rendendosi indistinguibile da un essere umano, il test è superato. Basta questo, si chiede e ci chiede Warvick, per ritenere che il computer sia intelligente?
Passando a un altro tema assai attuale, ossia la complessa questione etica che riguarda lo sviluppo delle applicazioni robotiche, l’autore riprende anzitutto una pietra miliare della fantascienza, citata spesso (a proposito e sproposito), per indicare le linee guida di base nello sviluppo di automi che non danneggino l’uomo: le leggi della robotica di Asimov. Non manca un riferimento alla cosiddetta singolarità tecnologica: un punto ben preciso della storia in cui l’emergere della coscienza degli automi determinerà in modo ovvio la consapevolezza di avere il coltello dalla parte del manico nella relazione con il creatore umano. Viene pertanto chiamato in causa opportunamente quel Ray Kurzweil, autore di La singolarità è vicina – e, segnatamente, esponente di spicco del dipartimento ricerca e sviluppo di Google/Alphabet – in cui essa viene descritta come fenomeno emergente dagli avanzamenti in genetica, nanotecnologie e robotica.
Una tesi dibattutissima e assai criticata dal Future Of Life Institute, che annovera tra gli esponenti più autorevoli Francesca Rossi, docente italiana dell'università di Padova e key person di IBM nell'ambito della recente partnership per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale con gli altri colossi Facebook, Amazon, la stessa Google e Microsoft.
Chiusa la parentesi di carattere più speculativo e filosofico, Warvick apre la sezione dedicata agli sviluppi più recenti dell'intelligenza artificiale, chiarendo un aspetto fondamentale: al giorno d'oggi, in contrapposizione o, per meglio dire, in maniera complementare alle tecniche tradizionali, si sta affermando un nuovo approccio in cui si punta a costruire un vero e proprio artefatto costituito dai componenti elementari del cervello umano, i neuroni, o, almeno, di un loro modello artificiale, la cui struttura viene descritta con ottima sintesi dall'autore.
Nelle ultime due sezioni, dedicate a robot e percezione del mondo, Warvick affronta gli sviluppi più recenti, dall’embodiment della “mente artificiale” all'interno di un corpo fisico, ai sensi umani replicati in modo da fornire alle macchine un complesso di stimoli sensoriali che ne sollecitino l'evoluzione. Fino ad arrivare alla questione assai discussa, e problematica dal punto di vista etico, della creazione di colture di neuroni di animali o umani per realizzare le stesse infrastrutture di moderni sistemi artificiali ibridi. In definitiva, il saggio intercetta e descrive molti degli argomenti chiave dell'AI, e costituisce davvero un'ottima base per principianti desiderosi di avventurarsi in questo complesso e affascinante mondo. Anche perché, in maniera più che opportuna, Warvick conclude ogni sezione con riferimenti bibliografici ad opere che trattano con maggiore dettaglio tecnico ogni argomento specifico.
Naturalmente, e necessariamente, la nota dolente è la conseguente assenza di approfondimenti, che rendono il “costo per pagina” del saggio un po' troppo alto per il lettore medio, a cui è indirizzato. Che, però, può consolarsi con un simpatico gioco che Warvick propone nella terza sezione, che consiste nell'identificare, a partire da tre risposte di tono umoristico, gli altrettanti interlocutori: un uomo, una donna o una macchina. E, forse, la chiave di tutto è proprio questa: non far mai mancare, anche in questioni così complesse e dibattute, una buona dose di senso dell'umorismo, artificiale o no.
È la medicina, bellezza!
Silvia Bencivelli, Daniela Ovadia
Carocci, 2016
pp. 200, € 17,00
Recensione di Simone Raho
Interessante ed estremamente istruttivo, il libro di Silvia Bencivelli e Daniela Ovadia si contraddistingue per lucidità e chiarezza espositiva, senza trascurare il rigore scientifico. Si tratta di un libro che dovrebbe essere letto da chiunque sia interessato ad approfondire le complesse tematiche affrontate e a riflettere sul livello di affidabilità che la medicina odierna possiede. Allo stesso tempo, contiene una profonda analisi dei temi della salute e della comunicazione in campo medico. Parlare di medicina infatti, come ci spiegano le autrici, può essere a volte un compito difficile tanto quanto esercitarla, poiché ogni protagonista può avere in gioco degli interessi più o meno grandi. La corretta comunicazione in ambito medico svolge un ruolo cruciale: dovrebbe essere seria e basata sempre sui fatti, lontana dagli eccessivi proclami mediatici, lasciando da parte il tono sensazionalistico.
Di notevole interesse anche gli esempi che le autrici propongono per chiarire l’importanza dell’epidemiologia, fondamentale in campo medico ma i cui dati possono essere scorrettamente manipolati, magari per trarne un indebito beneficio.
Un libro avvincente e stimolante, che racconta storie di medicina e di clamorose bufale, con profonde riflessioni sul ruolo del giornalismo e dell’informazione scientifica.
Abbiamo avuto l’opportunità di rivolgere alcune domande alle autrici per approfondire alcune questioni emerse dalla lettura.
Nel vostro libro parlate spesso dell’importanza del giornalista scientifico e sottolineate allo stesso tempo le difficoltà di questo mestiere. Ritenete che oggi in Italia, almeno in determinati contesti, questa professione sia sottovalutata o non affrontata nella maniera giusta?
Bencivelli: Sì, un po’ sì. Le cose stanno cambiando, ma i giornalisti di altro tipo conoscono ancora poco i giornalisti scientifici e ne capiscono ancora poco la specificità. Tendono a pensare che, insomma, per intervistare uno scienziato che cosa ci vuole? E che verificare le notizie sia tutto sommato semplice: se è un’importante università o un’importante rivista a darle, non basta così? Peggio ancora il fronte opposto: chi si fida della scienza ufficiale?
Non solo. I giornalisti che non conoscono la scienza tendono a pensare che il giornalismo scientifico sia quello che descrive cose simili a fiabe, per un pubblico di ragazzini e di pensionati: il volo spaziale, l’animaletto buffo, la curiosità sui comportamenti umani, la meravigliosa scoperta che ci renderà tutti più sani.
D’altra parte anche gli stessi scienziati hanno spesso (ancora) un atteggiamento di sufficienza verso i giornalisti scientifici: li considerano gente che scrive e che parla al volgo di quello che avviene nei laboratori, rendendolo semplice e quindi superficiale. Oppure si aspettano che i giornalisti scientifici siano lì pronti a pendere dalle loro labbra.
Ma un giornalista scientifico non è un traduttore di cose difficili e fuori dal mondo, per gente curiosa che legge nel tempo libero. È un giornalista, prima di tutto. Un giornalista che trattando di scienza conosce metodi, meccanismi, regole, e anche storture, della scienza moderna e di chi la pratica.
Ovadia: Direi che si sottovaluta l’aspetto di indagine che è insito nel giornalismo e che deve esserci anche in quello scientifico: c’è poco spazio per un giornalismo che vada davvero a indagare l’impatto di una scoperta, la metodologia usata o gli interessi che vi sono dietro la scienza, come dietro qualsiasi attività umana. In un mondo in cui il dibattito è polarizzato anche nei confronti della scienza, il giornalista scientifico è “bravo” se racconta le magnifiche sorti e progressive ed è visto come pericoloso o addirittura antiscientista se qualche volta racconta le storture della scienza, e questo malgrado vi sia una vasta letteratura in comunicazione della scienza che dimostra come un approccio critico alle innovazioni le renda più comprensibili e accettabili per il grande pubblico e renda più difficile la polarizzazione di cui parlavo prima.
Poi c’è la sottovalutazione del ruolo da parte dei media: non ho ancora conosciuto un direttore di giornale (se non in qualche rivista specializzata) che richieda al giornalista scientifico lo stesso rigore e la stessa competenza che richiede in altri settori critici per la società, come nel caso dell’economia. Un direttore di quotidiano mi ha detto che se un suo giornalista scrive una cosa sbagliata su un’azienda quotata in borsa, nel giro di un’ora tutte le banche, le società finanziarie, eccetera, gli saltano alla giugulare, ma se scrive una stupidaggine scientifica non protesta nessuno, quindi non c’è ragione di affidare i pezzi di scienza a giornalisti competenti, che sono, ovviamente, anche più costosi.
Dalle storie raccontate nel vostro libro emerge l’importanza di due scienze tra loro correlate, la statistica e l’epidemiologia. Si tratta di materie affascinanti e ostiche allo stesso tempo: sappiamo bene che un dato statistico può essere interpretato in maniera differente in base ai dati correlati, magari per esigenze di marketing, contribuendo a una mistificazione dei fatti. Qual è il vostro parere al riguardo?
Bencivelli: La statistica è uno strumento, e quindi può essere usata bene o male, e può anche essere usata per indirizzare la notizia dalla parte che ci va. Noi che facciamo i giornalisti dobbiamo imparare a maneggiarla e a riconoscerne eventuali usi sbagliati. E comunque anche la statistica non basta. Con i numeri soltanto non si fa del buon giornalismo così come non si fa una buona medicina, secondo me.
Ovadia: Sono materie ostiche, ma direi che non puoi scrivere di scienza (e certamente non puoi scrivere di medicina) se non sei in grado di capirci qualcosa. Non serve avere una laurea scientifica, basta studiare per conto proprio e applicare le proprie conoscenze alle notizie che arrivano sulla scrivania e, magari, fare la domanda giusta all’esperto. Solo se conosci gli usi della statistica e i limiti degli studi epidemiologici quando devono essere tradotti in consigli per il singolo individuo riesci a individuare un utilizzo non corretto nello studio stesso o nel modo con cui quello studio è raccontato, magari nel comunicato stampa.
Tra l’altro ci sono interessanti esperimenti di “data visualization” che cercano di rendere le statistiche e i dati epidemiologici comprensibili in modo intuitivo anche al pubblico generalista grazie ad artifici grafici. La grafica è una parte importante del giornalismo moderno e uno strumento interessante per comunicare un risultato ostico.
Il “caso Stamina”, ben documentato in un capitolo del libro, ha messo in evidenza il rapporto conflittuale che esiste a volte tra scienza e giustizia. È già accaduto in passato (si veda il “metodo Di Bella”), così come accade talvolta ancor oggi (si veda per esempio il caso Xylella e ulivi nel Salento). È solo un problema di comunicazione tra mondi differenti o secondo voi c’è dell’altro?
Bencivelli: Esempi di fraintendimento della scienza da parte dei giudici ce ne sono tanti. Per me è anche una dimostrazione lampante del fatto che la scienza è dappertutto e non è solo una cosa che si fa tra scienziati, ma ha ricadute sociali importanti e delicate, talvolta conflittuali. Non credo che ci “sia dell’altro” nel senso di disegni misteriosi. Più probabilmente si tratta di ignoranza, di senso del potere e di quella cosa molto umana per cui tendiamo a vedere solo quello che ci piace e a credere solo a quello che conferma le idee che abbiamo già. E siccome i giudici sono umani, ci cascano come tutti. Pericoloso...
Ovadia: Mi occupo del rapporto tra scienza e legge da molti anni e ho imparato una cosa: esiste un principio sacrosanto per cui la legge (e i giudici) sono al di sopra di tutti gli altri “poteri” e totalmente autonomi nel prendere le loro decisioni. È importante che sia così perché la loro autonomia è uno strumento di garanzia democratica, che si è evoluto nel diritto per evitare che chi amministra la giustizia possa essere sottoposto a pressioni esterne.
Ma questo principio ha un lato oscuro, come la democrazia stessa: è necessario, ma richiede da parte di chi amministra la giustizia la modestia di attenersi ai fatti e di selezionare con estrema cura i periti e gli esperti a cui fare riferimento. Nel diritto anglosassone esiste un principio, chiamato “principio di Daubert” da un famoso caso statunitense, che stabilisce che una prova scientifica, per essere ammessa in tribunale, debba essere ritenuta valida, nel metodo e nelle conclusioni, dalla maggioranza della comunità di riferimento, cioè dagli scienziati stessi. In Italia non abbiamo una norma analoga e i giudici possono chiamare come perito chiunque ritengano utile a loro insindacabile giudizio. Se sommiamo a questa lacuna giuridica il fatto che i giudici sanno pochissimo di scienza, comprendiamo perché emergono i casi che citi. Ma i correttivi devono essere di tipo giuridico, come ho detto: è molto pericoloso affermare, come spesso si sente fare da parte degli scienziati per comprensibile reazione, che i giudici non hanno competenza nel giudicare le questioni scientifiche, perché vorrebbe dire che la scienza si pone al di sopra dei meccanismi della democrazia (sì, lo so che recentemente un famoso medico ha detto che “la scienza non è democratica”, ma invece di applaudirlo avremmo dovuto preoccuparci della deriva autoritaria, a meno di non auspicare una sorta di Repubblica di Platone in cui è la scienza a governarci).
Leggendo il vostro libro sono rimasto colpito da questa frase: «Lo scienziato italiano medio non ha nessuna preparazione in comunicazione.» Secondo la vostra esperienza, è un problema solo italiano oppure è un problema più generale, che riguarda un po’ tutto il mondo scientifico?
Bencivelli: Italiano molto. Forse nel Regno Unito sono più attenti, ma comunque temo che anche altri paesi europei non siano messi poi meglio di noi (non sono un’esterofila!). In Italia può darsi che scontiamo anche un po’ di antiche abitudini baronali.
Certo è che le principali bufale scientifiche degli ultimi anni sono nate un po’ ovunque: Francia, Inghilterra, Germania... nessuno ne è immune.
Ovadia: In altri Paesi le cose sono cambiate già da qualche anno e i corsi di comunicazione della scienza o, più semplicemente, i “media training” sono diventati parte integrante della formazione della maggior parte degli scienziati, sia nell’accademia sia nella ricerca privata. Nel mondo anglosassone, poi, la comunicazione ha un grosso peso anche nel rating delle istituzioni accademiche e questo rende lo scienziato medio più consapevole dell’importanza dell’argomento.
Dopodiché lo scienziato non deve diventare un comunicatore o un giornalista, sono mestieri diversi: deve imparare però a interagire con essi nel modo corretto e anche a interagire col pubblico in modo corretto, se vuole partecipare a dibattiti e conferenze.
Negli ultimi anni sui media si intravede sempre di più quella che per certi versi può essere definita una “spettacolarizzazione della scienza”, e anche voi sottolineate l’eccesso di enfasi con cui alcuni giornalisti riportano le novità scientifiche, soprattutto quelle di frontiera. Quali sono i rischi correlati con questo approccio?
Bencivelli: A me che la scienza diventi spettacolo non dispiace in assoluto. Ci sono spettacoli scientifici che sono andati molto bene e che sono corretti ed efficaci. Altra cosa è l’enfasi da “recente scoperta” e da “novità che cambia le nostre vite”. I rischi sono soprattutto la perdita di credibilità del sistema. E poi ci sono i rischi per le famiglie di persone coinvolte nel problema in discussione, che potrebbero convincersi a finire nelle mani di ciarlatani (vedi i venditori di speranze staminali). Ma di questi rischi gli scienziati sono corresponsabili. La buona comunicazione si fa con la collaborazione di tanti.
Ovadia: La scienza è anche intrattenimento: se ti diverti, finisce che ti informi (e magari impari qualcosa di nuovo) senza annoiarti.
Un articolo perfetto dal punto di vista formale e scientifico, ma così noioso che nessuno lo legge, è un’occasione persa, come cerco spesso di spiegare agli scienziati che magari fanno le pulci alle metafore con cui cerco di spiegare aspetti complessi della loro sperimentazione.
Sono capace anch’io di scrivere come per una rivista “peer-reviewed”, ma se vado sul Corriere della Sera voglio essere interessante anche per mia nonna, che non comprende certi termini e non è neanche così interessata all’argomento da andarseli a cercare sul vocabolario.
L’importante è che il messaggio nel suo complesso sia corretto, che la notizia sia riportata in tutti i suoi aspetti (anche quelli controversi), che la gente capisca perché quella scoperta è un passo avanti per l’umanità (o un potenziale rischio, capita anche quello).
Detto ciò, credo che si debba condannare fermamente l’enfasi non giustificata, che però viene anche dallo scienziato, dal suo ufficio stampa o dalla casa farmaceutica che vuole vendere più scatole di un nuovo farmaco.
Il caso Stamina, per dire, è certamente frutto di un cattivo giornalismo ma anche di tutte le dichiarazioni roboanti di grandi scienziati in cerca di fondi che per anni hanno promesso che le staminali sarebbero state la panacea di tutti i mali e che la soluzione era lì, dietro l’angolo.